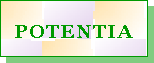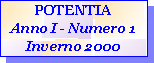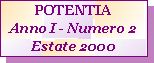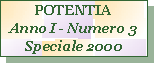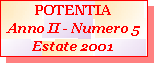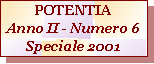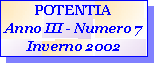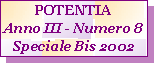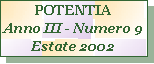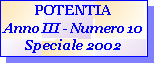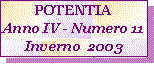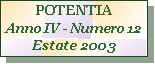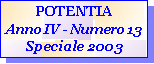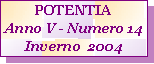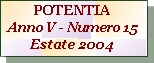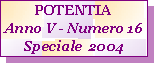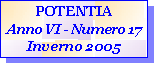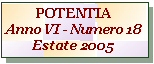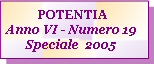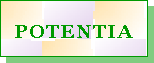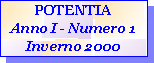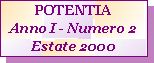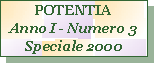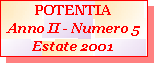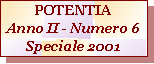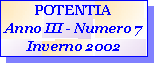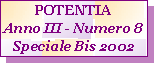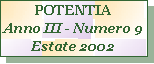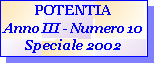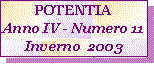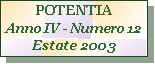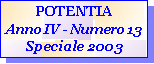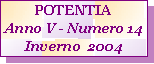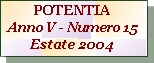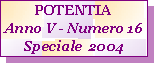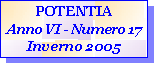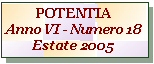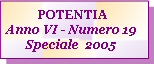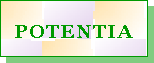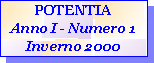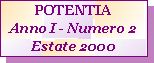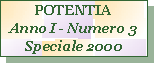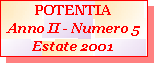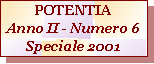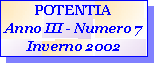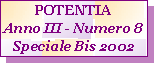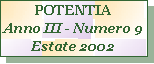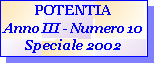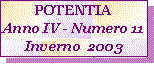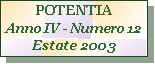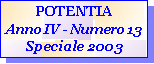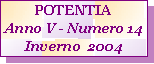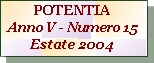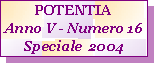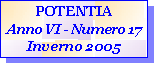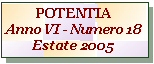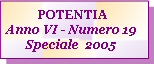| |
|
Presentazione
Con questo quarto numero di Potentia –
Archivi di Porto Recanati e dintorni apriamo l’anno 2001, che
speriamo sia ricco di soddisfazioni per i lettori tutti e i concittadini.
La nostra rivista, e di ciò siamo grati a quanti vi collaborano e la
sostengono, trova sempre maggiori consensi e con loro, i consensi,
arrivano pure consigli e suggerimenti sui quali assicuro il massimo dell’attenzione
del comitato di redazione.
Ma ci piacerebbe che, oltre i consigli e i suggerimenti, sempre assai
graditi (anzi, richiesti), la partecipazione si concretizzi in interventi
e contributi che in molti, al Porto e nelle località vicine, sono certo
in grado di fornire con competenza e capacità critica.
Come si potrà constatare dalle firme degli autori dei vari articoli, la
rivista comincia a far conto su diverse collaborazioni; intendiamo
proseguire su questa strada e dare spazi sempre maggiori ai tanti che
hanno cose interessanti da proporre: il nostro scopo è creare un punto di
riferimento costante per chi ha capito che occuparsi della materia di cui
si tratta in queste pagine non è roba minore, indegna di cervelli
che forse si credono destinati a dominare le scene della critica storica o
dell’arte o della letteratura.
Come che sia, noi siamo sempre qui, in via degli Orti 57 (tel. 071/9797374
e 0333/4304172), in una sede che è più che degna di accogliere il Csp,
pronti a fare quanto sappiamo e possiamo e pronti soprattutto a prendere,
ad accettare dagli altri i tesori della loro esperienza e delle
loro conoscenze.
Porto Recanati, inverno
2001
Il Direttore

|
| |
|
Nascita
e morte del mercato ittico (di
Lino Palanca)
Il primo mercato ittico di cui si ha notizia, agli
inizi del XIX secolo, era situato nella prima fila di case del lungomare
di Castelnuovo, quindi nella zona nord del centro urbano.
Non ne abbiamo trovato l’esatta ubicazione, ma sappiamo che doveva
essere così perché ce ne è traccia in diversi documenti relativi alla
lite tra i Comuni di Recanati e del Porto, che durò dal 1893 al 1907, a
proposito del pagamento alla ditta che aveva effettuato certe opere di
difesa a mare (Carte del C.S.P.).
Altre indicazioni in tal senso si trovano nelle delibere consiliari dell’epoca,
conservate negli uffici comunali, grazie alla sollecitudine di Anna
Bacchiocchi. E’ a questi documenti che faremo riferimento per riferire
sulle vicende del mercato ittico di Porto Recanati.
Nel 1874 una mareggiata ciclopica distrusse l’edificio in riva al mare.
Si cominciò a parlare della sua ricostruzione appena in tempo per
assistere, cinque anni dopo, al crollo di tutte le abitazioni antistanti
la spiaggia di Castelnuovo salvatesi nel ‘74; ancora adesso è ben
visibile l’enorme ferita causata dal mare in quella parte della città.
Ci vollero undici anni e una lunga serie di progetti assunti, bocciati,
riassunti e ribocciati, ma nel 1885, finalmente, fu collaudata e
inaugurata la nuova pescheria. Le idee, anche un po’ balzane, non erano
davvero mancate: c’era chi voleva il mercato nell’orto dei Missionari
(attuale Oratorio Salesiano), chi in via Leopardi, chi addirittura nel
posto dov’era il vecchio edificio. Alla fine prevalse la proposta del
consigliere Giovanni Volpini, che fin dall’inizio aveva insistito per
piazza Castello (oggi Brancondi).
Dal 1885 al 1893, però, il mercato era costituito soltanto dal corpo di
fabbrica centrale; i due corpi laterali, i magazzini, vennero realizzati
un po’ alla volta dalla giunta del nuovo Comune, coordinata dal sindaco
Enrico Volpini.
Della pescheria si parla pochino nei documenti e nelle delibere che
abbiamo potuto visionare, fino agli anni della prima guerra mondiale: nel
maggio 1898 si esamina il progetto dell’ingegner Mariano Menini per la
pavimentazione del piazzale esterno; nel febbraio 1902 l’affitto di un
magazzino costava ancora 30 lire l’anno, come stabilito nel 1896; nel
dicembre 1907 si ordina la costruzione di tre nuovi magazzini (ancora
progetto Menini per un costo di 3645 lire); nel 1909 si aumenta il canone
di affitto a 51, 81 lire per i magazzini di 24,08 metri q. mentre per
quelli di 17,20 metri q. si pagheranno 36,85 lire.
L’argomento mercato ittico diventa invece uno tra i più presenti nelle
discussioni consiliari e nelle decisioni della giunta a partire dal 1917.
Come noto, siamo in guerra da un paio d’anni; in aprile il Comune fa
sapere che tutto il prodotto delle nasse deve essere portato nei magazzini
dei negozianti di pesce "siti nella pescheria, e in quello
comunale ivi, onde possa aver luogo la vendita al minuto nella pescheria
stessa dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 16 alle 18"(atti
della giunta). Prezzo massimo di vendita al minuto delle seppie
e dei polpi, da vendere interi, è di 1,20 lire il kg.
Nel ’17 operavano 18 sciabiche: si ordina che seppie e polpi siano
requisiti per i bisogni locali in ragione di 4 kg per sciabica, 1 kg per
ogni 50 nasse, 3 kg per ogni negoziante di pesce. In totale si avranno 139
kg al giorno.
In giugno il Comune osserva che la gran parte del pescato è esportata e
che ben poca roba resta per il consumo locale "a prezzi
elevatissimi" (ibidem);
urge un prezzo equo per una maggiore quantità di pesce per la
popolazione: ci vorranno almeno 30 kg di pesce di prima qualità, 50 di
seconda e 100 di terza. La commissione all’annona (Giovanni Ridolfi,
Vincenzo Giri di Andrea, Giannetto Cittadini e Ivo Baggioni) propone che
il Comune requisisca ogni giorno il prodotto di due delle 18 sciabiche
pagando 2,10 lire il kg per il pescato di prima qualità (roscioli,
occhiatine, mezze seppie, merluzzi, mugelle, calamari, alici, guatti,
sfoglie, teste grosse); 1,20 lire per la seconda qualità (sgombri, agore,
sarde, baraccole, chieppe, ragni, bobboline o mindole, zanghette, polpi,
pannocchie, seppie, mezzi sardoncini e mezze testoline); lire 0,50 per la
terza (tremole, papalina, lattarina e mazzolinelle). L’incarico del
controllo viene affidato a un dipendente comunale, che deve stare con le
sciabiche per tutto il tempo di pesca e poi far trasportare il prodotto in
pescheria per venderlo.
Figuriamoci.
Il sistema non funziona. E allora si cambia il modo della requisizione. Ad
ogni proprietario si tolgono 2 kg di pesce di prima qualità, 3 di seconda
e 5 di terza dalla prima pescata della mattina e poi di seguito fino a
raggiungere le quote stabilite. Ma sono i "conduttori di
sciabiche" che dovrebbero portare il pesce in pescheria all’incaricato.
Figuriamoci anche qui.
Infatti, già in luglio, si osserva che proprietari e
conduttori di sciabiche riescono a evitare con facilità di rispettare gli
obblighi assunti. Ne prendono atto anche i sindaci dei comuni costieri (da
Porto Recanati verso sud, fino a Castellammare Adriatico) che il 25 marzo
1918 si riuniscono a Porto San Giorgio nel tentativo di disciplinare il
commercio e la vendita del pesce.
Si aggrava la "crisi carnea" (ibidem),
osservano, e si prevede che, a causa delle necessità militari, il pesce
sarà scarso nella stagione prossima anche perché non si può
disciplinare l’anarchia dei pescatori. L’unico sistema sarebbe la
requisizione generale del pesce a prezzi che soddisfino produttori e
consumatori.
I sindaci, alla fine, decidono per questa utopia e danno incarico al
collega ospite, Luigi Bronzi, di stabilire una tariffa di prezzi massimi
per le diverse qualità.
E così si va avanti, tra vani tentativi di imporre regole e calmieri,
fino al dicembre del 1918, e siamo nell’immediato dopoguerra, quando si
estende la requisizione dalle sciabiche alle barche a vela, che ora hanno
ripreso l’attività interrotta dagli eventi bellici (intanto, essendo
inverno, le sciabiche non pescano). Le lancette sono 50 e ogni
proprietario dovrebbe fornire 2 quintali di pesce di prima qualità e due
di seconda.
Manco a dirlo, come era nelle previsioni, i risultati sono scarsi.
Nel ’19 si aumenta il canone di affitto annuo dei magazzini della
pescheria da 33 a 55 lire per quelli sotto le tettoie laterali e da 30 a
50 per i centrali. La relativa delibera di giunta ci permette di conoscere
l’elenco degli affittuari, che sono: Pasquale Cesari fu Giacomo, Damiano
Feliciotti fu Guglielmo, Luigi Castelli fu Leandro, Maria Bugiolacchi
vedova Grilli, Nazzareno Feliciotti fu Giacomo, Vincenzo Cittadini fu
Angelo, Carlo Giri fu Andrea, Giannetto Cittadini fu Angelo, Alessandro
Giri fu Andrea, Vincenzo Giri fu Andrea, Francesco Cittadini fu Fortunato,
Antonio Giorgetti fu Isidoro, Giuseppe Cittadini fu Giovanni, Antonio
Cesari fu Luigi.
Col fascismo la categoria venne inquadrata nei ranghi
del sindacato fascista pescatori, che qui da noi aveva anche creato una
Casa del pescatore, ulteriore strumento di controllo delle attività
marinare.
Il 17 febbraio 1926, il commissario prefettizio Giuseppe Volpini
interviene sul dazio del pesce fresco per diminuirne la tariffa, in vigore
dal primo gennaio di quell’anno, di 5 lire, da 20 a 15.
Sono troppe 20 lire, argomenta il commissario, anche perché il
quantitativo di pesce soggetto a dazio "è notevolmente maggiore
di quello preventivato, motivo per cui l’esazione del dazio su questa
voce supererà sensibilmente la previsione" (delibere
commissariali).
Il pesce proveniente per via di terra da spiagge vicine è naturalmente
anch’esso soggetto a dazio; in questo caso la riduzione decisa da
Volpini è drastica; si va da 20 a 5 lire "..e di ciò non se ne
duole la classe marinara locale, perché essa non ne risentirebbe mai la
concorrenza, come ha espressamente dichiarato una loro commissione
interpellata" (ibidem). Bah!
Nel novembre 1927 viene fornito un nuovo elenco degli affittuari dei
magazzini della pescheria, questa volta comprensivo dell’ammontare degli
affitti annui pagati, che metto in parentesi: Giuseppe Cittadini (lire
130), Damiano Feliciotti (130), Giacomo Grilli (130), Giuseppe Cittadini
(150), Giuseppe Cittadini (150), Nazzareno Feliciotti (150), Nazzareno
Feliciotti (150), Vincenzo Cittadini (280), Carlo Giri (215), Giannetto
Cittadini (215), Alessandro Giri (150), Alessandro Giri (150), Vincenzo
Giri (150), Vincenzo Giri (150), Pasqualina Cittadini (130), Antonio
Giorgetti (130), Elisa Giri (115), Vincenzo Doffo (115), Stamira Giri
(130). I magazzini affittati sono 19, le quote di affitto si pagano
semestralmente entro il 10 gennaio e il 10 luglio; eventuali aumenti del
canone devono essere comunicati entro il primo ottobre.
Alla fine di maggio del 1928 si comincia a parlare
della nuova pescheria.
Lo fa il podestà Antonio Fabbri, un avvocato di Roma, calato al Porto nel
marzo precedente, una persona che ha certamente lavorato bene per la
nostra comunità. Appena qui, si rende conto che i magazzini in piazza
Umberto I° sono ormai decrepiti e antigienici (eppure avevano solo 43
anni!) e che bisogna farne di nuovi altrove.
Si sceglie la località dove dovrebbe sorgere il porto, cioè a nord dell’abitato,
presso il fosso Fiumarella, che nel frattempo è stato ricoperto con un’importante
opera in cemento armato "Tutto il dorsale del manufatto che
ricopre il torrente –scrive Fabbri- lungo mt 29,60 e largo mt
6,20 può essere usato molto convenientemente a sostegno del corpo
principale dei magazzini. A fianco di esso, in senso obliquo, sul lato
sinistro del prolungamento della via Castelnuovo, sorgerà un secondo
corpo, contenente tre magazzini più piccoli. I primi potranno essere
ceduti in affitto ai negozianti di pesce che esercitano il commercio all’ingrosso;
gli altri tre più piccoli serviranno ai pescivendoli che esercitano il
traffico al minuto, sia in paese che nei comuni limitrofi. L’ampio
piazzale che li fronteggia, tra le vie Castelnuovo e Monteconero,
convenientemente pavimentato per il facile ed abbondante lavaggio, sarà
il naturale mercato all’ingrosso del prodotto della pesca, molto comodo
perché a pochi passi dal mare" (delibere
podestarili).
Da rilevare che il progettista (costo previsto, 55 mila lire) era il
geometra Dante Santucci, che ricopriva pure la carica di segretario
generale del comune. Altri tempi, senza polemiche sui conflitti di
interesse.
Il 31 ottobre ’29 i lavori sarebbero finiti, comprese due latrine e due
orinatoi, se non che ci si accorge che il numero dei magazzini non è per
niente sufficiente ai bisogni dei commercianti e perciò si incarica la
ditta Giuseppe Cingolani di farne altri cinque (costo 20 mila lire) entro
l’anno: tempi rispettati, dato che il collaudo avviene il 28 dicembre ad
opera dell’ingegner Giovanni Volpini.
E giunge il gran giorno dell’inaugurazione, il 15
maggio 1930, data alla quale, però, comincia a incombere il pensiero di
che cosa fare dell’ingombrante vecchio mercato. Ma questa è una storia
che racconteremo un’altra volta.
Due anni prima, nell’agosto del ’28, era stato promulgato dal podestà
il nuovo regolamento del mercato ittico.
Vi si stabiliva che il pesce poteva essere venduto solo al mercato (ogni
giorno, escluse le feste tradizionali), che l’astatore era nominato per
un anno, inappellabilmente, dal podestà udito il rappresentante
sindacale. Rivenditori e acquirenti sono obbligati a possedere licenze
rilasciate dal Comune. Rigorose le norme sulla pulizia e l’igiene, con
multe da 20 a 40 lire fino all’inibizione dell’ingresso al mercato per
gli inosservanti.
Sull’importo lordo delle derrate gravano alcune percentuali: il 2% per
la cassa mutua, la percentuale per l’astatore secondo l’offerta di
questi nella domanda prodotta per la nomina, l’1% di abbuono sul peso, l’1%
a favore del comune per spese di direzione, forniture pesi, stampe etcc,
lire 2 al q.le per il diritto di pesatura più le imposte del dazio
consumo.
Articolo 29: "Le contrattazioni debbono essere
seguite sempre ed in ogni caso per contanti in lire e centesimi secondo il
sistema metrico decimale, evitando l’uso di frasi e parole di
gergo" (ibidem).
Pesatore e direttore sono anch’essi nominati dal podestà; quest’ultimo
esercita la polizia del mercato, coadiuvato da agenti comunali e,
eventualmente, dalla forza pubblica; l’ufficiale sanitario o suoi
delegati sono incaricati della vigilanza sanitaria.
I venditori locali al minuto (siamo ai cariòli) devono avere
sempre con loro il tesserino dove possono pure segnare l’eventuale
nomignolo; avranno anche un tagliando con indicata la percentuale di
maggiorazione che il rivenditore può applicare al prezzo all’ingrosso.
Sulle derrate ci vogliono i cartellini dei prezzi
A integrazione del regolamento comunale viene varato (maggio 1930) quello
per l’affitto dei magazzini. Questi sono concessi a commercianti all’ingrosso
e rivenditori al minuto, a domanda; durata dell’affitto, un anno a
partire dal primo luglio; obbligo agli affittuari di garantire pulizia e
igiene dei magazzini, al cui interno non si possono portare modifiche
senza approvazione del comune. Canone affitti annui: i magazzini n°
1-2-3-4 lire 500; il n° 5 lire 1000; i numeri 6-7-8-9-10 lire 700; i
numeri 12 e 13 lire 400.
Buone notizie alla fine del ’32 per il canone di
affitto dei magazzini; è ridotto del 50% in considerazione della critica
situazione nazionale e anche perché il Comune è venuto meno a uno dei
suoi principali impegni circa il mercato (e lo riconosce, il che non è
poco), vale a dire l’installazione dell’elettropompa per aspirare l’acqua
del mare con successivo utilizzo in pescheria.
Intanto, già il 12 luglio 1930 era stato nominato il primo astatore
ufficiale della storia del mercato: si trattava di Luigi Caporaletti,
morto però nel novembre ’32 e rimpiazzato temporaneamente da Francesco
Castelli, la cui condotta in servizio non è giudicata soddisfacente dal
podestà.
E’ perciò che si ricorre a un’altra nomina provvisoria affidando l’incarico
a Giovanni Giri.
Ci sono problemi per la gestione, nel senso che si stenta ad individuare
il soggetto che deve assumersela in maniera diretta; non può, il
podestà, tenere dietro anche alle questioni relative al mercato del
pesce, anche perché, come qui sappiamo bene, tali questioni toccano una
categoria niente affatto propensa a troppi accomodamenti di tipo
diplomatico.
Allora, il 17 aprile 1933 si decide che sarà la Casa del pescatore ad
occuparsi del normale funzionamento del mercato, fermo restando che le
nomine del direttore, dell’astatore e del pesatore competeranno sempre
all’Amministrazione comunale.
Nell’agosto successivo si nomina una commissione, presieduta dal
podestà; suppongo che la sua costituzione sia stata concordata con la
direzione della Casa del pescatore, se non da questa direttamente
suggerita.
Ne fanno parte Biagio Castellani in rappresentanza dei proprietari di
barche, Nicola Solazzi e Pasquale Borini per i pescatori, Lucidio
Feliciotti per i commercianti; vi sono ammessi, con voto consultivo, i
direttori del mercato e della Casa del pescatore.
Nel giugno 1934, però, il Comune riassume in proprio la gestione
revocando la delibera con la quale la gestione stessa era stata affidata
alla Casa del pescatore: la prefettura non aveva ritenuto legittima la
decisione del podestà e poi ci sono un po’ di guai con il personale.
Il fatto è che i dipendenti assegnati alla pescheria disciplinarmente
sarebbero soggetti al Comune, ma per tutto il resto dovrebbero dipendere
dalla Casa del pescatore, il che comporta inevitabili diversità di
interpretazione di questo o quel punto del regolamento, conflitti di
competenza tra gli enti coinvolti e, insomma, una disdicevole confusione.
Alla fine di agosto si arriva alla seguente conclusione: anche la
disciplina del personale sarà di spettanza della Casa del pescatore,
così come l’ordinamento generale del mercato. Il tutto, sotto il
controllo del Comune.
A noi pare che in tal modo si sia soltanto girato
intorno al problema.
Ma non solo a noi, anche alla prefettura di Macerata, che interviene di
nuovo per dichiarare illegale la delibera in quanto, in fatto di
disciplina, il personale non può che dipendere dal comune.
E così è stato anche per gli anni a seguire.
Il primo direttore del mercato ittico fu Giorgio Sandiford, nominato il 2
marzo del 1931 da una commissione formata allo scopo di individuare la
persona adatta al compito: non conosciamo niente di Sandiford né, almeno
al momento, siamo riusciti a sapere qualche cosa dai concittadini anziani
che abbiamo interpellato.
Continueremo a cercare sperando di avere migliore fortuna in futuro.
La direzione di Sandiford durò poco più di un anno;
il 4 giugno ’32, infatti, il direttore si dimetterà, sostituito in via
provvisoria da Teodosio Salvioni.
Costui era capoguardia fin dal 1912, quando aveva partecipato al concorso
indetto dal podestà per rimpiazzare Gustavo Abbruzzetti, nominato
ispettore di polizia urbana in Osimo, spuntandola sugli altri dodici
concorrenti.
Salvioni lavorava a quell’epoca come guardia municipale a Urbino; il suo
ricordo è ancora ben vivo in tanti portorecanatesi avendo egli svolto il
suo servizio fin dopo la seconda guerra mondiale.
Per di più, il figlio Medardo, giornalista, era ben conosciuto e stimato
in città.
Non abbiamo trovato la data esatta della nomina del successore di
Sandiford, Arnaldo Ramadori; sappiamo comunque che nell’aprile del 1936
venne nominato al suo posto, per un periodo di tre mesi, Virgilio
Cancellieri.
Era successo che Ramadori aveva pensato di arruolarsi volontario nelle
camicie nere; essendo il ’36 l’anno dello scoppio della guerra civile
in Spagna, c’è da supporre che sia andato con i suoi commilitoni a
combattere i rossi che difendevano la Repubblica Spagnola dal colpo di
Stato del generale Francisco Franco.
Tornato dalle imprese iberiche, Ramadori riprese l’incarico tenendolo
fino al 16 marzo 1937, giorno delle sue definitive dimissioni e dell’entrata
in servizio, sempre in via temporanea, di Dino Pierantoni.
Il servizio di cassa dal Credito Adriatico passò in quel periodo alla
filiale della Banca Nazionale del Lavoro (che lo conservò e svolse fino
all’immediato dopoguerra).
La Bnl, in conformità alla legge, garantiva la presenza di un ufficio
cassa dentro il mercato, ciò che il Credito Adriatico, invece, non era in
grado di fare; ecco perché fu scelta la Bnl.
Per tornare ai nostri direttori, questa volta la provvisorietà fu davvero
tale; infatti, un mese dopo, il 24 aprile 1937, fu nominato direttore
Guglielmo Feliciotti, che lo fu per trent’anni, fino alla metà degli
anni Sessanta.
Guglielmo era fratello di Lucidio, che abbiamo citato prima (agosto 1933)
quale componente della commissione per la gestione del mercato ittico e
che sarà membro autorevole del Comitato di Liberazione Nazionale di Porto
Recanati nonché sindaco nel 1959/’60.
Guglielmo Feliciotti accompagnò dunque la vita del mercato attraverso la
guerra, i problemi della ricostruzione, il boom economico e le prime
avvisaglie della crisi successiva; sempre dando prova di competenza
professionale, precisione e, quando occorresse, decisione nel far
rispettare i regolamenti.
Fatti i conti, la struttura di via Castelnuovo, di recente abbattuta, è
stata in piedi settant’anni per sessanta dei quali ha garantito un
servizio essenziale, un tempo, per l’economia cittadina. Nella primavera
del 1990, a ridosso delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale,
fu inaugurato il nuovo mercato ittico, tra squilli di trombe e promesse di
brillante avvenire.
E’ finita come sappiamo, nel modo più triste
possibile. Al solito, la colpa della chiusura del mercato non è di
nessuno, c’è sempre un provvidenziale destino crudele che si incarica
di coprire incapacità e incompetenze; resta il fatto, indiscutibile, che
il mercato non c’è più.

|
| |
|
Un
convento di frati polacchi
Il concittadino che ha scoperto l’esistenza del
convento di frati, di cui si tratterà nel contributo che segue, non vuole
sia conosciuta la sua identità. Una scelta che rispettiamo.
Il convento sorgeva in contrada Bella Luce, tra la villa Gigli e il vicino
complesso turistico, su lato sinistro della strada, direzione Recanati.
La mia è stata una scoperta casuale; mai e poi mai
avrei pensato alla esistenza, un tempo, di un convento da quella parti, e
per giunta di frati polacchi. Stavo facendo del footing, da solo, quando
un tardo pomeriggio d’estate ho incontrato un anziano contadino che,
trascinando il suo passo stanco, se ne ritornava a casa conducendo davanti
qualche pecora.
Un saluto in fretta, qualche battuta d’occasione, e poi –non ricordo
come- quel vergaro (Eugenio Cupido) m’incomincia a raccontare che lì,
nella sua casa, nei secoli scorsi eran vissuti frati polacchi.
Mi faccio subito condurre a visitarla, anche se lì per lì rimango un po’
scettico che lassù sia esistito davvero un convento di religiosi
provenienti da un paese tanto lontano.
Vicino, però, c’è il santuario della madonna, della quale i polacchi
sono notoriamente devotissimi: Totus tuus è il motto di papa
Giovanni Paolo II; la Vergine di Czestochowa è la gran protettrice della
nazione; a porta Marina di Loreto v’è un istituto di suore polacche; e
poi la struttura dell’edificio, che nella parte esteriore conserva
intatta l’originaria forma conventuale; tutto spinge a credere che il
vecchio parla con verità.
E mentre il piccolo cane nero da guardia mi scodinzola di qua e di là
abbaiando felice a lingua sciolta, lì sull’aia ai piedi della grossa
scalinata che conduce alla loggetta, mi fermo ad ascoltar volentieri il
racconto di quell’uomo che, pur essendo vicino all’ottantina, mi
colpiva per la freschezza dei ricordi e l’agilità della mente.
Fino alla battaglia di Castelfidardo del 1860, in quella che adesso è la
sua abitazione c’era, dunque, un convento di frati polacchi, che
possedevano 56 ettari di terra qui attorno, avendo alle dipendenze quattro
o cinque famiglie di contadini; ne ricorda ancora quattro: Testasecca,
Guazzaroni, Lavini soprannominato Ciuccò, e Lana.
La vittoria di Cialdini significò la fine della dominazione papalina
nelle marche e altrove; per cui anche i nostri frati dovettero abbandonare
il convento e riparare a Roma.
Affidarono l’amministrazione dei loro possedimenti ad un lato prelato
recanatese, il quale per un certo periodo ha mandato ai frati uno scudo
all’ettaro ogni fine d’anno. Poi, con un atto arbitrario, se l’è
appropriati intestando i terreni a un suo nipote come dono di cresima. E’
chiaro che è sorta una lite giuridica, durata di sicuro fino alla fine
della seconda guerra mondiale.
Un tempo continua nel racconto Cupido, prima di diventar convento, questa
casa serviva da vedetta alla città di Recanati contro le incursioni dei
pirati, perché da quassù gli avvistamenti delle navi nemiche avevano un
raggio molto più ampio, che non dalla torre del Porto (ed anche questo,
penso tra me, era molto probabile perché da lì Recanati la si vede
vicinissima in tutta la sua figura a schiena d’asino).
Era, ed è tuttora conosciuta fra i contadini locali come la casa del
pozzo cupo; e mi indica lì accanto il vecchio pozzo, apparentemente
ancora ben mantenuto nella sua struttura ad arcata di mattoni..
Mi alzo perché voglio vederlo da vicino, osservarne la profondità, la
quale, spiega con il suo sorriso sempre bonario Cupido, arriva ad una
decina di canne; e siccome una canna corrisponde a circa tre metri, il
pozzo misura 30/35 metri.
E dando pure una lezione di filologia, aggiunge: "cupo vuol dire
profondo; se infatti uno dice, in dialetto: sa fossa è troppo in cima
(quella buca è poco profonda), - allora la ncupiscio – risponde
l’altro, cioè la scavo di più.
Il pozzo si trova ad un paio di metri dalla strada: serviva da ristoro
anche per gli uomini e le bestie che, una volta, trascinavano i carri da e
per il Porto, al termine di un’ascesa non dura, ma costante.
I contadini la chiamano strada vecchia, per distinguerla da quella nova,
comunemente detta strada dei pali; perché nel secolo scorso, dopo aver
prosciugato tutta la zona della piana che era completamente paludosa, v’hanno
fatto, appena la strada comincia a salire verso Recanati, uno strarìpo,
cioè un rialzo lungo sui tre/quattrocento metri, e l’hanno protetto
appunto con pali di pietra alti 2/3 metri.
Ci spostiamo nuovamente sull’aia, mentre dentro di me cerco come di
fotografare tutto quel che il vergaro mi viene dicendo e mostrando,
perché mi riprometto di scriverci su qualcosa, che una scoperta del
genere non può restare ignorata.
Durante l’ultima guerra, quando passava il fronte,
nel ’44, riprese quel brav’uomo, le mani pesanti in tasca, il busto in
avanti appoggiato su una gamba, nella mossa tipica dei contadini che si
riposano sulla vanga, i soldati polacchi avevano fissato qui, in questa
casa, la residenza per gli ufficiali ed issata pure la loro bandiera,
facendo capire che sapevano bene che quella era stata un tempo proprietà
polacca, e tale la ritenevano ancora.
E per convincermi dell’autenticità delle sue parole, Cupido mi mostra
una grossa pietra di tufo proprio ai piedi della scalinata, con su
scolpite due evidentissime P.P. Ci vuol poco a capire che significano
Proprietà Polacca.
Proprio come s’usa vedere in certi palazzi nobili di Recanati, i quali
in qualche angoletto di muro esterno riportano su una piccola lastra la
scritta, ad esempio: proprietà Antici-Mattei.
Chiaramente nel corso degli anni l’ex convento ha subito modifiche nella
parte interna, ma esternamente gli archi sopra le porte sono ancora ben
rintracciabili, così come le finestrelle nella parte alta: gli uni,
forse, immettevano alla stalla, oppure era il refettorio o il dormitorio
dei frati? Oppure servivano per la piccola chiesetta del convento? Le
altre erano del granaio oppure delle cellette?
Ma le sorprese non sono finite: proprio a ridosso dell’abitazione
(lato sud-ovest) l’anziano vergaro mi fa vedere i resti di quella che
era una fornace, piccola s’intende, ma capace di fornire mattoni agli
stessi frati e ai contadini dei dintorni. E mene dà una prova,
spiegandomi che i grossi muri della casa eran fatti al di dentro con
mattone crudo, cioè di malta; mentre il muro esterno con mattone cotto.
Si è fatto tardi, ormai; la sudata mi si è raffreddata; ho voglia di
correre subito a casa,a fare una bella doccia. Ringrazio il buon Cupido e
fò per salutarlo promettendogli che su quel che mi ha raccontato
scriverò qualcosa, quand’egli con un largo gesto delle braccia, l’aria
compiaciuta di chi sa di possedere un gran segreto da svelare, esclama:
"Ma dove andate? Manca da vedere ancora la cosa più
importante!". E mi mostra lì per terra, accanto alla parete ovest
della casa, una vecchia lamiera tutta arrugginita, coperta alla bell’e
meglio da alcune tavolacce. Sotto a quella specie di botola si diparte un
camminamento che zigzagando si protrae fin nel pozzo; di sicuro serviva ai
frati per attingervi acqua in casi di necessità, quando, ad esempio,
venivano attaccati dai nemici. Penso agli assedi dei Saraceni; ai passaggi
delle truppe napoleoniche e garibaldine.
Inoltre, le pareti di questo percorso sotterraneo sono ricoperte tutte di
mattoni, ed ogni tanto c’è un nicchio, che certamente fungeva da
ripostiglio sicuro e fresco.
Smanio dalla voglia di scendervi, per andar a
constatare di persona quel che mi è stato appena detto; ma prevale il
buon senso; non ho con me una pila, né una macchina fotografica; e
chissà che quell’antro non riservi qualche brutta sorpresa? Meglio
rimandare; da quel giorno, però, quella specie di discesa agli inferi,
alla maniera degli antichi eroi d’Omero e di Virgilio, che han popolato
la mia fantasia di fanciullo, è diventata una costante nei miei pensieri.
Questa volta saluto sul serio Cupido e, mantenendo fede alla promessa
fattagli, da quel giorno ho cominciato a darmi da fare, consultando,
leggendo, scrivendo.
Innanzi tutto presso l’archivio di Recanati, nel
catasto del sec. XVIII, al foglio 56, risulta presente nella zona indicata
come Bellaluce la Opera Pia Polacca.
Tra l’altro lo stesso volume contiene la descrizione territoriale di
Porto Recanati, com’era allora, quando il 20 ottobre 1757 venne
completata "….la pianta de’ terreni della possessione dei rev.
Padri di sant’Agostino di Recanati in contrada del Porto, e dell’Ill.ma
Comunità di detta Città di Recanati misurati da noi sottoscritti
agrimensori e catastieri di essa città, e terminati coll’assistenza
degli Ill.mi sig.ri Marchesi G.Antici e G.Roberti deputati per parte della
medesima città, e dei padri Baccellieri Giuseppe, Nicola Cruciani e
Nicola Catalani deputati per parte del ven. convento di sant’Agostino….".
Circa l’alto prelato recanatese credo opportuno –per ovvi motivi-
tacerne il nome; comunque, nel Duomo di Recanati, se volete prendervi il
gusto di dare un’occhiatina alle varie lapidi ivi murate, ne troverete
una con su scritto che "..il...dal re di Polonia fu annoverato fra
i cavalieri di san Stanislao e dell’Aquila Bianca…ascritto fra i
Magnati nativi della Polonia…".
Il che conferma in pieno gli eccellenti rapporti tra quello Stato dell’est
ed il nostro nobile recanatese; senonchè questi è morto circa cinquanta
anni prima della battaglia di Castelfidardo!
Un momento di delusione: forse il vecchio contadino ha confuso alquanto le
cose. Comunque, non demordo: credo al suo racconto. MI reco nella
biblioteca comunale e lì, scartabellando in mezzo a fogli ingialliti,
trovo che Cupido non aveva affatto mal ricordato.
Infatti un consanguineo dell’altro sopra "…fu da Pio IX nel
1856 nominato Patriarca di Costantinopoli, e nel 1875 promosso alla
porpora cardinalizia, assegnatogli il titolo presbiteriale di san Lorenzo
in Panisperna".
Per avere altra conferma ed ulteriori notizie decido di
scrivere al Biskup Szczepan Wesolj, il centro di cultura polacco che ha
sede a Roma in via delle Botteghe Oscure, 15; del quale riporto
integralmente la risposta dattiloscritta, la quale convalida
definitivamente quanto sopra detto: "Nel secolo XVI il Cardinale
Stanislaw Hozjusz, vescovo di Warmia, Cardinale della Polonia di allora e
Gran Penitenziere della Santa Sede fondò a Roma la Chiesa ed Ospizio di
S.Stanislao in favore dei pellegrini polacchi. Allo stesso tempo fu
comperata a Loreto (l’estensore della lettera non può conoscere le
millimetriche suddivisioni territoriali che v’erano e tuttora esistono
attorno alla Villa Gigli, la quale ben si sa che rappresenta il punto di
congiunzione dei territori di tre Comuni: Recanati, Porto Recanati,
Loreto. E’ chiaro che egli ha come suo unico punto di riferimento la
Santa Casa di Loreto!) una proprietà dato che la maggioranza dei
pellegrini polacchi visitava anche quel famoso santuario mariano. Verso la
fine del sec. XVIII la Polonia perse la sua indipendenza ed il suo
territorio venne diviso in tre parti, delle quali una fu occupata dalla
Russia, l’altra dalla Prussia e la terza dall’Austria. Lo zar russo
assunse il protettorato sulle proprietà polacche all’estero. Sotto tale
protettorato si trovarono anche la Chiesa ed Ospizio di san Stanislao a
Roma. Secondo le nostre informazioni la proprietà polacca fu data in
affitto ancor prima delle spartizioni della Polonia. Verso la metà del
sec. XIX l’affittuario di quella proprietà la vendette
illegittimamente. I tentativi di sua Eccellenza Mons. Giuseppe Gawlina,
che voleva dopo la seconda guerra mondiale ricuperare sulla via del
diritto la venduta proprietà polacca, non hanno avuto nessun risultato a
causa della prescrizione di quell’affare".
A questo punto, per completare la ricerca non mi
restano che due cose: una visita alla biblioteca-archivio della Santa
Casa, e…la discesa nella grotta.
Mi piacerebbe sapere chi erano questi frati, e quanti; se erano
francescani oppure appartenenti a qualche altro ordine religioso; a quanto
ammontavano le loro rendite, e in che forma se ne servivano per aiutare i
pellegrini polacchi e d’altri paesi giungenti a Loreto.
E se mai v’è stata la possibilità di contatti con il paesino
sottostante di poveri pescatori, qual era allora il Porto di Recanati. Se,
per esempio, vi si spingevano per la questua, come fra’ Galdino di
manzoniana memoria; oppure nel loro convento v’era venerata qualche
immagine, che richiamava la gente non solo di campagna, ma anche del mare.
Ad esempio, ancor oggi alla domenica chiunque può recarsi alla messa
mattutina nella piccola chiesetta annessa al convento delle carmelitane di
Maris Stella; e sempre collegato a questo monastero di Montorso, un
ricordo fugacissimo della mia fanciullezza: potevo avere sui 4/5 anni, e
con la mamma ho preso parte in una calda sera d’estate, illuminata da
numerose fiaccole, ad una processione notturna con tanta gente, in onore
della vergine, ivi particolarmente venerata.
Finalmente sono andato a Loreto presso l’archivio
della Santa casa, e lì, in mezzo a quelle pareti altissime gonfie di
libri e documenti antichi, ero certo di trovar qualche risposta alle mie
curiosità.
Ma un fraticello, il pizzetto alla D’Artagnan, in modi alquanto
sbrigativi s’è liberato di me subito, quasi geloso della mia invadenza
fra le sue carte, sostenendo la non veridicità della mia ricerca.
Così me ne sono andato via, un po’ deluso invero, ma in fondo contento
dentro di me perché, se avessi trovato qualche freddo registro, non avrei
più potuto più continuare a fantasticare di monaci provenienti da un
paese lontano, come invece mi succede ogni volta che, facendo footing,
passo davanti alla vecchia casa di Cupido, lo stemma di Gigli ben visibile
in alto sulla facciata, accanto alla nicchietta del Santo vuota; una cetra
giallo-oro su un fondo blé-mare. Nella nicchietta c’era una bellissima
rappresentazione in terra-cotta della Madonna col Bambinello in braccio,
seduti sopra la Santa Casa di Loreto, mentre un gruppo d’angeli la
sostenevano al di sotto volando sopra il mare. La muffa cresciuta attorno
aveva un po’ annerita l’immagine, dandole quella patina d’antico
sufficiente a far pensare che lì l’avessero collocata gli stessi frati
polacchi! Poi, un giorno di qualche anno fa, è sparita: prelevata da
qualche abile mano desiderosa di piazzarla chissà dove.
Quanto alla discesa nella grotta sono ancora in attesa
di un …Virgilio qual mio duca.
Ah, dimenticavo di aggiungere che Cupido, prima di
lasciarmi m’ha anche detto –a stuzzicare ancor più la mia fantasia-
che appena sopra il cimitero del Porto, dov’è l’attuale vigneto, i
vecchi raccontavano che vi fossero anticamente un villaggetto ed una
chiesetta chiamata di san Giovanni!!

|
| |
Dialogo
con il gabbiano (di Nando Carotti)
Mi piace incontrare, quasi ogni mattina, il
gabbiano.
Vado a cercarlo sul bagnasciuga, là dove la
curva della sabbia respinta via via dalla risacca è bruscamente
interrotta dal piccolo scoglio, poco più che un sasso nero
appuntito levigato verso levante dove batte l’onda, al quale
seguono tanti piccoli scogli a far da corona fino alla curva di
sabbia successiva.
Questo di adesso è il gabbiano antico, non uno
di quelli un po’ troppo vivaci, forse perché piccoli, non
soltanto inesperti, che sentendomi avvicinare battono le ali,
infastiditi, e saltellano poco più in là o si involano. Questo è
lo stesso di una volta: il gabbiano con il quale ho dialogato tutta
la vita, quello che per anni mi ha atteso quando ero lontano e
dialogavo con altri gabbiani, ma lui non lo sapeva, e così da
quando mi ha riveduto ha avuto tante cose da dirmi.
E' grosso. Un po' tronfio, così accucciato come
se ne stà sulle zampe appollaiate sulle asperità del sasso che
forse e danno sicurezza a lui ormai insicuro probabilmente perché
vecchio. Il becco sprofondato nel piumaggio del petto, immobile,
rivolto al sole che fra poco farà capolino laggiù oltre
l'orizzonte e la sponda opposta dell'Adriatico. Gli occhi chiusi
perché finge di dormire: finge, lo so, perché tra le fessure delle
palpebre e delle pieghe della pelle lo sguardo è certamente vigile
come quando, la prima volta che ci incontrammo e lui non conosceva
le mie intenzioni, improvvisamente spalancò il becco minacciandomi
con quel suo grido rauco somigliante ad un scroscio di risa d’un
maleducato.
E' grosso e vecchio: rispettato dagli altri
gabbianelli che gli lasciano tutto intorno lo spazio dovuto all’autorità
del capofamiglia o del capo e basta. Il patriarca, insomma. Forse l’unico
rimasto dell’antica stirpe dei gabbiani che chiamavo
"reali" per scopiazzare il modo di definirli usato da un
vecchio pescatore d’altri lidi tanto tanto tempo fa. Forse l’unico
tra gli amici di un tempo ormai troppo lontano per ricordarte nomi e
fisionomie.
"Che fa? – mi domanda giungendomi alle
spalle l’amico d’ogni mattina, quello che non so come si chiami
e che forse non sa come io mi chiami - guarda i cocali?". I
cocali, forse voce dialettale per cocelli, la razza di gabbiani di
dimensioni ridotte. "No - gli rispondo senza voltarmi perché
il gabbiano non mi creda distratto - dialogo con lui". Quando
mi volto, poco dopo, l'amico non c'è più: se ne è andato senza
fare il minimo rumore sulla sabbia ancora freddina, forse per non
disturbare il mio dialogo col gabbiano o forse temendo il peggio. Mi
crederà pazzo, penso, o quanto meno strano: alla prima occasione
dovrò spiegargli che cosa sia per me questo gabbiano anche se,
dopo, forse si domanderà se non avesse visto giusto.
Si muove. Adagio, quasi impercettibilmente. Come
un vecchio signore che si stia risvegliando, stiracchiandosi un poco
prima di aprire gli occhi al nuovo giorno, forse dopo una notte non
proprio tranquilla, forse agitata da sonni non belli, forse irritata
da una cena insoddisfacente. Solleva un poco il becco, distaccandolo
appena dal petto. Agita qualche piuma grigionera, di quelle con le
quali terminano le ali biancastre più bianche al centro che adesso
non si vede perché serrato al petto ancora. Sul capo sembra
vibrargli un ciuffo di peli, come se nervetti appena sottopelle
avessero provato d'essere vivi, o come se un pensiero gli fosse
frullato per la testa, ammesso che anche per i gabbiani si dica
così. Dalla gola gli esce una specie di borbottìo soffocato che
del caratteristico grido, la solita "parola" del gabbiano
ha soltanto il tono profondo, forse arrochito dall’aver dormito
all’addiaccio, ma pur sempre la "sua" voce,
inconfondibile.
Si stiracchia apertamente, adesso. Senza ritegno.
Alluna prima un’ala poi l’altra, e mi sembra di sentire quasi lo
scrocchiare di qualche giuntura: forse soffre di artrosi. Poi fa un
minimo di toletta: si liscia col becco le penne del petto poi,
sempre col becco, fa qualcosa sotto le ascelle, prima a sinistra poi
a destra, ma si chiamano ascelle anche quelle dei gabbiani?, e
sembra goderne, o forse soffre il solletico. Infine si solleva
stendendo le zampe, stendendosi tutto, allarga le ali, un metro e
mezzo all’incirca, tutto sommato, e le batte ma non abbastanza per
sollevarsi in volo proprio per muoverle, evidentemente, forse
intorpidite, forse obbediente all’antica abitudine della
ginnastica mattutina.
Allora mi vede "ufficialmente": non sa
che avevo capito già da tempo di non essermi avvicinato
inosservato. Forse lo intuisce ma non gliene importa; l'importante,
credo stia pensando, è che io abbia rispettato il cerimoniale, che
sia lui a darmi udienza!
Sembra indeciso se fare un voletto o zampettare
sulla sabbia tra i granchiolini appena nati che la risacca
scaraventa sulla schiuma dell’onda che frange, quasi invisibile
tanto il mare è calmo. Indeciso se continuare a volgermi la schiena
perché non mi teme o guardarmi fisso negli occhi sfruttando il
favore d'essere per me controluce adesso che il sole è finalmente
spuntato abbagliando tutto davanti a sé.
Decide per la colazione, evidentemente. L'ho
detto, è maleducato: non mi invita nemmeno pro forma, becca qua e
là nella sabbia e certamente ingurgita qualcosa ma tanto svelto che
non vedo che cosa, forse quei granchiolini sfortunati che la risacca
non ha fatto in tempo a risucchiare nel mare. Scaccia un gabbianello
impudente che svolazzando gli si avvicina, lo scaccia minacciandolo
nella sua lingua di grida arrochite, accennando appena un'apertura d’ali:
il gabbianello ripiega sollevandosi d'un paio di metri col moto
saltellante che pare imitare quello delle rondini in caccia. Allora
il "mio" gabbiano si stiracchia da capo, fa due passi come
per bagnarsi le zampe, becca l'acqua spruzzandosela sul petto e solo
dopo, terminate quelle che probabilmente sono le sue abluzioni
mattutine, mi degna d’una occhiata e s’avvicina.
Gli dico come ho trascorso la notte. Col
pensiero, naturalmente, non a viva voce : lui, forse, gradirebbe
sentirla come altre volte è accaduto, ma se qualcun altro mi
sentisse direbbe a tutti che parlo da solo quando nessuno mi è
vicino. Così i nostro dialogo è muto,è un dialogo tanto riservato
che esclude tutto, uomini, gabbiani, cose, come se a l mondo, nel
nostro mondo , esistessimo solo noi due.
Mi torna alla mente la "melodia di un’antifona"
, che scrissi anni fa' . Diceva "Uomini. Gabbiani. Ricordi
lontani/ nel tempo agitato dal vento,/ sospeso nel vuoto dolente/ di
memorie che riaffiorano/ e spingono/ e urgono/ sole, private d’amore,/
sofferenti nel buio,/ tremanti di freddo e d’ali insicure./ Corpi
non corpi, sul bagnasciuga./ E ali, ali, ali bianche e rosate./
uomini. Gabbiani. Ricordi lontani/ nel tempo che torna e racconta/
commosso, la favola bella" . . Non è un caso : anche allora
dialogavo col "mio" gabbiano reale , ed anche allora non
era per caso perché io avevo dialogato sempre con un gabbiano, con
quello che a turno era il "mio" gabbiano.
Ricordo che fanciullo, sguazzavo nell'acqua bassa
fingendo ciò che non sapevo fare, nuotare. Battevo le mani
sollevando spruzzi ed agitando i piedi riposandoli al più presto
sul fondo sabbioso, e ridevo, divertito. E ricordo il vecchio
pescatore al quale non ebbi il coraggio di rispondere quando
osservò che disturbavo i gabbiani, e la sua meraviglia quando si
rese conto che non capivo, e l’incertezza che, frenò miei giochi
quel giorno e gli altri successivi finché non mi fu chiaro che i
gabbiani, come avevo inteso dire dal vecchio pescatore, non erano
dettagli del paesaggio ma esseri vivi, veri e propri personaggi da
rispettare come lui e me e gli altri.
Ricordo quando, tanti anni dopo, qualcuno mi
raccontò una fa vola che, pensai, forse proprio una favola non era:
quella dei gabbiani che sarebbero gli spiriti irrequieti dei marinai
d’un tempo, di quelli che non ci sono più e vogliono vivere sul
mare il loro aldilà., la loro ignota eternità. Ricordo di averla
sentita raccontare in più parti del mondo da marinai delle lingue e
dai dialetti più disparati e d’essermi chiesto quanto ci fosse di
vero e quanto di sentimentale, di fantastico, forse di scaramantico:
ma allora ero poco più che un ragazzo.
Ricordo quando, durante la guerra, un gabbiano
morente si gettò a capofitto sulla coperta della mia nave anziché
tra le onde che gli sarebbero state più amiche, e ricordo le
lacrime di un giovanissimo marinaio che venne a spiegarmi che quel
gabbiano, proprio quello perché lui lo conosceva bene, era lo
stesso che da quando avevamo salpato aveva svolazzato sulla nostra
verticale durante il giorno appollaiandosi poi di notte sulla
formaggetta dell’albero per i segnali
Ricordo l’amore di due gabbiani adulti che
parevano ragazzi timidi in cerca di intimità e che accertatisi che
nei pressi sarei stato l’unico testimone, me ne diedero
cortesemente atto facendosi gli affari loro con grazia, con
trasporto, come fosse la loro prima notte di nozze, e ricordo che mi
volsi dall’altra parte per non disturbarli, come avrei fatto nei
riguardi di due ragazzi su una panchina.
Ricordo il gabbiano grande, davvero maestoso se
in quel momento fossi stato ispirato da vena poetica anziché da
spirito di sopravvivenza, che volteggiava, si tuffava, pescava, poi
veniva a lasciar cadere il pesciolino non ingurgitato esattamente
sulla mia testa convinto, evidentemente, che alimentarmi
contribuisse a non lasciarmi affogare.
Ora credo abbia recepito il mio messaggio
pensato: compie un quarto di giro su se stesso, goffo come se fosse
anchilosato o pigro, poi mi osserva diritto negli occhi. Mi
disturba, come quando il professore mi osservava allo stesso modo ed
io sapevo che intuiva se fossi o non fossi preparato. Adesso è
immobile, come sempre o quasi sempre quando non vola: per
risparmiare forze, nel rispetto dell'età, o forse perché questo è
il suo modo di sentirsi importante.
Adesso è lui, il gabbiano, che, muto, trasmette
un pensiero.
Pensa un gabbiano? Sì se avverto nel cervello
qua]cosa che si mette in movimento, se provo il disagio
caratteristico di quando voglio dialogare con chi forse parla una
lingua diversa e ancora non so se potremo capirci. Eppure capire
questo gabbiano è facile: basta non voler, sapere tanto più di
lui, basta l'umiltà di sentirsi alla pari. Basta stendere una mano,
lentamente perché sia chiaro che si tratta d’un gesto da amico,
non di una minaccia. Basta convincersi che lui ti ricambia quando
scuote le spalle come se si apprestasse a spalancare le ali che
invece continua a serrare sul corpo, in riposo.
Qualcosa non gli va giù, mi comunica. Aspetto
paziente, che mi trasmetta il resto.
Non gli va giù che i gabbianelli siano tanto
diversi da lui: non più piccoli, ché a crescere ci sarà tempo,
diversi, che il bagnasciuga non sia più pulito come una volta ,
quando lui era un gabbianello, quando alla sveglia sguazzava con le
zampe nell’acqua e le ritraeva lavate e rinfrescate, non annerite
e untuose come adesso appena al di là degli scogli; che perfino io
lo lasci troppo solo saltando qualche mattina perché impegnato in
altre cose che non gli spiego perché, queste si, non le
cambierebbe.
Proprio come tu fossi un uomo, gli sussurro, e
lui batte le palpebre sugli occhietti che adesso mi sembrano
rossastri.
Gli racconto quello che faccio. Poi rifletto e
gli confesso anche quello che provo, come fosse l’amico del cuore,
l’intimo cui tutto si confida, quello parlando con il quale piace
"aprire le cateratte", come diceva don Giulio quand’ero
bambino. E lui, il gabbiano, apprezza: ascolta impettito senza
spostarsi di un millimetro, pare perfino trattenendo il fiato
perché, saggio come deve essere alla sua età, sa che l’incantesimo
si rompe con niente, pure con l’alito emesso involontariamente.
Poi mi interrompe: ha impellente bisogno di
sgranchirsi un po'. Spicca il volo quasi senza battere le ali grandi
e bianche, nere sulle punte; sale qualche metro compiendo un giro
senza perdermi di vista, me ne accorgo perché anch’io lo osservo;
poi cala planando e si posa sul medesimo scoglio voltando la coda al
mare e al sole , il becco a me che sono rimasto dov’ero. Come tra
amici, quando uno dei due si sposta un momento senza interrompere l’altro.
Così non devo riallacciarmi a quanto stavo dicendo perché quello
che voglio raccontargli sto ancora dicendolo come prima che lui
compisse il voletto, si sganchisse le ossa.
Ora il sole non si nasconde più: si è elevato
sull’orizzonte e punta diritto nelle mie pupille ,così mi è
difficile , adesso , guardare il gabbiano controluce mentre lui si
riscalda la schiena e la nuca semiaffondata nelle piume folte del
collo. Gli annuncio che me ne vado, che tornerò domani quando il
sole sarà ancora al di là dell’orizzonte ed a me sarà possibile
guardare verso il mare: pare capire il problema, forse si domanda se
in condizioni diverse sarei disposto a rimanere, magari soltanto per
un po’, e per provare la propria teoria si solleva di pochi
centimetri e con un semplice battito d’ali compie un quarto di
giro sulla mia sinistra e si posa sulla sabbia ancora indurita dal
fresco umido della notte appena trascorsa. Poi, accoccolato come era
poco fa sullo scoglio, immobile , mi osserva come aspettando ciò
che farò adesso che le condizioni sono cambiate, adesso che lui le
ha cambiate.
Capisco. Ruoto anch’io d’un quarto di giro e
lo osservo, e sorrido perché il gabbiano mi sembra buffo così
deciso a simulare la più assoluta indifferenza mentre so che ha
realizzato, ha scelto lui il posto, lui che lo conosce meglio di me.
Va bene, gli dico d’accordo. Adesso mi
accoccolo anche io sulla sabbia meravigliandomi un poco di non
sentire subito l’umidità penetrarmi nei pantaloni: già,
rifletto, ha scelto lui il posto, lui che lo conosce meglio di me.
I gabbianelli svolazzano intorno tenendosi a
rispettosa distanza senza emettere i loro gridolini di pulcini
festosi; formano, tutti insieme, un piccolo stormo adesso che sono
piccini, perché quando saranno cresciuti ognuno andrà per la
propria strada e non disdegnerà di rubare il pesciolino dal becco
dell’altro, se appena potrà. Si stancano presto, atterrano uno
dopo l’altro quasi scegliendosi un posto in platea tutto intorno
allo spazio, che rimane vuoto, tra me ed il gabbiano reale; poi,
imitando il patriarca, si accoccolano anch’essi col petto ed il
ventre nella sabbia, la testa sprofondata tra il petto ed il collo,
tutti eguali, tutti diversi dame. Testimoni, forse sperano, del
dialogo serrato tra il loro capo e questo animale grande e grosso
che forse non hanno avuto ancora il tempo di imparare chi sia.
Le paure sottolineano i pensieri, tra una frase e
l’altra che rivolgo all’amico. Anch’esse, le pause, hanno un
significato; e lui, credo, le capisce perché le rispetta, non
sollecita né continuità né fine. Ed ogni pausa nei miei pensieri
è un salto di data, spesso un salto geografico, perché un pensiero
ne tira un altro, un ricordo quello più remoto, e lui, il gabbiano,
deve faticare un poco, temo, per non perdere il filo ed essere
pronto, quando glielo chiederò, perché sa che glielo chiederò,
che cosa ne pensi. Lo guardo fisso nelle fessure che stringono gli
occhi, ai lati del becco sottile affondato nelle piume del petto
rigonfio, così come è nel riposo: forsesi è addormentato, penso,
e lui solleva le palpebre, mi mostra per una frazione di secondo due
occhietti brillanti come punte di spillo esposte al sole, e subito
le richiude. Non dorme, ho capito: mi ascolta, attento, concentrato,
come quando io chiudo gli occhi per gustare meglio Bach suonato all’organo
da Schweitzer.
Ricordi, gli dico, il nostro primo incontro? Ero
bambino, su quella lancetta che Giuseppe teneva come un salotto
buono di casa, tutta pulita e lavata di fresco ogni mattina ed ogni
sera quando tornava a terra col pescato, tutta profumata di pesce
allora che l’odore di pesce mi pareva profumo tanto amavo già il
mare. Con la sua vela trapezoidale di cotone ritorto dipinta d’un
colore tra il marrone ed il rossiccio attraversato su in alto da un
arco di sole giallo-oro. Pareva a me piccino una nave enorme; e tu,
che vi volteggiavi sopra non disdegnando gli scarti del pescato che
Giuseppe e il figlio gettavano in mare, mi incutevi dapprima paura
poi soggezione e infine rispetto quando ebbi imparato che avrei
potuto perfino toccarti senza che tu te ne risentissi, ricordi?
Si scuote un momento, come a cacciare qualcosa
che lo molesti: forse lo infastidisce non ricordare, o forse3 vuole
dirmi che non era, non poteva essere, lui. Certo che non era lui!, l’antica
leggenda riferisce che un gabbiano reale è centenario e forse più,
ma credo sia soltanto una leggenda, tanto più che il
"mio" gabbiano era già grande e grosso allora, quando ero
bambino; ma a me piace pensare che il gabbiano ed io siamo sempre
gli stessi, anche perché se questo fosse un altro gabbiano non
l0omdistinguerei, non credo.
Forse incuriosito si appresta ad ascoltare
ancora, immobile come i gabbianelli affascinati accovacciati poco
distante, in cerchio, come gli amici quando il vecchio racconta.
Ricordi, gli dico, quando viaggiasti con me,
clandestino perché nessuno ti aveva permesso di allontanarti tanto,
ed io potei riportarti indietro?
Ricordi quando desti l’allarme alla gente, al
levar del sole, perché tu solo avevi avvistato quel pover’uomo
annerito dalla lunga immersione, spiaggiato nella notte dalla
risacca? Quello che non si seppe mai chi fosse stato né donde fosse
venuto ma solo che era affogato?
Ricordi?, ero bambino allora, e tu eri già lì,
appuntato nel celo come un ago sul puntaspilli, disegnando nell’azzurro
una macchia instabile biancastra con qualche contorno nero,
annunciando la tua presenza a chi fosse distratto con quella tua
voce roca uguale alle voci roche di tutti i gabbiani del mondo, da
quando mondo è mondo, credo.
Ricordi?
Adesso sono stanco. La sabbia sotto di me si è riscaldata, il sole sta
surriscaldando l’altra, quella sulla quale
non faccio ombra. Il gabbiano reale ha esaurito quanto aveva da é dirmi,
almeno per oggi, e manifesta d’essere
stanco anche lui, forse ha perfino fame: si muove appena, accenna ad
alzarsi sulle zampe; è un segnale, gli altri,
i gabbianelli, spiccano il volo d’un tratto, tutti assieme, pare
vogliano attenderlo lassù e lui li accontenta,
si innalza nel cielo quasi senza muovere un muscolo, solo aprendo quelle
grandi ali bianche punteggiate di nero,
solo puntando il becco al di sopra della testa. Si sofferma un instante,
immobile, sorretto da una brezza tanto lieve
che non l’avverto, guarda giù a me che adesso non posso seguirlo, poi,
deciso, punta il becco a levante e
sparisce nella scia del sole, lui che può farlo.
"Riposava?" – mi chiede il bagnino
disceso ad aprire gli ombrelloni, a preparare le sdraio.
"Già – rispondo sottovoce – come ogni
mattina da quando non vado più per mare".

|
| |
|
"Uno
tango.....milla lire" (di Carlo
Siniscalchi)
(Titolo preso in prestito per vecchie storie di paese e
probabili giochi del destino)
"... di fatto negli anni a venire,
li avrei rivisti suonare ancora insieme, ma quella sera rimase sempre nei
miei ricordi come qualcosa di più....".
Estate del 1944, faceva molto caldo e lo scontro tra le
truppe tedesche e quelle alleate era ormai imminente anche nelle nostre
zone. Il fronte si stava avvicinando; i tedeschi preparavano la ritirata
verso nord portandosi via tutto quello che trovavano: l’utile e l’inutile.
La linea difensiva passava per Castelfidardo e Camerano, dove l’artiglieria
tedesca attendeva l’avanzata da sud, lungo la costa adriatica, della
VIII Armata alleata.
Molti Portorecanatesi si trovavano sfollati nelle campagne attorno al
paese; erano momenti di paura perché, dove passava il fronte, tutto
diventava insicuro, incerto e precaria ogni aspettativa.
Da qualche mese Porto Recanati si era svuotato. I Tedeschi avevano
ordinato lo "sfollamento", non perché temessero conseguenze per
i civili, dovute ai bombardamenti dal cielo e dal mare, bensì per poter
organizzare meglio la difesa, sabotando il più possibile, in primo luogo
i ponti sul fiume Potenza.
In quei giorni, cosa si poteva avere se non paura e fame! Come molti
Italiani di allora passarono alla storia per essere stati dei "poveri
morti di fame", anche tra i nostri concittadini ci fu chi realmente
soffrì. Non c’era pane, sale, olio. In inverno non c’era carbone per
riscaldarsi. Dove la guerra era passata aveva lasciato solo macerie.
Fortunatamente il territorio di Porto Recanati non fu molto provato; forse
lo preservò la vicina presenza della "Vergine Nera" di Loreto
(!), forse la poca rilevanza strategica o forse perché era già nei piani
dei Tedeschi il più sicuro insediamento a nord, lungo la Linea Gotica.
Terra, questa, dove gli scontri passarono in fretta, con pochi giorni di
cannonate e quando, agli inizi di luglio, si videro scendere dalla collina
di "Montesanto" verso la piana le prime jeep alleate, tutto ciò
che fino ad allora era stato se ne andò per sempre.
Se ne andarono i Tedeschi, se ne andò la miseria, se ne andò o passò a
miglior vita "Bel Ami", anonimo eroe dalla parte sbagliata che
da solo cercava di arginare l’impeto dei bombardieri alleati, seduto
sull’unica postazione antiaerea situata in fondo allo stabilimento della
Montecatini e se ne andarono coloro che in certi ideali avevano creduto,
tanto da pagare le conseguenze della sconfitta.
Tutti a casa finalmente, con la scabbia fra le dita,
qualche pidocchio in testa e con il solito vuoto allo stomaco che però
non infiacchiva la spinta dei "carioli" carichi di povertà e
poche cose. Ritornava la coscienza della realtà e mentre
"fuori" tutto appariva molto brutto, "dentro", nel
cuore della gente, c’era la sensazione che le cose sarebbero cambiate,
che un mondo migliore sarebbe venuto. Un mondo migliore, dove si potesse
ricominciare a vivere, lavorare e, perché no, mangiare un po’ di più e
meglio. Si diceva: "Se non mangi devi fare tutto e male, se mangi
puoi scegliere cosa è meglio fare e magari farlo bene. Così fu per molti
e per tutto ciò che seguì negli anni a venire, fino a quando il ricordo
di quei giorni si affievolì soprattutto per i fatti più brutti, quelli
che non si raccontano con piacere o che sono ormai dimenticati.
Al contrario non si potranno dimenticare i volti di chi rientrava quel
giorno in paese. Un’immagine da "Quarto Stato" con i segni
impressi della sofferenza e della dignità ma, in più, della felicità
frastornata, confusa nel pianto e nella rabbia di aver comunque perso
inutilmente una parte della propria vita. Pochi uomini, vecchi, donne,
bambini e, fra i giovani, uno di diciassette anni con una grande passione
per la musica. Anni prima assisteva curiosando alle prove della Banda
Musicale Scarfiotti, diretta dal Maestro F. Piangerelli.
Grande quel Maestro, uomo tutto d’un pezzo, paziente e rigoroso; capì
che Pietro poteva suonare. Infatti gli riusciva con gli ottoni, tant’è
che gli venne assegnata una tromba e cominciò a studiare la teoria
musicale.
Pietro, con i suoi diciassette anni, rientrava in un paese diverso da come
l’aveva lasciato, non c’erano più gagliardetti e camicie nere, non c’erano
più gerarchi, avanguardisti e figli della lupa, non c’era più la
fanfara fascista a cui era stato aggregato d’ordine dal gran capo
Conconi che, in zona, pare contasse molto.
Con la fanfara, Pietro aveva suonato nelle manifestazioni ufficiali di
partito, qua e là per la provincia e, come tutto nella vita serve, anche
quell’apprendistato musicale contribuì alla migliore conoscenza dello
strumento. Turbato fu il suo sguardo quando nelle vie del paese non vide
più i vecchi "carioli" ma jeep, enormi camion, mezzi blindati e
carri armati; sentì parlare lingue incomprensibili da soldati di chissà
quale provenienza. Australiani, Canadesi, Indiani, Polacchi, Americani ed
Inglesi, tutti quanti a dar vita ad una piccola Babele dove capire e farsi
capire sembrava essere il principale problema.
Con questa immagine uscì definitivamente dalla storia, anche per i
Portorecanatesi, l’Italia dei treni popolari e dei telefoni bianchi.
I primi, di cui si vedevano solo i contorni dietro il
fumo delle macchine a vapore e sopra i quali molti poterono far salire
solo la propria fantasia e i propri sogni e i secondi, immagini virtuali
di un mondo lontano rinchiuso in logori nastri di celluloide che
singhiozzando giravano nelle piazze di paese.
Era l’Italia di provincia che si muoveva a ritmi lenti, incurante che il
proprio presente, in altre parti del mondo, apparteneva al passato e per
certi versi anche remoto; un’Italia che dovette risalire la china
modificando tanto di sé stessa, non tutto per fortuna.
Quando i contingenti alleati si frazionarono sul territorio, a Porto
Recanati rimasero per lo più Polacchi, Americani di colore ed Inglesi.
Il quartier generale dei primi si insediò in quella che oggi conosciamo
come Villa Calvi, tra Piazza dei Mille e Via Pastrengo, il comando
americano fece base nei locali dello stabilimento della Montecatini, nella
parte nord del paese; gli ufficiali inglesi si stabilirono nell’allora
prestigioso Albergo Arena gestito dalla famiglia De Bellis, affacciato
sulla attuale Piazza Fratelli Brancondi. Altri gruppi di militari
trovarono alloggio nei vari angoli del paese: gli Indiani, ad esempio,
occuparono l’ospedale; altri Inglesi i locali del preventorio, dove era
funzionante la sala operatoria ed una grossa officina di riparazioni;
gruppi di militari polacchi, fra cui un notevole numero di donne, nei
locali dell’ex Casa del Fascio, nel Palazzo Volpini di fronte all’attuale
sede della Scuola Elementare lungo il Corso Matteotti ed ancora nella
Villa Rossa della famiglia Komareto- Volpini nella parte sud del paese, in
una costruzione, ormai da tempo abbattuta, lateralmente all’attuale
Largo Monte Conero e nel palazzo Lucangeli, già sede del comando tedesco,
dove fra l’altro era funzionante una grande cucina.
Campi militari e tendopoli situate nel territorio completavano il quadro.
Gli Inglesi furono i primi a reclutare manodopera per
la ricostruzione dei ponti sul Potenza, fatti saltare dai Tedeschi. Molti
giovani si fecero avanti e fra questi Pietro che, per la prima volta, alla
fine della giornata lavorativa, vide entrare nelle proprie tasche la somma
di cinquanta lire (!). C’era l’idea di libertà e realmente si
avvertiva il miglioramento della qualità di vita.
Logicamente all’inizio ci furono periodi di comprensibile diffidenza e
parve impossibile poter stabilire dei punti d’incontro tra tutti; poi
qualcosa avvenne, si cominciò a socializzare, si riuscì a capire che era
necessario condividere la storia di quegli anni insieme.
La vicenda quotidiana di una piccola comunità marinara si intrecciò,
allora, con la vita di uomini e donne in uniforme che, sicuramente, più
della guerra desideravano riavere semplici emozioni, aspirazioni e pensare
a qualcosa di bello per il futuro, in quel momento per loro così incerto.
Ripresero le attività lavorative, ripresero i piccoli commerci, arrivò
il contrabbando con il mercato nero, le connivenze negli ambienti
militari, le storie di mala, gli imbrogli, l’usura, gli amori
clandestini, la musica nuova ed il ballo. Era evidente che bisognava
vivere e lasciar vivere.
Come quel giorno della fine estate ’44, quando due navi inglesi, dirette
a nord e cariche di latte di benzina da 20 litri, incapparono in alcune
mine poste tempo prima dai Tedeschi e colarono a picco a circa 5 Km. al
largo, di fronte al centro del paese. Ciò che fece scattare l’idea di
un grosso "affare" fu la mancata combustione del carburante
contenuto nelle latte che, al contrario, affioravano intatte dal fondale
non eccessivamente profondo, dove le navi si erano adagiate.
Chi poté disporre di una barca si avvicinò alla zona con l’intento di
una pesca "miracolosa" e correndo naturalmente grandi rischi.
Arrivarono da Ancona i palombari, incaricati del recupero ufficiale del
carico; poi in orari particolari altri "liberi professionisti"
coraggiosi si immergevano in apnea col preciso compito di intraprendere
una nuova attività col commercio del carburante.
Vennero nascoste numerose latte sottoterra in un posto sicuro, una sorta
di magazzino e mentre gli uomini del mare continuavano nella
"pesca", gli uomini di terra provvedevano allo stoccaggio ed
alla distribuzione. Un’organizzazione perfetta che purtroppo andò in
crisi quando un bel giorno il "bunker" sotterraneo venne
svuotato. Da chi, non fu mai dato a sapere. Dagli uomini di terra? Dagli
uomini di mare? La storia continua.
Il finale della vicenda, pare, essere stato addirittura
"pirotecnico", nel senso che accanto ai controlli più severi
delle autorità militari, le "cagnare furibonde" con accuse
varie, un incauto e sprovveduto personaggio mentre era intento ad un
ennesimo sopralluogo del tratto di mare, non ebbe meglio da fare che
gettare il mozzicone della sigaretta accesa in acqua con le conseguenze
immaginabili. Il mare di fatto inquinato da chissà quanta benzina, prese
fuoco e lo sciagurato si salvò per miracolo, riportando notevoli ustioni.
Tra le fiamme bruciarono così, per alcuni, i sogni di un’insperata e
rapida ricchezza.
I Polacchi del Generale Wladislaw Anders a differenza
degli Inglesi si sforzavano di imparare l’italiano, forse perché erano
consapevoli di dover rimanere a lungo in terra straniera, sempre più
confinati nelle retrovie, quando ormai l’avanzata alleata aveva assunto
i connotati delle vere nazioni vincitrici: gli Stati Uniti e l’Inghilterra.
"Erano dei begli uomini" scrisse in seguito Carlo Levi
"grandi e grossi, con facce colorite; molti portavano i baffi, dei
lunghi baffi biondi o rossi; molti non erano più giovani, erano già
calvi o grigi, avevano la pancia; ma tutti avevano un portamento così
nobile, un tratto da gran signore. Si stava bene con loro. Amavano bere;
bere molto per ore ed ore. Amavano la musica e non si accontentavano di
quella dei locali, ma facevano venire dei suonatori e cantanti della
strada che suonavano col violino, per loro, vicino ai tavoli. Le donne, le
trattavano bene: facevano loro mangiare tutto quello che volevano, le
prendevano per mano, le chiamavano "Signora". Erano timorati di
Dio, religiosi al punto di avere dappertutto medagliette, madonnine,
crocefissi, santini; al collo, al polso, nel portafoglio, nella fodera dal
cappello. Parlavano sempre della famiglia e della chiesa e dei miscredenti
ebrei che bisognava sterminare. Erano pigri, pagavano in sigarette per
farsi lavare i camion e le jeep dai ragazzini e intanto bevevano.
Corteggiavano le donne con garbo, ma non ammettevano schermaglie amorose
né incontri vani. Fratelli, fidanzati, mariti, erano per loro nemici
naturali contro i quali avventarsi, ubriachi persi, armati di coltello.
Gli occhi chiari e umidi si arrossavano di ora in ora e dopo il tramonto
diventavano fessure sanguigne: allora braccavano le ragazze con le quali
si erano mostrati gentili, le strattonavano, le picchiavano e il giorno
dopo le aspettavano sotto casa con un fiore e una tavoletta di cioccolata.
Spesso stupravano e offrivano nozze riparatrici in una sola serata".
Allora non erano ancora giunte da queste parti le vicende della pineta del
Tombolo e sicuramente non si sapeva nemmeno cosa e dove fosse; per certo a
Porto Recanati le truppe occupanti non raggiunsero mai livelli di
"ribellismo" come avvenne in Versilia, comunque i soliti
Polacchi, che più degli Inglesi e degli Americani s’integrarono meglio
con la gente del posto, rimasero famosi per epiche bevute, memorabili
risse, storie di donne, feste danzanti con incursione finale della M.P.
Il bene ed il male, aspetti reali sempre esistiti, che possono turbare l’equilibrio
di chi vive nel bisogno di tutto, sogni ed illusioni comprese; come
avvenne, appunto, anche dalle nostre parti.
Già dopo i primi mesi di occupazione, in paese, si
respirava un’aria diversa; tante erano le difficoltà a ricominciare, ma
tanti erano i motivi per riappropriarsi della spensieratezza e divertirsi.
Con poco, naturalmente. Nelle strade c’era festa, nelle case si cantava,
ci si incontrava, a volte si ballava. A Castelnuovo, ma sicuramente anche
in altre zone, vivevano famiglie spesso numerose che, di fatto, rendevano
le proprie abitazioni "aperte" a tutte le persone amiche, per
poter trascorrere qualche ora insieme. Dai Filippetti, dagli Alessandrini,
ad esempio, o dagli Attili, si sentivano grandi "cantate" e a
volte il suono della fisarmonica si mischiava al pianto dei bambini che
crescevano in modo "comunitario", a dimostrare che solidarietà,
amicizia e aiuto reciproco non erano mai scomparsi.
Poi si suonava nei locali.
Primo fra tutti la "Gospoda Zolniaska", situato negli ambienti
del Kursaal Lido, mitico luogo d’incontro estivo, che, unitamente all’Arena,
già una pubblicità degli anni ’30 definiva: "Grandioso teatro
coperto, Servizio bar-ristorante, terrazza a mare, ritrovo elegante".
Lo dirigeva una contessa polacca con il marito, colonnello dell’esercito;
c’era la cassiera pani Danuta e il magazziniere pan Scieniskj, per il
resto chi vi lavorava era del Porto. Alla Gospoda Zolniaska si mangiava e
si ballava con musica rigorosamente dal vivo, visto che altrimenti non era
certo possibile.
I grandi matinées danzanti della contessa; quanti se ne vide Pietro, che
nel frattempo aveva trovato lavoro con altri ragazzi nel locale e quante
coppie fece ballare, in seguito, proprio lì, al suono della sua tromba!
Formazioni di musicisti, più o meno improvvisate, suonavano qua e là; il
gruppo del Maestro Piangerelli, già nell’estate del’44, si esibiva al
"Canneto", locale "trendy" per l’epoca, perché
situato sul lungomare, all’altezza circa dell’attuale balneare
"Antonio" e caratterizzato da una delimitazione perimetrale
fatta di sole canne. Idea geniale di Giuseppe Bufarini, già proprietario
del Caffè dello Sport, che con poca spesa riuscì a creare un punto di
ritrovo estivo dove ogni sera non solo gli avventori del locale potevano
ascoltare musica e ballare, ma anche coloro, tanti a dire il vero, che al
di là delle "canne" si ammassavano. Era inevitabile che certe
sere, quando gli animi si surriscaldavano troppo, un po’ per l’alcool,
che scorreva abbondantemente, un po’ per l’elevato numero di uomini
che "statisticamente" non si potevano trovare d’accordo sui
vari problemi del momento, uno fra tutti le donne, prendessero vita delle
"scazzottate" che, a macchia d’olio si estendevano nelle zone
circostanti il locale. Se la prima scintilla veniva accesa dal solito
contenzioso a due, presto si arrivava al "tutti contro tutti" e
allora fra Polacchi, Negri, Portorecanatesi ed altri ancora, non ci si
capiva più niente. L’arrivo della M.P. e il conseguente fuggi -fuggi
generale sedavano animi e situazione così che la musica e le danze
potevano riprendere.
I generi musicali d’oltre oceano, che fino ad allora
erano stati censurati dal regime e che solo, grazie alla maestria di
grandi cantanti e musicisti, si erano affermati con l’opportuna
"italianizzazione", riuscirono ad emergere nella loro
originalità. Accanto alla musica dei Maestri Barzizza, Angelini, Kramer,
Danzi, Bixio e alle canzoni del Trio Lescano, di Alberto Rabagliati, di
Natalino Otto e di tutti quei musicisti che dai microfoni dell’EIAR
avevano alimentato i sogni e tenuto alto il morale per un ventennio, la
maggior parte della gente incontrò per la prima volta il vero jazz, lo
swing made in USA, il boogie-woogie, i ritmi afroamericani e caraibici e
quelle melodie che segnarono un’epoca e che fecero innamorare una
generazione.
Come sempre succede, ai vecchi maestri subentrano i nuovi ed anche allora
per suonare il "nuovo" bisognava cambiare. Pareri contrastanti,
vedute musicali diverse, difficoltà in fatto di esecuzione, fecero sì
che sulla scena le prime arrangiate formazioni passarono il testimone a
gruppi più giovani, al passo con i tempi.
Quando nell’estate del ’45 Giovanni, che aveva già suonato in un
gruppo, colse al volo l’occasione di "mettere su" qualcosa di
suo, Bruno era da poco rientrato dalla prigionia in un campo di
concentramento nazista , Pietro si arrangiava come poteva lavorando e
"suonacchiando", Armando lavorava nell’attività familiare,
Franco era un giovane di belle speranze e Oreste, con qualche anno in
più, già conosceva la vita anche negli aspetti di maggior pragmatica.
Gli Inglesi volevano un’orchestrina per le feste al loro Circolo
Ufficiali, i Polacchi, non da meno, la volevano per le serate danzanti
alla Villa Rossa, alla terrazza del Preventorio ed alla terrazza di
Palazzo Volpini; ci si doveva divertire e per ballare, qualcuno doveva pur
suonare.
Nacque l’orchestra Rampioni 06, gruppo musicale che,
forse unico in quel periodo, consolidò la sua fama anche negli anni
successivi proponendo la modernità che allora andava per la maggiore.
Giovanni Rampioni, sax di tutti i tipi e clarini, studente poi in
medicina, mente, trainer e cemento del complesso; Oreste Gonnelli, il
decano, violino; Pietro Pierini, l’irruenza, la passione, tromba;
Armando Attili la tenacia, la musica dentro, fisarmonica; Franco
(Francesco) Medori, l’eleganza e il ritmo scattante dato ad una
sgraziata batteria cinese; Bruno Benedetti, la storia, il metodo, la
disciplina, alla chitarra prima e poi, grande, al contrabbasso.
L’orchestra Rampioni 06 suonò dapprima al Canneto e sicuramente fece
conoscere ai Portorecanatesi la musica di Gershwin, di Young, di Cole
Porter, di Carmichael, di Chern e Glenn Miller; motivi come Again,
Stardust, In the mood, Beguine the beguine, Laura, Moonlight serenade,
Blue moon, Serenata a Vallechiara, Estasi d’amore e tanti altri,
entrarono nella vita di tutti ed accompagnarono i "moti dell’anima"
dell’esuberanza giovanile; per molti della precoce maturità. Forse
tutto ciò grazie anche a quel gruppo di amici.
Si suonava al Giardino Verde, nell’attuale Via Vittorio Veneto, dove
allora c’era il dopolavoro del Cementificio Scarfiotti; qui l’orchestra
Rampioni 06 era di casa, come pure all’albergo Arena, al Caminito ed al
Reticolato.
Il Caminito, nome capace di evocare ricordi di una terra lontana dove già
molti Portorecanatesi erano emigrati in cerca di fortuna, in realtà era
un grande magazzino dove si conservava il grano. L’esatta localizzazione
era in Via degli Orti, in quei locali, che in tempi più recenti,
sarebbero stati sede dell’indimenticabile "Lavaggio de
Checco"; durante l’occupazione tedesca, questo come altri magazzini
era chiuso e posto sotto stretta sorveglianza. Le scorte di grano dovevano
servire per i militari in primo luogo, in minima parte per i civili che,
logicamente, vivevano una condizione di necessità alimentare precaria.
Quando il grano viene conservato male e troppo a lungo si infesta di certi
parassiti che, nel gergo popolare, almeno allora venivano chiamati "tigni"
e diventa inutilizzabile a meno che ci sia una necessità, come dire,
fuori misura. Ciò che avvenne a Porto Recanati nei giorni della ritirata
tedesca, quando vennero aperti i magazzini, fu l’ovvio assalto
incontrollato della gente e come sempre succede senza regole precise
"homo homini lupus".
Finalmente il grano poté rientrare nelle case, pulito, macinato e
utilizzato per fare il pane di cui tanto si sentiva il bisogno.
Venne anche venduto o barattato come era d’uso allora e questo aspetto
si legò nel tempo alle vicende della "Divisione Tigno",
nomignolo dato a quei gruppi di donne più o meno giovani, generalmente di
provenienza meridionale, che si spostavano lungo l’Italia liberata, per
procurarsi il grano ed altro, visto che nelle loro zone d’origine la
guerra ed il clima erano stati più crudeli con i raccolti. Naturalmente
compravano il grano grazie alla loro manodopera nella bonifica dello
stesso; da cui il nome dato dai Portorecanatesi.
Nell’estate del ’45 e del ’46, fin quando
numeroso fu il contingente alleato di stanza a Porto Recanati, si
organizzavano feste da ballo negli edifici dove risiedevano i militari.
Alla Villa Rossa, ad esempio, dove l’orchestra Rampioni 06 suonò più
volte e dove il racconto dei ricordi della signora Enrica Volpini,
proprietaria della villa, sembra restituire alla storia pagine inedite,
anche se, nella confusione di quel periodo, facilmente comprensibili. Come
le adunate dei militari polacchi prima della libera uscita, nel cortile
antistante la villa, che si concludevano sempre in un religioso silenzio,
con un segno della croce collettivo, per poi dare vita ad una crescente
sarabanda fino a tarda sera. Al di là del cancello erano sempre presenti
decine e decine di "segnorine", di fidanzate ed altre ancora, di
provenienza incerta, spesso del Sud, che parallelamente al fronte
avanzavano nel rincorrere una promessa, un amore, un sogno dettato dall’ingenuità,
una passione che presto si sarebbe spenta. Quindi il ballo, la festa e
sovente l’eccesso.
Si suonava all’aperto al Kursaal Lido ed in particolare due erano i
momenti di maggior richiamo di pubblico: il veglione del Circolo del
Tennis ed il veglione Goliardico. Si trattava di serate di gala, con
ingresso ad inviti, per ospiti provenienti da tutta la provincia, di
rigore l’abito delle grandi occasioni. Anche l’orchestra Rampioni 06,
per essere all’altezza della situazione, rafforzava le sue fila con l’aiuto
dei "professionisti". Generalmente era il cantante o qualche
elemento solista da Ancona. A volte ebbe l’onore di accogliere il
Maestro Giuseppe Nicoletti, mitico fisarmonicista di allora, che essendo
originario di Castelfidardo, veniva a trascorrere le vacanze al mare, dopo
essere stato ospite fisso, durante l’inverno, dei maggiori locali di
Roma; uno fra tutti la Rupe Tarpea.
Durante la stagione invernale c’erano i veglioni di carnevale.
Si svolgevano negli spazi del Kursaal al coperto, avevano un’impronta
più popolare, i promotori che oggi chiameremmo "sponsors" erano
i partiti politici. Da poco era passata la breve stagione del governo
provvisorio di Ivanoe Bonomi, in cui convivevano Alcide de Gasperi e
Palmiro Togliatti; solo qualche sentore di quello che avvenne pochi anni
dopo, quando la contrapposizione politica assunse toni così marcati da
impedire, spesso, la possibilità che tutti, indistintamente, potessero
vivere insieme un momento di festa. Per fortuna i veglioni dei partiti
politici, della Stampa e della Società Sportiva, furono sempre a
vastissima partecipazione, tanto é vero che, per creare ordine nelle
danze, si fornivano le coppie di nastrini di colore diverso, poi lo
speaker di turno invitava in pista i contrassegnati dall’uno o dall’altro.
L’orchestra Rampioni 06, intanto suonava.
Suonava in trasferta scortata dai militari polacchi, gli stessi che,
appassionati per il tango, in certe serate si rivolgevano ai musicisti
chiedendo: "Prosze, uno tango ... milla lire!". Pietro,
generalmente incaricato della riscossione, prendeva le mille lire e
rispondeva: "Dziekuje bardzo". Poi via con la "Cumparsita"
o col "Tango della gelosia".
"....poi, in sala, cominciarono
a parlare solo i cuori.
Gli animi s’infiammarono, le camicie stropicciate e madide di sudore si
appiccicavano ai corpi in movimento, le coppie si stringevano, si
lasciavano, roteavano, si torcevano con esuberante maestria e le donne,
quella sera, erano tutte belle. Le vedevamo già amanti procaci che, nel
divenire delle ore, quando solo le stelle nel cielo sarebbero rimaste
accese, ci avrebbero accompagnato nella ricerca della carnalità tanto
attesa.
Dal salone della villa sembrava sprigionarsi un profumo di passioni
ritornate alla luce, di sentimenti ritrovati, di felicità terrene e
nessuno voleva il disincanto.
Quando, per l’ovvia stanchezza dei musicisti, il tono della festa
mostrò qualche cedimento, uno straniero si mise ad urlare: - Ancora
musica! Ancora ballare! Uno tango, prego uno tango, milla lire! –
Così dicendo sventolava delle banconote e chissà, sperava di comprare la
felicità con "milla lire", sapendo che domani, forse, l’avrebbe
persa...."
L’orchestra suonava e di fronte all’abbondanza
delle opportunità alimentari fornite dagli alleati, non sapeva resistere.
Così come avvenne a Pedaso, durante una serata, quando la custodia della
fisarmonica di Armando, venne riempita, di nascosto, con tutto ciò che di
commestibile e bevibile si era in grado di nascondervi.
L’orchestra suonava ai pranzi di nozze e prestava elementi per le
romantiche serenate che ancora si facevano e se a chi, non é dato sapere,
si può immaginare quanto facesse bene al cuore. Al mattino, nel luogo
dove la sera prima, complice il coprifuoco, passione, musica e parole si
erano fuse assieme, si trovavano cioccolate, sigarette ed altro, segnali
evidenti di riconoscenza di chi condivideva le stesse pene d’amore.
Quegli anni sembravano interminabili, invece passarono
rapidamente, passarono i vent’anni, passò l’emergenza. Gli ultimi
militari stranieri se ne andarono il 20 ottobre 1947. L’orchestra
Rampioni 06, ormai conosciuta e rinomata, con i famosi leggii in legno
fatti e stilizzati da tal Luigi Mengascini, suonò fino alla laurea del
Dottor Giovanni Rampioni.
Cambiarono i tempi e le necessità, cambiò la vita che per ognuno dei
componenti prese strade diverse. La passione per la musica rimase e per
alcuni di loro divenne preponderante per il resto della vita.
Giovanni Rampioni morì prematuramente e se ne andò Oreste Gonnelli,
facendo rivivere, per fortuna, nella sua discendenza il geniale estro
musicale che tutti conosciamo; Armando, poi, non riuscì per poco e
sfortunatamente a rimettersi in gara con la sua vecchia fisarmonica,
sarebbe stato bello poterlo riascoltare! Pietro continuò a suonare con
vari gruppi e formazioni, poi lunghi anni di silenzio, quasi a dimenticare
tutto un passato; finalmente riaffiorò la passione e con tenacia
ricominciò col "liscio" proposto dal Maestro Rossini e con la
musica più "colta" della Banda "G. Verdi" di Porto
Recanati. Oggi, quando ancora suona, come ieri non si sa risparmiare.
Franco, apparentemente il meno legato ai ricordi, non suonò più. Non è
difficile potergli carpire, ancora oggi, qualche aneddoto su quei giorni,
che però nel suo racconto rimane sempre un po’ sfumato ed
apparentemente confuso nella mente di un anziano e corretto
"signore". Infine Bruno che più di ogni altro ha vissuto per la
musica. Suonò sempre il contrabbasso con varie formazioni in provincia,
divenne insegnante di chitarra e generazioni di ragazzi, sotto la sua
guida, vennero avviati all'apprendimento di questo strumento, tanto da
essere insignito di vari riconoscimenti quando ancora le Scuole Musicali
erano di là da venire e almeno a Porto Recanati, la teoria musicale si
studiava solo dalla Maestra Vera Romagnoli. Oggi a quasi ottant’anni si
diletta con la chitarra e qualche volta abbraccia ancora il suo vecchio
"osso di prosciutto", così chiama il contrabbasso. Nei momenti
di malinconia racconta di un sogno dove rivede il suo amico Giovanni (Rampioni)
che dall’alto lo chiama e sorridendo lo rassicura che lassù tutto è
pronto per il grande concerto finale.
Gli dice:
- O Bru’ pia sto’ canapo, legace el ghitarò, che lo tiramo sù!
"Sotto le stelle del jazz,
ma quanta notte è passata ....
Marisa, svegliami, abbracciami
è stato un sogno fortissimo...." (P. Conte)
E’ vero, quanto tempo è trascorso e quante cose sono
successe!
Tante piccole cose, relegate sicuramente alle cronache di paese,
dimenticate fra le pagine della grande Storia. La Storia che non
ricorderà, certo, quei sei giovani musicisti, ma che non potrà
dimenticare l’entusiasmo con cui si viveva in quegli anni.
Rivederli passare per strada, con gli strumenti in mano, trasportando il
pesante contrabbasso, come allora ci emoziona e il nostro ricordo si
unisce a quella voce che, di casa in casa, come una specie di segnale, un
rispettoso tributo, li accompagnava:
- Ahò, ahò, maniteve, i soni à sù! (Sbrigatevi,
i suonatori vanno al Kursaal, a suonare!).
".... Ci sedemmo su una panchina
con lo sguardo assente rivolto verso il nord, quando il vapore denso di
una locomotiva ci inghiottì con tutti i nostri pensieri e con l’idea di
libertà...."

|
| |
|
Dopo
la tragedia della guerra ricomincia la vita (di Renzo
Bislani)
Questa scheda di ricerca di Renzo Bislani ripropone
l’argomento trattato da Carlo Siniscalchi nell’intervento precedente,
sviluppandolo sinteticamente da un osservatorio "esterno".
Il 4 luglio 1944 il fronte di guerra italiano passa per
Castelfidardo per spostarsi al nord: le truppe tedesche di occupazione si
ritirano strategicamente dal fiume Musone verso la line Gotica mentre
quelle polacche in marcia sulla direttrice adriatica liberano via via
Porto Recanati , Loreto, Recanati e il paese delle fisarmoniche.
Dopo la tragedia e gli orrori della guerra, vissuti anche in prima persona
dagli abitanti del luogo, la vita rincomincia in attesa della fine del
conflitto mondiale. La vita sorride di nuovo. Sono i giovani a dare una
mano agli anziani per riprendere il cammino del lavoro e della normale
attività sociale quotidiana. La parola d’ordine è ricostruire un
futuro sereno sulle macerie di un recente tragico passato che non dovrà
più ripetersi.
A Porto Recanati un gruppetto di giovani si ritrova
dopocena in casa di Medori per il corso Vittorio Emanuele per le prove. E’
prossima la prima uscita dell’orchestrina "Rampioni 06"
nell’estate del 1945. Ne fanno parte: Rampioni Giovanni di anni 21 al
sax, studente universitario alla facoltà di medicina a Bologna, fondatore
e animatore del sestetto, Pierini Pietro di anni 18 tromba, Medori Franco
di anni 19 batteria, Attili Armando di anni 19 fisarmonica, Benedetti
Bruno di anni 24 contrabbasso, reduce dalla prigionia in Germania,
Gonnelli Oreste di anni 28 violino.
L’esibizione avviene al Kursaal di Porto Recanati, all’aperto, settore
debitamente recintato e illuminato con piattaforma per ballare. Nella foto
troviamo i nostri eroi da sinistra: Pierini, Medori, Rampioni, Attili.
Benedetti e Gonnelli. E’ con loro un ospite importante, lo straordinario
fisarmonicista di Castelfidardo Nicoletti Giuseppe reduce da numerosi
concerti, testimonial della locale fabbrica di fisarmoniche "Zero
Sette", prestigioso esecutore anche con il sax e il clarino tenore. I
leggii che fanno mostra in primo piano della foto sono opera egregia del
falegname Mengascini Luigi costruttore di barche. L’orchestrina si
esibisce come si vede senza impianto di amplificazione e per di più senza
il cantante. La sigla di apertura e chiusura del programma musicale è "Serenata
al chiaro di luna" di Glen Miller. Il programma comprendeva altri
brani del famoso autore americano come "In the Mood", di
Duke Ellington, opere come "Smoke gets in your eyes", "Chattanooga
tho tho", "Besame mucho" e lo scatenante boogie-woogie.
Saranno famosi gli assoli di Nicoletti reduce dal successo romano di Rupe
Tarpea. La gente smetteva di ballare per meglio ascoltare la musica.
Gli elementi provenivano dalla Banda Musicale cittadina
"Scarfiotti". Svolgeranno negli anni a venire: Pierini il
cassiere della Cassa di Risparmio, Medori lavorerà ai cementi, Rampioni
diverrà medico, esercitando a Castello, Attili aveva una fabbrica di
ciabatte, Gonnelli sarà stagnino, l’ultimo, Benedetti, continuerà nell’impegno
musicale diventando insegnante di chitarra. Tutti sapevano leggere la
musica appresa con il noto e universale Metodo Bona.
Il complesso suonerà inoltre in occasione di feste organizzate dagli
ufficiali dell’esercito, inglesi e polacchi, presenti in zona, al
Balneare Piangerelli, al "Canneto" di Bufarini Giuseppe, al Bar
dello Sport, e sarà attivo fino alla laurea in medicina del suo leader
Rampioni e cioè per quattro o cinque anni.
Ultimamente è salito ad esibirsi in cielo con la sua
fisarmonica il castellano Nicoletti. Lo aspettavano per suonare in un
nuovo complesso jazz con i leggii tra le nuvole: il dottor Rampioni,
Attili e Gonnelli. Il quartetto ha aperto subito il suo programma con le
antiche e terrene note de "Moonlight serenade" di Miller.
Un anziano pescatore sostiene di aver inteso quell’aria celestiale in
mezzo al mare in una notte di luna piena, mentre calava la rete. Realtà,
fantasia ?… no, solamente ricordi… nostalgia di tempi passati, "sa
le calze corte e la forza ‘n te i bracci e ‘n te le gamme".
Tempi d’oro per i portolotti. Una petroliera inglese
era affondata davanti al paese urtando una mina lasciata in eredità dai
tedeschi. Sarà la ricchezza del centro rivierasco per cinque o sei mesi.
Il relitto a un paio di chilometri dalla spiaggia veniva spogliato
metodicamente da palombari con lo scafandro dalle lattine di benzina che
conteneva. Bastava appena spostarle nei contenitori della nave in fondo al
mare che le lattine venivano a galla a grappolo e immediatamente raccolte
sulle barche dai fortunati pescatori.
Dopo poco più di cinquant’anni, anche oggi la
benzina è … oro e da qualche parte, in una via del Porto o di Castello,
un gruppo di giovani si ritrova ancora per suonare per "rincominciare
a vivere".

|
| |
|
Album del Porto
 Foto n° 8. Un complesso musicale
"mitico" per Porto Recanati, The Rangers, che sotto la
guida di Bruno Benedetti ha mietuto grandi successi negli anni Sessanta.
Bruno Benedetti, per i pochi che non lo sapessero, ha insegnato a suonare
la chitarra a generazioni di giovani nostrani. E’ lui che ci ha fornito
la foto. Da sinistra a destra: Alessandro Antognini, Nazzareno Cionfrini,
Francesco Feliciotti, Vittorio Solazzi, Arcangelo Gasparre (presidente
Azienda di Soggiorno), il piccolo Massimo Benedetti (figlio di Bruno),
Pasquale Moroni (sindaco), Piero Gonnelli, Bruno Benedetti, Mario Riccetti.
La foto è del 1965. L’anno successivo The Rangers apparvero per
tre minuti nella rubrica televisiva Cronache Italiane. Foto n° 8. Un complesso musicale
"mitico" per Porto Recanati, The Rangers, che sotto la
guida di Bruno Benedetti ha mietuto grandi successi negli anni Sessanta.
Bruno Benedetti, per i pochi che non lo sapessero, ha insegnato a suonare
la chitarra a generazioni di giovani nostrani. E’ lui che ci ha fornito
la foto. Da sinistra a destra: Alessandro Antognini, Nazzareno Cionfrini,
Francesco Feliciotti, Vittorio Solazzi, Arcangelo Gasparre (presidente
Azienda di Soggiorno), il piccolo Massimo Benedetti (figlio di Bruno),
Pasquale Moroni (sindaco), Piero Gonnelli, Bruno Benedetti, Mario Riccetti.
La foto è del 1965. L’anno successivo The Rangers apparvero per
tre minuti nella rubrica televisiva Cronache Italiane.
 Foto n° 9. Foto n° 9.
Il passaporto per l’interno
rilasciato dal Comune di Porto Recanati a Pietro Cavallari nel 1918, a
firma del sindaco Giovanni Lucangeli e del segretario generale Dante
Santucci.
All’epoca Cavallari aveva 50 anni. In questo numero si scrive
di lui come segretario del Circolo Democratico Attilio Valentini.
Dobbiamo
il documento alla gentilezza della signora Jole Fabbrizzi Cavallari.
 Foto n° 10. Tracce di un molo o banchina affiorate
dalla spiaggia, all’altezza del grattacielo Bianchi, dopo la mareggiata
del 1959. La discussione è aperta tra chi le ritiene ciò che resta di
lavori per la costruzione del porto e chi, invece, pensa si tratti di
quanto rimane di una banchina cominciata a costruire dopo la grande
mareggiata del 1879, a difesa dell’abitato. Nel 1881 la via che oggi si
chiama Manin fu denominata Via della Banchina. Questa foto,
come la seguente, è un dono di Rodolfo Monarca al CSP. Foto n° 10. Tracce di un molo o banchina affiorate
dalla spiaggia, all’altezza del grattacielo Bianchi, dopo la mareggiata
del 1959. La discussione è aperta tra chi le ritiene ciò che resta di
lavori per la costruzione del porto e chi, invece, pensa si tratti di
quanto rimane di una banchina cominciata a costruire dopo la grande
mareggiata del 1879, a difesa dell’abitato. Nel 1881 la via che oggi si
chiama Manin fu denominata Via della Banchina. Questa foto,
come la seguente, è un dono di Rodolfo Monarca al CSP.
 Foto n° 11. Un comizio politico del fronte delle
sinistre tenutosi al cinema Kursaal il 14 ottobre 1945, in vista del voto
per l’Assemblea Costituente. Il compagno Guido Latini è l’oratore.
Alla sua destra è riconoscibile Vittorio Monarca. Non è stata
riconosciuta la terza persona sul palco. Foto n° 11. Un comizio politico del fronte delle
sinistre tenutosi al cinema Kursaal il 14 ottobre 1945, in vista del voto
per l’Assemblea Costituente. Il compagno Guido Latini è l’oratore.
Alla sua destra è riconoscibile Vittorio Monarca. Non è stata
riconosciuta la terza persona sul palco.
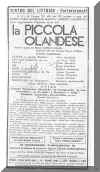 Foto n° 12. La piccola olandese fu
rappresentata al Teatro Littorio (il Kursaal) il 5 e 6 giugno 1937. Si
tratta di un’operetta di Romolo Corona (parole e musica) interpretata da
Alina Spedaletti nel ruolo di Liliana, Aureliano Doffo (Pan Pan Tulipan,
zio di Liliana), Fedra Macellari (Violet), Luigi Castellani (Dik),
Raffaele Scalabroni (Hans lo Sparviero), Angelo Zazzetta ( doppia parte:
Anastasio, giardiniere di Pan e il Borgomastro), Wanda Filippucci (Nadia),
Domenico Agostinacchio (Segretario del Borgomastro). La prima ballerina
della compagnia, Dopolavoro aziendale società Cementi Scarfiotti,
era Licia Spedaletti. Presero parte alle danze e ai cori ben 46 tra
bambine e ragazze e 26 bambini e ragazzi. Direttore artistico, Quirino
Laccetti del Circolo Mussolini di Ancona; direttore e concertatore d’orchestra
(15 professori!) Fernando Piangerelli; al piano Vera Romagnoli; scenari di
Fede Costante della Scala di Milano; vestiti d’epoca confezionati dalla
ditta di Anna Medori. Prezzi: primi posti lire 4, secondi lire 2,50,
galleria lire 1,50. Non compare il nome del regista.
Foto n° 12. La piccola olandese fu
rappresentata al Teatro Littorio (il Kursaal) il 5 e 6 giugno 1937. Si
tratta di un’operetta di Romolo Corona (parole e musica) interpretata da
Alina Spedaletti nel ruolo di Liliana, Aureliano Doffo (Pan Pan Tulipan,
zio di Liliana), Fedra Macellari (Violet), Luigi Castellani (Dik),
Raffaele Scalabroni (Hans lo Sparviero), Angelo Zazzetta ( doppia parte:
Anastasio, giardiniere di Pan e il Borgomastro), Wanda Filippucci (Nadia),
Domenico Agostinacchio (Segretario del Borgomastro). La prima ballerina
della compagnia, Dopolavoro aziendale società Cementi Scarfiotti,
era Licia Spedaletti. Presero parte alle danze e ai cori ben 46 tra
bambine e ragazze e 26 bambini e ragazzi. Direttore artistico, Quirino
Laccetti del Circolo Mussolini di Ancona; direttore e concertatore d’orchestra
(15 professori!) Fernando Piangerelli; al piano Vera Romagnoli; scenari di
Fede Costante della Scala di Milano; vestiti d’epoca confezionati dalla
ditta di Anna Medori. Prezzi: primi posti lire 4, secondi lire 2,50,
galleria lire 1,50. Non compare il nome del regista.
 Foto n° 13. Una foto fornitaci da Roberto
Attaccalite, dove compaiono parecchi membri della sua famiglia, ben
noti ai portorecanatesi. Siamo intorno al 1930: in piedi con il badile Nazzareno
Attaccalite, a fianco in bicicletta Guerrino Attaccalite, sul
carro di destra Arnoldo Attaccalite con a fianco il bambino Tommaso
Palanca (zì Rutulì), sul carro di sinistra Romolo Attaccalite,
sull’automezzo del Comune adibito al trasporto della nettezza urbana c’è
Perna e sulla motocicletta el Paò Foto n° 13. Una foto fornitaci da Roberto
Attaccalite, dove compaiono parecchi membri della sua famiglia, ben
noti ai portorecanatesi. Siamo intorno al 1930: in piedi con il badile Nazzareno
Attaccalite, a fianco in bicicletta Guerrino Attaccalite, sul
carro di destra Arnoldo Attaccalite con a fianco il bambino Tommaso
Palanca (zì Rutulì), sul carro di sinistra Romolo Attaccalite,
sull’automezzo del Comune adibito al trasporto della nettezza urbana c’è
Perna e sulla motocicletta el Paò
 Foto n° 14. Un altro complesso, mitico dell’immediato
dopo guerra, il Rampioni 06. Foto n° 14. Un altro complesso, mitico dell’immediato
dopo guerra, il Rampioni 06.
Da sx a dx: Franco
Medori, Pietro Pierini, Giovanni Rampioni, Giuseppe Nicoletti, Armando Attili, Bruno
Benedetti, Oreste Gonnelli e Dino Fabbracci. La foto è di Renzo Bislani.
 Foto n° 15. La polizza di assicurazione riservata
ai militari combattenti nella prima guerra mondiale, stipulata per 500
lire da Crispino Castellani, imbarcato sulla regia nave Misurata, a favore
della sorella Maria. Foto n° 15. La polizza di assicurazione riservata
ai militari combattenti nella prima guerra mondiale, stipulata per 500
lire da Crispino Castellani, imbarcato sulla regia nave Misurata, a favore
della sorella Maria.
Siamo al primo gennaio 1918. In basso a sinistra, tra
le altre, la firma del Ministro del Tesoro Saverio Nitti.
Il documento ci
è stato fornito da Giuliano Tiseni.

|
| |
|
Una
poesia di Emilio Gardini - (‘sta sera) (di
Lino Palanca)
Fedele all’idea che poesia significa soprattutto
felice incontro tra ispirazione e possesso dello strumento linguistico nel
quale si sceglie di esprimersi, è così armato che affronto un testo di Emilio
Gardini, poeta dialettale scomparso sei anni fa.
Si tratta di "‘sta sera", trentadue agili
versi inseriti in Pe’ nun ‘mmalàmme de nustalgia,
volume di poesie edito a Porto Recanati nel 1988, contenente 27 splendide
composizioni liriche prefate dal sottoscritto.
Il testo:
‘Sta sera
el maru
se èste
de turchinu |
|
drentu
de me
c’è el neru
de la notte |
so’
da per me
tra i sassi
giò le bòtte |
|
senza
gnisciuna
che me sta
‘icinu… |
La luna
fa ‘na strada
a ‘na
paranza… |
|
de mille
perle,
che nun fenisce
mai, |
tutti
da longu,
gnisciuna,
cume mai? |
|
ma quella
luce
me dà
tanta speranza. |
Struttura agile, abbiamo scritto; le strofe sono di
quattro versi di lunghezza variabile, da un minimo di una sillaba a un
massimo di cinque, senza un ordine logico perché così, è evidente, ha
voluto l’autore.
La strofe introduttiva ci porta di fronte al mare che
va vestendosi di azzurro cupo; quindi non è ancora notte, fuori; lo è
nell’animo del poeta, che, solitario, passeggia a ridosso della
battigia. La notte è illuminata dalla luna i cui raggi disegnano una
strada di perle percorsa da una barca. E’ una luce che invita a guardare
con più fiducia all’avvenire.
Quattro delle otto strofe (seconda, terza, quarta e
settima) sono dominate dal sentimento della solitudine; la prima strofe ci
colloca nel momento della giornata, la sera, che più di ogni altro si
presta agli esami di coscienza; la quinta, sesta e ottava fanno sorgere da
uno dei più suggestivi spettacoli offertici dal creato, dal gioco di luce
originato dai riflessi della luna sul mare, un’altra luce, questa
interiore, che parla di speranza.
La solitudine, dunque. Questo sentimento è
sottolineato dal neru de la notte dei versi 7 e 8, dalla locuzione da
per me (v.10), dall’insistenza sull’indefinito gnisciuna (vv.
14 e 27) ogni volta accompagnato da constatazioni dolorose (gnisciuna
che me sta ‘icinu….tutti da longu).
A ben guardare si tratta di una costante della poesia
di Gardini, il timore di restare da solo, di non avere il conforto degli
amici che gli testimonino affetto, solidarietà, sostegno.
Dietro il sorriso bonario di tanti quadretti di vita
paesana, accanto all’osservazione arguta, ironica e sovente mordace che,
pure, costituisce parte non secondaria della poetica di Emilio, sporge
sempre lo sguardo che cerca di penetrare il vuoto alla ricerca del punto
di riferimento, della faccia amica, della mano tesa. Come il gabbiano di
Montale (quante volte è passato nei cieli delle fantasie di Gardini il cucàle!),
che è destinato a volare sempre più in là.
Ed è con marcato stupore che il poeta, resosi conto di
essere davvero solo e nudo di fronte al mistero della vita, sorte che ci
accomuna tutti, sussurra come smarrito quel cume mai? (v. 28) che
da solo riassume e illumina il senso vero della lirica: il tormento del
dubbio che corrode le facili certezze di cui ci facciamo corazza, la presa
d’atto della precaria condizione umana e di un destino arduo che nessuno
può affrontare al nostro posto.
Una domanda semplice, cume mai?, che evoca il
ricordo dell’anziano di Fellini in Amarcord, solo in mezzo alla
nebbia, senza amici né donne né vino, che si chiede sgomento se quella
è la morte e risponde a se stesso col deciso gesto di rifiuto mutuato da
un altro personaggio del grande riminese, Cabiria.
Ma non tutto qui è il pensiero di Gardini, ché non
vanno mai dimenticate le sue convinzioni religiose, le sue radici
cristiane. Ce lo ricorda lui stesso, dopo il viaggio au bout de la nuit,
ai confini della notte; in fondo al tunnel c’è la speranza,
simboleggiata dalla striscia di liquide perle, un’immagine di
straordinaria pregnanza, struggente desiderio d’infinito.
Non, però, la speranza di umano riscatto o di gioia
terrena, bensì la Speranza che scende di Lassù.

|
| |
|
Lo
scoutismo a Porto Recanati - 35 anni di storia (1^ parte)
(di Alberto Giattini)
Quando don Ennio Borgogna nel 1965 decise di portare la
sua esperienza di scautismo a Porto Recanati con l’aiuto del fratello
Vinicio e di pochi giovanissimi ragazzi inesperti, sapeva quello che
faceva. Altrimenti dopo 35 anni di attività non staremmo ancora parlando
del Gruppo Scout, l’associazione giovanile portorecanatese non sportiva
più longeva.
Quei ragazzi che nel 1966 partirono per un campeggio da
fare in tenda, con una strana uniforme che nel mese di luglio prevedeva
una camicia a maniche lunghe ed un fazzolettone al collo e d’inverno
invece era dotata come d’estate di pantaloni corti era sicuramente un po’
strana. Ma i valori che essa testimonia tutt’oggi sono sicuramente più
profondi di quello che lascia intravedere.
Calcara di Ussita ospitò il primo campo estivo, ne
seguiranno molti altri.
Don Ennio trovò quasi subito la collaborazione di
Giampiero Celestini, nipote dell’allora parroco don Nello Galeani e già
conoscitore dello scautismo per esperienze effettuate all’estero.
Giampiero rimase fino al 1968 quando gli subentrò
Gianluigi Bufarini che nel frattempo aveva seguito le orme di suo fratello
più giovane Claudio. L’anno precedente sempre Don Ennio diede vita, con
l’aiuto del giovanissimo (allora) Fiorenzo Piangerelli ai lupetti. Chi
scrive ebbe la pessima idea di aderire subito per rimanere poi incastrato
per ben 27 anni.
Il gruppo si completò nel 1970 con la terza fascia d’età
prevista dal metodo educativo scout, i rover (giovani over 16); come Capo
si chiamò un "esterno", Carlo Pesco, che diventerà una colonna
dello scautismo marchigiano e nazionale, attualmente Sindaco di Camerano .
Nel 1969 si effettuò il primo censimento (iscrizione
ufficiale all’Associazione) all’ASCI (Associazione Scouts Cattolici
Italiani) ufficializzando il Gruppo.
L’entusiasmo e l’impegno di Gianluigi, associato
alla razionalità ed alla competenza pedagogica di don Giancarlo Manieri,
che dal 1970 divenne il nuovo Assistente Ecclesiastico del Gruppo,
portarono lo scautismo portorecanatese ad avere un impatto di grosso
successo sui giovani, completato dal lavoro fatto da Fiorenzo e Carlo con
le rispettive fasce di età. Si nominò inoltre il primo Capo Gruppo,
Renato Giri.
Tale impegno determinò, all’interno dell’ASCI, una
maggiore considerazione della nostra realtà in ambito provinciale e
regionale tanto che sia Fiorenzo che Gianluigi furono chiamati, per
elezione a ricoprire ruoli di quadri in tale ambito.
Partecipando al Campo Estivo Provinciale del 1971
infatti si arrivò primi nelle varie competizioni ex-aequo con Civitanova
Marche, mentre l’anno successivo a Val Formazza (NO), sempre ad un Campo
Provinciale, sbaragliammo tutti per competenza e stile. Erano valori
allora molto sentiti, così come era consuetudine organizzare competizioni
durante le attività in modo da stimolare l’impegno; sono metodi oggi
passati in disuso nelle attività educative dove si preferisce che ognuno
gareggi con sé stesso. Cambiano i mezzi ma i fini sono sempre gli stessi.
Il 1972 vede anche la nascita delle coccinelle e guide,
ad opera di don Enrico Migliavacca, allora parroco. Livia Batkowski e
Liliana Barchiesi saranno rispettivamente le prime capo.
Altro evento importante del 1972 la nascita della prima
squadriglia nautica, i Cormorani.
Rimarranno nella "clandestinità" per tre
anni in quanto non aderirono alla associazione femminile allora esistente,
ma aspetteranno la fusione delle due associazioni nel 1975 da cui nacque l’AGESCI.
Il 1974 vide la partecipazione degli esploratori
(ragazzi di 12-16 anni) al Campo Nazionale al Lago di Vico; 6000
partecipanti con i nostri nel sottocampo nautico a navigare con gruppi
più esperti nelle attività nautiche, ma secondi a nessuno nelle altre
attività scout.
Terminato quel Campo si iniziò subito a lavorare per
il decennale che sarebbe caduto l’anno successivo. La scelta del posto
fu dettata dal suggerimento di un genitore conoscitore dei luoghi: era un
luogo incontaminato dove l’unica struttura in cemento, a parte le poche
case, era costituita da una diga di sbarramento. Era il Lago di Campotosto
(AQ) a1300 m di altitudine.
Partecipammo entusiasti, pur con tutte le difficoltà
organizzative (eravamo tutti presenti dai lupetti ai Capi) Fu immane la
fatica di portare tutto il materiale in riva al lago, con i lupetti e le
coccinelle sistemati all’asilo di Mascioni. Era presente anche il medico
del Campo (il dott. Pio Senigagliesi) che con un gruppo di genitori
campeggiava poco distante.
A completare il quadro il Gruppo N.G. (Nuova
Generazione), gruppo spontaneo di giovani dell’oratorio, nuovo a questo
tipo di esperienze.
Alla conclusione del campo un capretto ed un agnello
interi finirono "per sbaglio" su di uno spiedo e due enormi
bracieri per soddisfare l’appetito al termine delle nostre fatiche.
Superato il 1° Campo di Gruppo si cominciano a
delineare i primi sostanziali cambiamenti. I Capi che fino ad allora
avevano, con molto entusiasmo, tirato la carretta si trovano nelle
condizioni di dover allentare o di cominciare a pensare di dover mollare,
chi per motivi di servizio militare, chi per motivi di lavoro o
matrimoniali.
Nel settembre del 1977, durante una riunione-uscita
fatta a Seeonee, si discusse profondamente il problema. Avviene un cambio
generazionale quasi completo: lasciano Fiorenzo, Livia, Liliana, Giacomo
Borsella, Claudio Bufarini, Vincenzo Toccaceli, Enrico Traversa, Lorenzo
Caporaletti e Renato Giri. Verranno sostituiti da pochi giovani e forse un
po’ incoscienti Capi: oltre al sottoscritto iniziano quella che per
molti si rivelerà una splendida avventura Rosina e Teresa Zaccari e
Sandro Moriconi coadiuvato con le coccinelle da Elena Omelli. A garantire
la continuità rimangono Gianluigi, Angelo Giri e don Giancarlo. Come Capo
Gruppo viene chiamato un genitore, Nino Di Giovanni.
Venne chiuso un ciclo, ricco di soddisfazioni e
sicuramente valido sotto il profilo dei frutti, visto che nella
successione, anche se i Capi erano ancora molto giovani, venne garantita
l'attività in tutte le sue espressioni, senza interrompere nessuna delle
fasce di età. Inoltre, sulla scia di tale impegno nel 1977 viene
raggiunto il maggior numero di iscritti, 168; rimane a tutt'oggi un numero
ineguagliato.
L'anno successivo ai Campi Estivi non ci saranno grosse
defezioni da parte dei ragazzi, segno che i genitori ripongono la loro
fiducia in quei giovani di belle speranze che hanno l'ardire di portare
fuori i loro figli.
Gli anni a seguire, a cavallo tra i due decenni '70-'80
vedranno qualche altro avvicendamento, ma la Comunità Capi rimarrà
fondamentalmente compatta ancora per qualche anno. Si verificherà invece
a fine anni ‘70 un calo di iscritti, inevitabile sia per la minore
esperienza di chi subentrava, sia perché i cambiamenti portano comunque
qualche scompenso, la flessione sarà tuttavia seguita negli anni a venire
da un incremento.
In quegli anni purtroppo si verificheranno degli eventi
tristi, tra il '78 e l'83 ci lasceranno ben tre cari amici e fratelli in
tante avventure, Giuseppe Senigagliesi, Enrico Traversa e Giuseppe
Crescenzi. Tre tragici incidenti li riporteranno alla Casa del Padre
proprio in un momento importante della loro vita. Rimarranno per sempre
nei nostri cuori.
Tra le attività di maggiore spicco, a fine anni
settanta, ricordiamo l'intervento (2 campi) in Friuli per il terremoto nel
'76, l'inizio grazie a Rosina, Fiorenzo Castellani e don Giancarlo della
Via Crucis in Pineta organizzata da lupetti e coccinelle nella Settimana
Santa del '79 che ancora si ripete e il ritorno a distanza di 5 anni al
Lago di Campotosto per il Campo degli esploratori e delle guide.
Nell'80 Teresa lascia, anche se per poco il Gruppo e
Rosina la rileverà nella conduzione delle guide. La novità è che Rosina
si attiverà per portare le guide ad aprire la prima squadriglia nautica
femminile nel giro di un anno.
Intanto nel reparto maschile si inizia a dare spazio ad
un giovanissimo trombettiere che mette a disposizione la sua passione
nelle attività, in particolare ai Campi Estivi dove le giornate saranno
scandite per almeno 4 anni dalle "sveglie" e i
"silenzi" che Davide Crescenzi suonerà con la sua tromba. Avrà
miglior fortuna in seguito.

|
| |
|
Le
opere pubbliche da 1944 al 1956 (parte prima)
(di Aldo Biagetti)
Il 1° luglio del 1944, le truppe polacche del Generale
Anders, facenti parte della VIII° Armata Britannica, dopo una breve
sparatoria contro reparti di retroguardia dell’esercito tedesco,
superano il Fiume Potenza ed alle prime luci dell’alba entrano a Porto
Recanati, quasi del tutto deserta. Come già attuato altrove, e talvolta
con estrema violenza seminando terrore e morte nelle zone che stanno per
essere investite dalle operazioni belliche, il Comando Tedesco,
considerando Porto Recanati uno snodo di rilievo per traffico stradale e
ferroviario, aveva imposto - fin dai primi di maggio - lo sgombero totale
del paese. La cittadinanza si era rovesciata subito nelle vicine campagne,
intasando non solo le case coloniche ma anche ogni magazzino, aggravando
una situazione già resa precaria per il forzato esodo della popolazione
di Ancona, colpita da continui e pesanti bombardamenti.
L’Amministrazione Comunale aveva dovuto abbandonare gli uffici del
Castello Svevo e trascinandosi dietro, con mezzi di fortuna, archivi e
registri si era precariamente sistemata nella Scuola Rurale del Chiarino
ed in locali viciniori, con ovvio notevole disagio per tutti quanti
avevano necessità di accedervi. Il Podestà Michele Volpini, dopo aver
retto la carica per otto anni, si era dimesso ed era subentrato, come
Commissario Prefettizio, Gino Incerti, funzionario della Fabbrica
Montecatini, fabbrica non in attività come ogni altra industria per
problemi conseguenti alle vicende belliche.
Ritornata la Civica Amministrazione, con l’arrivo degli Alleati, al
Castello Svevo il 20 luglio il giovane avvocato Camillo Pauri, della
Democrazia Cristiana, indicato dai Partiti del Comitato di Liberazione
Nazionale (C.L.N.) riceve dal Prefetto la nomina a Sindaco. La situazione
in cui versa il paese è particolarmente critica e si sottolinea :
- non funzionano gli acquedotti (quello principale, a gravità,
proveniente da Montelupone - erogazione 5/6 litri al secondo - ha avuto le
condotte danneggiate dai tanti bombardamenti; quello integrativo, a
sollevamento - 2 litri al secondo - è inattivo da tempo per problemi
connessi con la situazione bellica), la gente fa pertanto la fila , dall’alba
al tramonto, nel cortile dei magazzini dei Conti Lucangeli per attingere l’acqua
da un pozzo artesiano, con comando a ruota;
- manca totalmente la corrente elettrica (si cerca di supplire nelle case
con lanterne a carburo, le vie sono totalmente buie, ma i cittadini vi
sono abituati perché dall’inizio della guerra vi era il totale
oscuramento);
- per carenza dei mezzi di trasporto (mancano gomme e carburanti) arrivano
saltuariamente molti generi alimentari, compresi pure quelli tesserati, si
fa quindi travagliato ricorso al mercato nero ed ora a qualche particolare
elargizione delle truppe alleate, che hanno tutto (viveri, sigarette,
coperte, benzina, ecc.) con grande dovizia;
- le fogne funzionano male, con numerosi tratti intasati o rotti;
- le strade, danneggiate dai pesanti mezzi cingolati dei due eserciti,
sono piene di buche, avvallamenti e detriti e pure di rifiuti e gli
spazzini, pochissimi, non hanno nemmeno scope idonee; le fabbriche, come
già detto, sono chiuse, come numerose attività artigianali.
L’Amministrazione Comunale, pur con scarsissimi mezzi
e risorse, affronta e cerca di risolvere le più impellenti necessità
della popolazione e pertanto:
- sollecita di continuo la sede UNES di Ascoli Piceno per il ripristino
dell’erogazione della corrente elettrica;
- incarica la Ditta Grenci Carmelo di rappezzare le tubazioni dell’acquedotto,
ma i risultati non possono essere che a breve termine;
- sgombra le strade ed avvia la raccolta dei rifiuti con attrezzature
improvvisate e durante l’inverno cerca di lenire i problemi del
riscaldamento abbattendo diversi alberi delle vie cittadine, onde poter
distribuire un po' di legna alle famiglie più bisognose.
Il 16 giugno 1945 Romolo Matassini, della Democrazia
Cristiana, insegnante, subentra a Pauri nella carica di Sindaco. Deve
affrontare gli stessi problemi del suo predecessore (alcuni riesce a
portarli a termine inviando funzionari a Roma, che viaggiano in treni con
finestrini tutti rotti, per ottenere - dai vari Ministeri - buoni di
prelievo per viveri (patate, sale) e carbone. Ritornata poi la corrente
elettrica le vie sono di nuovo (modestamente) illuminate, le fabbriche si
riorganizzano e molti operai tornano al lavoro. Completate le riparazioni
dei due acquedotti si può ripristinare l’erogazione dell’acqua
potabile, ma in misura inadeguata alla richiesta e per improvvise
aumentate esigenze e per la possibilità di usufruire di consumi
incontrollabili per mancanza di contatori non reperibili sul mercato.
Con le elezioni del 10 marzo 1946, le prime libere dopo
oltre venti anni, si ha la vittoria della lista di sinistra "Fronte
di Unità Popolare", formata da socialisti, comunisti ed
indipendenti. Nel lasciare la carica Romolo Matassini, con un pubblico
manifesto, "pur rammaricato non avendo il mio partito raggiunta l’auspicata
vittoria lascio tutti con animo eguale" formulava alla nuova
Amministrazione i più sinceri auguri per un proficuo lavoro nell’interesse
di tutti i cittadini.
Il 24 marzo i 20 consiglieri eletti (16 della maggioranza e 4 della
minoranza, si è votato con il maggioritario) si adunano al Teatro Kursaal
per procedere alla nomina del Sindaco e degli Assessori.
Vengono eletti:
- Sindaco, con 19 voti, Goffredo Jorini, socialista, reduce da una lunga
prigionia nei campi nazisti, ventinovenne;
assessori effettivi:
Simone Giorgetti, socialista; Francesco Feliciotti, comunista, come
pure Francesco Frittella e Vittorio Monarca
assessori supplenti: Igino Montanari socialista e Camillo Pauri,
indipendente
Veniva affrontato subito il problema della
disoccupazione ed eseguiti, con procedure d’urgenza e con il contributo
di Enti e di cittadini facoltosi, lavori di sistemazione delle strade di
campagna fortemente dissestate. Nella delibera consiliare n. 29/6 del 12
agosto 1946, in relazione ad un concerto di Beniamino Gigli si rileva:
"Il Consiglio ringrazia il Grand. Uff. Beniamino Gigli che terrà un
concerto vocale il 18 c.m. in quest’Arena, dal quale la popolazione di
Porto Recanati ritrarrà i mezzi necessari per l’assistenza
invernale..." -
In un atto di poco precedente il Comune aveva ritenuto di fare il punto
sulla situazione lavorativa locale che così si presentava:
Fabbrica Cementi 93 operai, fabbrica Concimi chimici 95, Cantiere Navale
Gardano Giampieri 11, Cipra 11 e Prodotti in cemento 26.
In quel periodo il Comune aveva alle sue dipendenze 39 persone, tra
impiegati, salariati vari, custodi, comprese tre impiegate all’Ufficio
Annona - vigendo ancora il tesseramento -, due medici (Guido Mazza ed
Alighieri Pettorossi), una levatrice e due bidelli delle Scuole
Elementari.
Per potenziare il rifornimento idrico il Comune da incarico ad un
professionista di notevole competenza, il Prof. Ing. Monte Giamboni di
Roma, sessantacinquenne, della ricerca di nuove vene acquifere in tutto il
territorio e di effettuare, per una spesa di £. 2.500.000, le necessarie
trivellazioni (fino a mt.44 di profondità per prelevare acqua da falde
non inquinabili) e di procedere poi alla progettazione definitiva di un
nuovo acquedotto, compreso un secondo serbatoio di raccolta ed una
adeguata rete di distribuzione. Nel contempo viene fissato in £.500 annue
il canone per le abitazioni, a libero consumo.
Si pongono contemporaneamente allo studio i mezzi per reperire più
sostenute risorse finanziarie. Si recupera la gestione diretta delle
Imposte di Consumo (il dazio), in effetti una delle maggiori entrate
comunali, si risolve la vertenza dell’affitto dell’Albergo Arena con
il sig. Gabriello De Bellis, portando il canone annuo da £.8.000 a
£.150.000, avendo anche rinunciato il De Bellis alla gestione del Caffè
Ristorante Lido (ex-Littorio), che ritorna al Comune. Si avviano pure le
procedure per passare allo Stato l’onere della Scuola Media (Preside
Prof. Augusto Pauri), ora a totale carico del Comune. Per detta scuola,
abbandonando i locali concessi in affitto da Santiago Bufarini, in Via
Cavour, si appronta una nuova sede: l’intero primo piano dell’ex-Casa
del Fascio, completamente restaurata dopo i danni che l’immobile ha
subito con il passaggio del fronte e la successiva occupazione da parte
delle Truppe Alleate.
Approfittando di una manifestazione ostile al gestore
del Cinema Kursaal (Remo Franchini di Ancona) da parte di numerosi
cittadini, più o meno programmata, il Comune recupera la piena
disponibilità della sala e pure dell’Arena Gigli, ciò consentirà, a
parte il sensibile apporto finanziario, l’uso di interessanti strutture
per manifestazioni artistiche e culturali. Per gestire queste attività il
Consiglio Comunale (riunione del 28/2/47) istituisce un apposito servizio
con autonomo bilancio e nomina il personale occorrente come appresso:
Ermanno Bandini, responsabile; Domenico Porfiri, operatore, Simone
Giorgetti e Umberto Grilli maschere, Giovanni Flamini bidello. E delibera
pure di affrontare tutte le spese occorrenti per: acquisto macchina
cinematografica (£. 1.500.000), di 1500 sedie per l’Arena; fornitura
mobili ed adeguamento e sistemazione dei locali; rivestimento in populit
sala cinema per "migliorare l’acusticità".
L’Amministrazione Comunale elabora poi un vasto
programma di opere pubbliche, da realizzare in gran parte a totale carico
dello Stato, come danni di guerra, o con contributi governativi, a mente
delle leggi vigenti. Ma a questo punto è doveroso precisare che Porto
Recanati è uno dei sei comuni rossi (cioè con amministrazioni di
sinistra) della Provincia di Macerata - e di certo uno dei più
significativi - e trova quindi (siamo entrati nel clima e nel periodo
della guerra fredda) una forte preclusione ministeriale per accedere ai
benefici erariali. Non solo, è soggetto pure a periodici, minuziosi ed
estenuanti controlli da parte di ispettori governativi, totalmente
risparmiati alle Amministrazioni Comunali di altro indirizzo politico. Ma
il Comune trova dei santi protettori in due funzionari statali di elevato
rigore morale e di apprezzate e riconosciute capacità professionali che,
pur distanti per sensibilità politica, sono sempre disponibili per
consigli, suggerimenti, indicazione delle vie e delle procedure più
idonee per richiedere e reperire finanziamenti statali, nei più disparati
articoli e meandri dei bilanci governativi, e qui li si vuole ricordare.
Sono: il dr. Giovanni Ciurciola, Dirigente della Divisione di Opere
Pubbliche della Prefettura di Macerata, classe 1917, di area cattolica,
con due fratelli salesiani e che l’8 luglio di quest’anno è stato
premiato, nel salone del Castello Svevo, al Premio Internazionale di
Poesia e l’Ing. Paolo Calogero, classe 1908, di tendenze fortemente
liberali, Responsabile - all’Ufficio del Genio Civile - di tutte le
opere pubbliche da Macerata al mare; appassionato di musica operistica
Calogero fu uno dei più attivi nel riportare, a grandi livelli, le
stagioni d’opera allo Sferisterio.
Vengono ora demoliti i tre ricoveri antiaerei e i
vecchi lavatoi pubblici, restaurata e migliorata la Pescheria Comunale,
asfaltato il Lungomare, sistemate le Scuole Elementari (con banchi nuovi
in tutte le aule), realizzato un ponticello ad una corsia (per la
contenuta spesa di £.6.000.000 ammessa a contributo statale) sul Fiume
Potenza in sostituzione di una vecchia struttura in rovina, riprese la
Torre Civica e le Mura Castellane.
Poi all’improvviso un colpo di fortuna che avrà per diversi anni peso e
ripercussioni nella vita cittadina e che porterà alla ristrutturazione di
una "palestra" ed alla costruzione di un’altra in Via Bramante
E’ una storia che nasce quasi per caso in un mite pomeriggio domenicale
di metà novembre del 1947. Reolo Rapaccini, un anconetano estroverso,
chiassoso ed esuberante, giornalista, arbitro di incontri di pugilato per
dilettanti, è in Piazza Brancondi per accedere all’Ufficio Telefonico
onde dettare, al suo giornale, il resoconto della partita di calcio da
poco terminata al Nazario Sauro. Si imbatte qui con Luigi Rabuini,
ragioniere del Cementificio Scarfiotti grande appassionato di sport,
dirigente della nostra società calcistica, fondatore, Presidente ed unico
finanziatore della locale Accademia di Pugilato (ha portato due giovani al
massimo titolo italiano della categoria), organizzatore di incontri di box
anche di elevato livello (come l’Amanini-Battaglia, dell’estate
precedente, semifinale per il titolo italiano dei medi, svoltosi in un’Arena
gremitissima). Reolo s’infiamma: "Gigetto proprio te cercavo, ho
incontrato ieri in Ancona, presente Cinti (1), Steve Klaus (2) e
Montefredine (3), stanno ancora cercando una sede idonea per gli
allenamenti della nazionale per le Olimpiadi. Cosa ne pensi?. Gigetto non
ha dubbi : come Palestra si potrebbe utilizzare la vecchia sala
cinematografica adiacente al cortile delle Scuole Elementari, dove da
tempo, con tanta buona volontà si allenano i suoi ragazzi, come alloggio
è di certo confacente l’Albergo Arena, lasciato libero dalle truppe
alleate e già bene risistemato rapidamente dal Comune, e sprona Rapaccini
ad invitare i due responsabili nazionali, con Cinti, a Porto Recanati, per
un sopralluogo e chiusura finale con un buon brodetto da Bianchi.
Dopo una settimana Steve Klaus e Montefredine sono a Porto Recanati, l’allenatore
federale è subito entusiasta, in America ha allenato - afferma - tanti
campioni in riva ai grandi laghi salati. qui vi è il mare, quindi sabbia
ed iodio, la cittadina è tranquilla, non vi sono pericolose distrazioni,
il locale da adibire a Palestra con le realizzazioni necessarie può
andare bene, l’Albergo anche. Pure il cibo è ottimo (questo a
conclusione di un lauto pranzo offerto da Gigetto). I due responsabili
federali partono assicurando che daranno presto notizie che saranno di
certo positive, ed infatti dopo una decina di giorni arriva la richiesta
ufficiale della Federazione, rivolta al Comune, così articolata:
a) Per la Palestra, una descrizione dettagliata di tutte le opere
necessarie (docce, spogliatoi, sala massaggi, ecc.) con possibilità di un
congruo contributo da parte della Federazione ad opere ultimate secondo le
modalità indicate.
b) Concessione della Palestra per una esclusiva disponibilità da parte
della Federazione.
c) Albergo Arena, impianto di riscaldamento per almeno un piano oltre il
piano terra.
d) Per terminare tutte le opere il tempo massimo non può superare i due
mesi.
Gigetto Rabuini, con i documenti in mano, corre a casa del Sindaco e la
macchina comunale si mette subito in moto. Appare evidente, sin dal primo
sopralluogo, che i lavori di sistemazione della Palestra sono
particolarmente onerosi (si deve intervenire anche sulla copertura, sugli
infissi, sugli intonaci, sugli impianti, ecc.) ma il Comune è deciso a
non perdere l’occasione. Vengono pertanto chiamate due imprese edili
locali, Gino Scarabotti e Giuseppe Montironi che, dividendosi il lavoro,
dovranno eseguire tutte le opere nei termini e tempi prescritti. La Giunta
Comunale, con atto n. 33/6 del 9/2/1948 delibera poi di effettuare i
lavori di sistemazione della Palestra (in effetti già iniziati) e di
concedere l’uso della Palestra stessa per la preparazione e per gli
allenamenti dei preolimpionici, atto che verrà ratificato dal Consiglio
Comunale.
Ultimati i lavori nei tempi stabiliti arrivano subito, da tutta Italia, i
pugili selezionati ed hanno inizio gli allenamenti sotto la guida di Steve
Klaus e dell’allenatore in seconda Natalino Rea, buon ex-pugile.
Collabora pure Egidio Mosca, un italo-americano, allenatore della locale
Accademia Pugilistica, richiesto nel 1946 da Gigetto Rabuini ad una
società maceratese. Mosca ha un modesto stipendio dalla Federazione che
Rabuini, sempre attento e disponibile, integra regolarmente ogni mese. I
pugili italiani s’imporranno alle Olimpiadi di Londra e per lunghi anni
Porto Recanati sarà la sede degli allenamenti della nostra nazionale
dilettanti in vista di tutte le competizioni internazionali e durerà
questo rapporto per una quindicina d’anni, fino a quando la Federazione
(Steve Klaus si è intanto ritirato) costruirà in una cittadina umbra una
propria sede per gli allenamenti. I pugili come ristorante, dopo una
concordata alternanza tra Bianchi ed il Torcoletto, scelgono, per banali
motivi, questo ultimo locale.
Per farsi allenare da Steve Klaus i più grandi campioni del pugilato
vengono periodicamente a Porto Recanati, talvolta con grande risalto sulla
stampa anche straniera, e ricordiamo fra i tanti Roberto Proietti, Manca,
Duilio Loi, Festucci, Mazzinghi, Nino Benvenuti, Lopopolo, ecc.
Subito nel 1950 arriva Tiberio Mitri, triestino, ventiquattrenne, campione
europeo dei pesi medi, che qui si allena per incontrare a New York, Jack
La Motta, titolo mondiale in palio. L’accompagna la giovanissima moglie,
triestina anche lei, Fulvia Franco, splendente Miss Italia. Vengono
ricevuti in Comune e festeggiati da cittadini ed associazioni, anche
perchè considerati gli alfieri di una città contesa e non ancora libera.
Ritorniamo ai lavori: il Consiglio Comunale, nella
seduta del 15 maggio 1948, precisa che l’Ente Comunale di Assistenza (l’ECA),
proprietario degli immobili dell’ex-Ospedale Civile e della Casa d’Isolamento,
ha solo una modesta rendita di £. 51.240 annue, in titoli di stato e
preso atto che le strutture "ospedaliere" erano già modeste ed
incomplete prima della guerra e che non è ipotizzabile attivare un vero
ospedale, decide di accettare l’offerta del dr. Valentino Zanella, pari
a £.350.000 per canone di affitto annuo. Tale cifra potrà consentire una
buona attività all’Ente assistenziale. Dato che i locali sono stati
fortemente danneggiati dal passaggio delle truppe e dagli sfollati, si
provvede con tutta urgenza e con l’intervento dello Stato, come danni
bellici, ad un restauro e sistemazione generale per un onere di
£.2.500.000.
Con verbale n.15/1 del 5 gennaio 1949 il Consiglio Comunale nomina il
nuovo Comitato dell’ECA., come segue: Giri Michele, Matassini Romolo,
Feliciotti Lucidio, Giri Carlo, Pettorossi Alighiero (verrà sostituito da
Gino Scarabotti), Scalabroni Valentino, Pulcini Nicola, Giri Antonio (che
emigra in America e viene sostituito da Palanca Giuseppe), Scarafoni
Luigi.
Un breve cenno ora su un lavoro modesto, anche come
entità: il Comune decide di convenientemente sistemare il locale all’angolo
sud-ovest del Kursaal, per due anni utilizzato come macelleria comunale.
La Civica Amministrazione aveva ritenuto opportuno, nel 1946, istituire e
gestire, in effetti direttamente, uno spaccio per vendita di carni (con
Andrea Leonardi al bancone e Cesare Felicioti, gestore, alla cassa) ma
superato il periodo critico delle restrizioni e del tesseramento si era
ritenuta esaurita tale iniziativa.
Il locale (vi era e vi è tuttora annesso un vano finestrato per deposito
ed un servizio igienico) non si trovava in buone condizioni ed anche per
il particolare impiego che s’intendeva farne - un ufficio per
informazioni turistiche - si rendevano necessari radicali restauri onde
assicurare all’ambiente funzionalità e decoroso aspetto (si realizzò
anche un’alta zoccolatura in legno con pannelli in tela, in gran parte
ancora esistente). Questa era la sede approntata per la Pro-Loco,
istituita dal Consiglio Comunale con delibera n.26/12 del 1°/2/1949; era
inoltre riportato in tale atto lo statuto del nuovo ente e la nomina di un
comitato provvisorio di gestione così composto:
Jorini Goffredo sindaco; De Bellis Gabriello albergatore; Bianchi Nicola
trattore; Giri Pasquale bagnino; un rappresentante del Circolo
Universitario; Bonanotte Giuseppe per la società sportiva e Pianella
Umberto commerciante.
Con l’istituzione della Pro-Loco il Comune intendeva liberarsi da tanti
numerosi impegni, specie durante il periodo estivo (manifestazioni
teatrali, mostre, feste popolari, tombole, serate danzanti all’Arena,
fuochi artificiali) che comportavano problemi di non semplice soluzione,
anche sotto il profilo amministrativo.
Durante il mese di luglio (del ‘49) un fulmine a ciel
sereno: l’acquedotto di Montelupone, pregevole opera d’inizio secolo
di un rinomato ingegnere, noto anche all’estero) improvvisamente
"muore". Non vi è più acqua nei quattro pozzi di captazione,
la falda (è di prima vena) si è esaurita. In Comune, assillati anche
dalle proteste di tanti bagnanti, che fanno coro con quelle dei residenti,
si arriva ad una decisione immediata: sfruttare il pozzo di prelievo,
realizzato proprio da pochi mesi con il 1° stralcio del Progetto Giamboni,
approntare una provvisoria centralina di sollevamento, inviare un camion
nel nord per prelevare dalle fabbriche mt.1500 di tubi mannesmann delle
sezioni rispondenti alle previsioni del nuovo progetto generale, superare
anche con mezzi di fortuna il Fiume Potenza e portare l’acqua nel
serbatoio di deposito di Montarice.
Le Ditte Giuseppe Papa e Carmelo Grenci danno subito inizio, con tre turni
di lavoro nelle 24 ore, allo scavo di mt.1400 di terreno ed alla posa
delle tubazioni come arrivano, Vincenzo Rocchetti realizza la centralina e
piazza una idonea pompa, il tutto viene completato in 18 giorni. A lavori
ultimati il Consiglio Comunale approva e delibera la spesa di
£.3.100.000.
Poi un altro colpo fortunato.
Beniamino Gigli, che ha cantato nuovamente all’Arena il 31 luglio, in un
concerto per beneficenza svoltosi dopo una grande corsa motociclistica
(vinta da Masetti), effettuata principalmente lungo la Strada Regina, per
festeggiare l’asfaltatura di questa importante arteria (per i lavori, £
60.000.000, il Comune ha versato un contributo di £.1.000.000), ha
significato al nostro Sindaco il desiderio di tornare a cantare un’opera
qui. Su richiesta di Gigli arrivano in Comune, per pareri e consigli, i
maestri Alfano (5) e Berrettoni, che concordano con i responsabili
comunali il programma della stagione lirica ed indicano agenzie per
contattare cantanti e professori d’orchestra e ditte specializzate per
scenari ed impianti, intendendo il Comune, per contenere le spese, gestire
il tutto direttamente. Ma il problema è il palcoscenico e le strutture
annesse (camerini e depositi e servizi), che versano tutte in condizioni
pietose perchè fortemente danneggiate dalle tante truppe che vi hanno a
lungo stazionato e da arbitrari "prelievi" di sfollati e di
ignoti.
Per il finanziamento e per le rituali autorizzazioni si corre in Ancona
dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per le Marche; di certo
Porto Recanati è un Comune amministrato dalle sinistre, ma il viatico di
Gigli scardina ogni resistenza, non si può impedire al più grande tenore
del mondo di cantare e per giunta a titolo gratuito. Il Provveditore, dopo
qualche attesa, è disponibile ad accollare al suo ufficio l’intero
onere dei lavori, chiede prima di visionare un progetto completo. Dopo una
decina di giorni si torna in Ancona con gli elaborati richiesti, va tutto
bene e per i tempi ormai ristretti il Comune è autorizzato alla
trattativa privata ed a condurre le opere.
Viene nuovamente chiamato Gino Scarabotti che. malgrado forti impegni,
accetta e da subito inizio ai lavori. Scarabotti, sessantenne, grande
appassionato di opera lirica, è venuto giovane a Porto Recanati da un
comune dell’Alto Maceratese, innamoratosi della figlia di un piccolo
imprenditore locale (Lorenzo Severini) abbandona gli studi a Roma e si
mette a lavorare alle dipendenze del futuro suocero, rilevandone la ditta
alla morte di questi.
Scarabotti non vedrà totalmente finito questo suo lavoro e l’imponente
palcoscenico rimesso a nuovo, i camerini e tutte le strutture. Preoccupato
perchè durante le ore notturne venivano asportati da ignoti i mattoni che
accantonava per la realizzazione di due palazzine gemelle che stava
erigendo in Via Biagetti si portava ogni sera, sul tardi, a segnare con
calce i materiali, come gli era stato suggerito. Anche la sera del 19
giugno si reca, ancora una volta a segnare i mattoni, poi, forse per
lavarsi le mani o per rinfrescarsi il viso, si porta in spiaggia ma qui
colto da improvviso malore cade esanime sulla riva.
Ultimati i lavori ed approntati materiali ed attrezzature per preparare le
scene numerosi operai e carpentieri ed artigiani accorrono all’Arena,
tutti disponibili a lavorare pomeriggio e notte - dopo le recite- pur di
poter assistere alle opere, prove comprese. Anche Guido Campanella si
porta all’Arena, assicura che fornirà tutti i mobili e gli arredi
necessari, lo ha fatto del tutto amichevolmente pure l’anno prima, per
una recita tra amici che in questo modo intendevano abbracciare e
festeggiare Antonio Mariolani, in partenza per la lontana Argentina. Per l’occasione
venne messa in scena, su un palcoscenico rabberciato, "La voce nella
tempesta" e Guido si esibiva in un applauditissimo assolo di violino.
Giovedì 13 luglio la stagione lirica inizia con l’Elisir d’Amore con
il grande Beniamino, con Rina Gigli, un veramente apprezzato soprano che
aveva cantato in diversi teatri , particolarmente con Ferruccio Tagliavini,
e con il basso Luciano Neroni (Dulcamara).
L’Arena, portata a 1800 posti, è quasi piena, un centinaio di persone
premono contro il portone di Via Loreto chiamando a gran voce, durante il
primo intervallo, "Beniamino aprici", e così avviene. Dopo una
recita del Barbiere di Siviglia (sabato 15 luglio), ostacolata da un vento
impetuoso si chiude la Domenica con una replica dell’Elisir, con gli
stessi cantanti e nuovo trionfo di Beniamino Gigli. Anche la figlia Rina
suscita entusiastici consensi, il suo cachet è stato concordato in
£100.000 a sera.
L’arrivo di cantanti ed orchestrali ha particolarmente movimentato la
piccola cittadina, che ancora si presenta con un centro urbano di
dimensioni paesane, circoscritto tra la Pescheria, la Caserma dei
Carabinieri, Via degli Orti, il Cementificio e Via Biagetti; la colonia
dei bagnanti è molto contenuta, e si va al mare dal Faro (all’inizio di
Castelnuovo) alla casa Lanari (all’altezza di Via P. Micca) e
principalmente nella mattinata. E’ semplice quindi familiarizzare con
cantanti e professori d’orchestra, talvolta sono gli stessi operai che
lavorano all’Arena che li accompagnano, accollandosi con disinvoltura i
bagagli, nelle case ove alloggeranno (non vi sono strutture ricettive di
sorta e l’unico Albergo è ovviamente al completo). Molte volte i
proprietari delle abitazioni all’uopo prenotate da tempo dall’organizzazione
chiedono ai loro ospiti solo dei biglietti d’ingresso, come
remunerazione. Gigli, lo ha fatto sempre, s’incontra e chiacchiera con
marinai e cittadini (ha un piede a terra nell’attuale Viale 1° Maggio,
subito a sud della casa Lanari) e gioca a carte con tutti. Durante le
prove si fanno lunghe soste al bar Arena di Ferruccio Lucchetti, che si è
fatto subito un gran nome per i suoi gelati.
Per farsi sentire dal grande tenore diversi giovani accedono l’Arena
ogni pomeriggio, Gigli è sempre presente, pur premuroso e cordiale è
categorico nei suoi giudizi. Invita pure nella sua fastosa dimora di
Montarice, costruita nel 1927, i cantanti e i responsabili del Comune e
della Stagione operistica. Ma sono convivi a corrente alternata tra la
chiassosa esuberanza di Luciano Neroni (purtroppo ormai al termine - ed è
solo quarantunenne - della carriera e della vita per l’improvviso
esplodere di un male incurabile) ed i contrasti continui tra il tenore e
la consorte Costanza Cerroni. Questa accusa il marito d’infedeltà e di
convogliare notevoli risorse finanziarie verso Lucia Vigarani, dimorante
allora a Roma (poi soggiornerà a lungo a Porto Recanati) con i tre figli
avuti dal tenore. I due coniugi si erano pure rivolti, per lumi e
consigli, a Padre Pio di Pietrelcina, il frate con le stimmate,
perseguitato dal S.Uffizio e da Padre Gemelli, che proprio in quegli anni
aveva dato inizio, con le offerte della gente, alla costruzione di un
enorme complesso ospedaliero, uno dei più importanti del Centro Sud. Ma
nemmeno le parole di Padre Pio, taglienti e precise, risolsero il grave
profondo contrasto.
NOTE
1 - Cav. Ottorino Cinti, per lunghi anni Presidente del Comitato
Regionale della Federazione Pugilistica Italiana, all’epoca residente in
Ancona, in Via Fazioli n.21
2 - Steve Klaus, di origine ungherese, emigrò giovanissimo negli Stati
Uniti, ove presto si affermò come allenatore di pugilato. Negli anni
anteguerra venne chiamato in Italia per allenare una società pugilistica
romana, poi divenne allenatore federale
3 - Avv: Giovanni Montefredine, responsabile del Comitato per la
preparazione dei nostri pugili per le Olimpiadi di Londra (agosto 1948),
fu poi il successore, quale Segretario Generale della Federazione
Pugilistica, del grande indimenticato Edoardo Mazzia, deceduto per
malattia il 10 luglio 1954, dopo oltre 30 anni di impegno al massimo
livello dirigenziale
4 - Gino Scarabotti, nato a Visso nel 1889, da Nazzareno, guardia
forestale e Paolina Paolucci, insegnante. Muore il 19/6/1950 sull’arenile
sud di Porto Recanati
5 - Franco Alfano (1875-1954), nel 1925 gli venne affidato il compito di
ultimare la stesura della Turandot sulla base degli appunti lasciati da
Puccini
6 - Giuseppe Taddei, nato a Genova nel 1916, notevole interprete di opere
liriche anche per l’abilità scenica e la chiarezza del fraseggio

|
| |
|
Documento 4
Un circolo repubblicano al Porto
Pietro Cavallari, deceduto non molti anni fa, aveva in
casa un documento prezioso attestante l’esistenza, alquanto travagliata
in verità, di un circolo repubblicano fondato a Porto Recanati nel 1913.
Di tale circolo il nonno di Pietro, Pietro anche lui ovviamente, era
segretario.
Possiamo darne testimonianza grazie alla squisita cortesia della signora
Jole Fabbrizzi Cavallari, moglie di Pietro, che ci ha permesso la
pubblicazione degli atti di quel sodalizio politico.
Soci fondatori
Bonaventura Scarafoni, Cittadino Cittadini, Gaetano Crocetti, Emilio
Budini, Lorenzo Michelini, Fortunato Scartozzi, Antonio Cionfrini, Pietro
Cavallari, Francesco Giorgetti, Francesco Riccetti, Enrico Riccetti,
Giuseppe Riccetti, Vincenzo Antognini, Pasquale Tabocchini, Marino Giri,
Vincenzo Giri, Pasquale Grilli, Armando Cittadini, Biagio Giri, Pio
Cittadini, Tullio Giacomo Genga.
Soci ordinari
Giovanni Velluti, Luigi Castellani, Michele Belardi, Giuseppe
Cittadini, Alessandro Rabuini, Luigi Tabocchini, Geremia Tabocchini,
Ettore Balloni.
Verbale del g. 8 febbraio 1913
Dopo vari accordi preliminari da un nucleo di amici è stata gettata
la base per la costituzione di un circolo democratico intitolato allo
illustre concittadino Attilio Valentini. Il dottor Scarafoni presenta uno
schema di Statuto sociale che viene letto e in massima approvato. Si è
poi proceduto all’elezione delle cariche sociali risultando eletti:
Presidente dott. Bonaventura Scarafoni, vice presidente Michele Belardi,
segretario Pietro Cavallari, vice segretario Pio Cittadini, sindicatori
Cittadino Cittadini – avv. Emilio Budini, cassiere Lorenzo Michelini.
STATUTO SOCIALE
Principi generali
art. 1. E’ fondato in Portorecanati un Circolo
politico intitolato all’illustre concittadino Attilio Valentini.
art. 2. Il Circolo, essenzialmente anticlericale e antimonarchico, ha
per iscopo chiaro e preciso di stringere in una salda ed omogenea
associazione tutti gli elementi popolari, affinché per mezzo di nozioni
semplici e pratiche possa formarsi nel paese quella coscienza politica
che è sinonimo di diritto e di giustizia sociale.
art. 3. La bandiera del Circolo porterà la scritta "Libertà e
progresso". Ogni socio adunque dovrà liberamente professare e
pubblicamente sostenere la propria fede di uomo libero e cosciente verso
ogni forma di giustizia, anche a prezzo di qualche sacrificio
individuale e famigliare.
Scopi particolari
art. 4. L’associazione convinta che il nostro paese
possa emanciparsi e rigenerarsi con le proprie energie popolari, rivolge
un caldo appello a tutti gli onesti e specialmente alla gioventù perché
nella più salda e cordiale fratellanza venga iniziata una vera crociata
contro l’affarismo e il clericalismo, i due tarli più sordidi dell’attuale
anima cittadina.
art. 5. Da molti anni il paese vegeta inquinato dalla prepotenza di pochi,
dal bigottismo di molti, dall’apatia di tutti. E’ necessario adunque
convenire che se lo scopo dell’associazione è intimamente politico, non
deve però trascurare gl’interessi vitali del paese sia vigilando in
tutto il complesso funzionamento amministrativo, sia cercando di abbattere
con lealtà ogni forma d’ingiustizia o di privilegio.
art. 6. L’associazione adunque non deve far soltanto opera di
sorveglianza, di critica e di demolizione, ma divenire pure istituto
operoso e fattivo per la conquista dei pubblici poteri, per poi iniziare
quella serie di riforme che la civiltà impone ad illuminati e (illeggibile)Amministratori
Mezzi pratici
art. 7. Primo fra tutti è il contatto reciproco:
vedersi e vedersi costantemente, affiatarsi, comprendersi significa:
apprezzarsi, amarsi, riuscir vincitori.
art. 8. Altri mezzi utilissimi poi sono: gli scritti, le conferenze, la
propaganda giornaliera; nei quali mezzi tutti deve però sempre aleggiare
la sincera e disinteressata affermazione delle proprie convinzioni, e non
mai la guerra alle persone, giacchè allora la lotta politica si
ridurrebbe ad un tristo episodio d’ignobile ambizione.
art. 9. Ma perché tutti questi mezzi di lotta riescano veramente pratici
ed efficaci, devono aver per base la divisione del lavoro, per modo che
ogni socio del circolo, assumendosi la doverosa relativa responsabilità,
diventi un piccolo centro di vigile catechismo per un determinato numero
di concittadini.
Cariche e quote sociali
art.10. La direzione del Circolo si compone di: un
presidente, un vicepresidente, un segretario, un vicesegretario, un
cassiere, due sindacatori.
art.11. I suddetti membri direttivi dureranno in carica un biennio e
potranno essere rieletti.
art.12. La quota d’ammissione al Circolo è di lire una: quella mensile
di centes. 50.
Disposizione transitoria.
Tutte le varianti al presente Statuto verranno di volta
in volta proposte e discusse in seno all’Assemblea generale dei Soci..
Verbale della seduta del 15 marzo 1913
Letto ed approvato il verbale della seduta precedente,
si verifica che il numero dei soci fondatori è quasi al completo giacchè
manca soltanto il Vice Presidente per causa di leggera indisposizione.
Dopo alcuni schiarimenti forniti dal Presidente sull’essenza e sulle
finalità del circolo, viene riletto, approvato e firmato lo Statuto
Sociale da tutti i soci fondatori presenti. E’ posta poi la discussione
sulla sede del Circolo.
Interpellato in proposito il socio Biagio Giri proprietario di un piccolo
locale situato nel centro del paese, si conviene con lui per un affitto
annuale con il pagamento mensile posticipato di £ 10 (dieci), previo
decente adattamento, ripulitura e impianto di luce elettrica. Dopo di che
la seduta viene sciolta rimanendo d’intesa di riunirsi la sera del 22
corrente nella sede nuova del Circolo.
Seduta del 29 marzo 1913 (presenti 17 soci)
Il socio Cavallari propone l’abbonamento a qualche
giornale di parte democratica da tenersi in permanenza nel locale sociale
a disposizione dei frequentatori. Vengono scelti l’Avanti e l’Iniziativa.
In merito all’indirizzo politico che il circolo dovrà seguire in
occasione delle prossime elezioni politiche, dopo animata e cortese
discussione, vengono prese ad unanimità le seguenti decisioni: 1) di
coadiuvare la possibile fusione dei vari blocchi popolari del Collegio e
prendere in tal proposito i preventivi accordi; -2) di cooperare nel modo
il più leale ed efficace alla riuscita in primo scrutinio del candidato
del proprio partito; -3) al momento del ballottaggio però di sostenere
con la stessa lealtà quel candidato di parte popolare che avesse
riportato maggior numero di voti. Letto ed approvato il verbale si
stabilisce di indire una nuova adunanza nel giorno (cancellato)
alle ore 20, allo scopo di prendere migliori accordi per la prossima
battaglia politica.
Adunanza del 10 maggio 1913 (presenti 16 soci)
Non riproduciamo il verbale perché vi si tratta di una
questione personale sorta tra il presidente Scarafoni e il
sindacatore Budini. Quest’ultimo si è dimesso.
Adunanza del 17 maggio 1913 (presenti 15
soci)
Il socio Giorgetti Francesco presenta la domanda
verbale per un socio nuovo sig. Tabocchini Luigi e viene accettata ad
unanimità. Preso atto delle dichiarazioni del dott. Scarafoni nella
seduta del 10 maggio 1913, i soci si sono riservati di sentire anche l’avv.
Budini e stabilire di discutere la vertenza nella prossima seduta del 31
corrente.
Adunanza del 2 giugno 1913.
Si discute solo della vertenza Scarafoni/Budini e si
conclude con un invito alla riappacificazione.
Adunanza del 21 giugno 1913 (3^ convocazione) (presenti
9 soci)
Il socio Cionfrini Antonio deplora che le adunanze
sociali siano poco numerose per modo da attestare il nessun interesse da
parte dei soci stessi. Propone quindi di mandare un invito ai soci non
presenti nel seguente tenore: "Egregio Consocio, da parecchie
adunanze molti soci trascurano il dovere di frequentare il circolo senza
alcun motivo specifico. Ti invitiamo a pronunciarti o per iscritto o a
trovarti nel locale del Circolo alla adunanza straordinaria che si terrà
il giorno 23 prossimo venturo alla ore 21, perché diversamente
significherebbe diserzione dalla nostra affermazione liberale, la quale
iniziata con tanto entusiasmo, sarebbe deplorevole finisse strangolata
nella culla. All’opera adunque, fede e coraggio sempre. La
Direzione". In seguito ad alcune osservazioni fatte dal socio
Giorgetti Francesco, viene deliberato che nella prossima adunanza venga
data una migliore e più esatta spiegazione alla dicitura del voto emesso
dal socio Cittadini Cittadino: "Che l’assemblea generale dei soci
non trovando alcuna gravità nel fatto personale tra il dott. Scarafoni e
l’avv. Budini, ritiene che in omaggio allo spirito dello Statuto
sociale, ogni divergenza venga pacificamente risolta per mezzo di comuni
amici.
Adunanza del 23 giugno 1913 (presenti
14 soci).
E’ data lettura della lettera di dimissioni per la 2^
volta dell’avv. Budini. Il Presidente chiarisce il concetto esposto dal
Giorgetti nella seduta precedente, con piena conferma del socio Cittadini
Cittadino, in merito al voto emesso da questi nel seguente tenore:
"Che l’assemblea generale dei soci non trovando alcuna gravità nel
fatto personale tra il dott. Scarafoni e l’avv. Budini, ritiene che in
omaggio allo spirito dello Statuto sociale, ogni divergenza venga
pacificamente risolta per mezzo di comuni amici". Il socio Riccetti
Francesco propone di respingere le dimissioni dell’avv. Budini. Il socio
Cittadini Cittadino osserva che è bene non accettare tali dimissioni
anche perché la questione con il dott. Scarafoni è ancora pendente.
Messa ai voti la proposta del Riccetti Francesco è approvata.
Qui finisce il libro dei verbali del Circolo
democratico Attilio Valentini di Porto Recanati. Forse esso è vissuto
soltanto per i quattro mesi e mezzo correnti tra l’8 febbraio e il 23
giugno 1913 e registrati nel documento che abbiamo riportato. Probabile,
dato il carattere fumino anzi che no, manifestatosi in diverse
circostanze, dell’avvocato Budini e del dott. Scarafoni. Non è certo
scomparsa nella realtà portorecanatese la presenza dei repubblicani,
guidati fino agli anni della seconda guerra mondiale da Lorenzo Michelini
e poi da altri.

|
| |
|
Documento 5
La "dota"
Argentino Volpini ci ha fornito copia di un contratto
relativo a un matrimonio celebrato nel 1904 e riguardante il corredo della
sposa. Lo proponiamo ai lettori.
In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III per grazia
di Dio e volontà della Nazione Re d’Italia.
Nota del corredo che il sig. Rombini Pasquale dona in dote a sua figlia
Fortunata in occasione degli sponsali col giovane Volpini Antonio di
Giacomo.
1 letto completo, 10 paia di lenzuola, 52 camicie, 11 paia foderette, 10
tovaglie, 36 salviette, 42 asciugamani, 6 paia mutande, 16 sottanini, 6
busti colorati, 5 maglie di lana, 25 paia calzetti, 8 coperte colorate, 25
sottane colorate, 18 giacchetti colorati, 30 sinali colorati, 18 sciabatte
colorate, 12 fazzoletti di lana, 1 armadio di abete, 1 comò con pietra di
marmo e toiletta, 1 abito di seta, 1 macchina da cucire, 4 paia calzature,
3 paia boccole d’oro, 1 catena d’oro, 2 fili di corallo, 1 fermaio d’oro,
1 anello d’oro, 1 orologio a pendola, £ 2,50 dicasi lire
duecentocinquanta da consegnarsi entro l’anno 1904.
Letto e confermato e sottoscritto come appresso.
Volpini Antonio
Fortunato Rombini
Portorecanati 20 gennaio 1904.
Possediamo anche altri contratti del genere; sono tutti
strutturati alla stessa maniera mentre variano, in rapporto alle
condizioni sociali dei contraenti, le quantità delle singole voci.
Ciò vale, per esempio, per il matrimonio di Ada
Pierini e Giacomo Giri (non è indicata la data) ; qui compaiono anche le
firme dei testimoni Giuseppe Palanca e Luigi Bartozzetti.
Abbiamo pure (27 dicembre 1933) il contratto relativo
al matrimonio tra Giacomina Volpini e Ferdinando Monaldi, controfirmato da
Pasquale Giri e Giacomo Volpini.
La più ricca di voci è la lista riguardante il
matrimonio tra Elisa Cipolletti di Loreto e Giuseppe Biagetti, fratello
del pittore Biagio e padre del nostro collaboratore Aldo.
Il contratto fu steso il 22 ottobre 1916 e in più
rispetto ai precedenti troviamo, tra le altre cose, servizi da tavola e
tovaglie da the, 18 mattinè (?) e un boa , bauli e borsette, ombrelli e
paletot etc..
La prima pagina del detto contratto, stampato, si
presenta così:
Loreto 23 ottobre 1916 –
Alla gentil donzella Elisa Cipolletti
ed all’egregio giovane Giuseppe Biagetti di Portorecanati
nel fausto giorno di loro bene augurate nozze
GIOSUE JAFFEI in segno di riconoscenza:
A vostra giovinezza in santo unita
fuoco d’amor che non sappia il gelo,
scorra dolce la vita,
sia benigna la terra amico il cielo!
Sul vostro nido nuovo e benedetto
scenda la pace che non sa gli affanni
ho dolci, nell’affetto
pio di due cori, anche se dolgon, gli anni!
Intorno a Voi, il vostro cor nutriti,
crescan i figli –rigogliosa prole-
buoni, sapienti, arditi,
quali il Signor, quali la patria vuole!
Abbondanti le firme a piè del documento: gli sposi
Giuseppe Biagetti e Elisa Cipolletti e poi Dante Cipolletti, Luigia
Cipolletti, Giosue Jaffei, Giuseppe Grondona, Enrico Agostinelli.

|
| |
|
Documento 6
Medici contestati
Il 12 marzo 1855 il Rappresentante del Comune di
Recanati nel Porto, e Uditor Legale, Pietro Morici, trasmise al
Gonfaloniere della città (credo il conte Luigi Della Torre) una lettera
indirizzata allo stesso massimo magistrato cittadino, giuntagli anonima e
contenente gravi accuse contro il medico chirurgo del Porto, dott.
Sabbatini.
Possiamo darne conto ai lettori grazie alla pazienza di Flaviano Ponziani,
che ha "tradotto" in caratteri di computer quanto scritto nel
documento la cui copia si trova nelle Carte del Csp.
Eccellenza Illustrissima, è la popolazione del Porto
Recanati oratrice dell’Ecc.za V. Ill.ma che riverentemente espone quanto
appresso.
Erano le ore 18 del primo marzo quando Sampaolo Davide
si portò ansante con cavalcatura a prendere questo Chirurgo Pericle
Sabbatini per la sua moglie Teresa che da più ore si trovava in
gravissime pene e dolori di parto: ed il sud. Chirurgo non solo si ricusò
assolutamente di accedere, ma eziandio con modi più insultanti e
minaccianti malmenò il sud. Davide, colono in S. Maria in Potenza, il
quale si raccomandava sempre più con le lagrime agli occhi perché gli
facesse un tanto favore. Nulla giovando le sue preghiere, si presentò
tutto piangente a questo nostro Parroco, onde si volesse degnare ad
interporre la sua mediazione presso il sud. Chirurgo, e così muoverlo ad
accedere nella sua casa a tal uopo.
Il Parroco, vedendo una mestizia ed una afflizione straordinaria nel sud.
Sampaolo, si mostrò subito propenso il Rappresentante di questo luogo
sig. Leone Cittadini, perché desse ordine immediato al Chirurgo di
portarsi senza dimora a visitare la partoriente. Frustianeo (vano)
fu anche il comando del Sig. Rappresentante, per cui il Sampaolo fu
costretto ritornarsene tutto mesto e dolente senza il desiderato intento.
Giunto a casa, ritrovò che il parto sempre più si faceva difficile, e
circa le ore due di giorno rimandò il suo fratello Pacifico l’istesso
scopo, che brontolando sempre contro il contadino vi andò tutto
indispettito; si presentò dalla miseranda, si fece dare il braccio, le
tirò il sangue, e senza alcuna osservazione se ne partì lasciando in uno
stato il più pericoloso la stessa partoriente. Infatti erano le quattro
ore circa di notte (intorno alle 22), quando tre fratelli Sampaolo
con due cavalcature di gran galoppo si presentarono, uno dal nostro buon
Parroco, che immediatamente partì con gran velocità, e l’altro nella
casa del Chirurgo, che non vi era, stando in conversazione altrove; dopo
alquanto fu ritrovato, che si ricusò di andare a cavallo, ma bensì
richiedeva una carrozza. I pazienti furono costretti a trovarla, e vi
montò il Chirurgo unitamente al Medico, che giunto alla casa alle ore sei
di notte, trovò che il Parroco se ne partiva dopo di avere somministrati
quei pochi conforti di nostra S. Religione, e di avere raccomandata l’anima
di Teresa che fra le più dure pene di morte spirò nel bacio del Signora
nell’età di anni 23.
Non può immaginare l’E.V.Ill.ma quanto noi abbiamo brontolato per la
negativa di ieri, e quanto oggi nel vedere venire trasportata nel paese
estinta l’infelice partoriente, si sia rinnovato in noi un mesto ed
afflitto cordoglio, e perfino in non poche persone un pianto inconsolabile
per l’immatura morte; e se i motivi di Religione non ci avessero
trattenuto, certamente saressimo caduti in eccessi di furore. Per la qual
cosa onde in avvenire non abbiano a rinnovarsi simili inconvenienti, prega
la popolazione tutta l’E.V.Ill.ma di prendere quei opportuni
provvedimenti, che il saggio suo sapere in simili casi può adoperare, e
così non essere noi obbligati e costretti a ricorrere ad altro Superiore
per la retta giustizia dell’esposta. Che se l’E.V.Ill.ma non volesse
persuadersi di quanto Le abbiamo narrato, potrà per la verità
interpellare questo nostro Parroco, il Rappresentante Sig. Leone
Cittadini, il marito dell’estinta con l’intera famiglia ed altre
persone bene informate, dalle quali potrà accertarsi viè meglio esistere
il successo ed altri fatti accaduti di recente per trascuratezza non solo,
ma d’imperizia pur anche del nominato Chirurgo.
Non sappiamo quali sviluppi abbia avuto la vicenda, se
pure ve ne sono stati.

|
| |
|
Documento 7
Le guardie
Qualche curiosità sui vigili urbani dei primi anni
dell’autonomia.
Divise. Delibera della giunta comunale del 23 marzo
1911. Si adotta l’uniforme per le guardie urbane. Per le feste e
altre solennità: di panno nero. Uniforme ordinaria: di panno verde
grigio. Uniforme ordinaria per l’estate: seta verde grigio.
Per il capoguardia: distintivo con filettatura in oro a zig zag intorno al
berretto e sopra i paramani, dello stesso panno della tunica; tunica ad un
pezzo, con falde e filettatura rosso bacca; piccole bande ai pantaloni.
Per tutti: cappotto nero a doppio uso.
Pistole. Delibera di giunta del 20 luglio 1910.
Rivoltelle per guardie municipali: si decide l’acquisto di due
rivoltelle, con fondina (è evidente che i vigili, allora, erano
ritenuti persone con i nervi a posto).
Contravvenzioni. Delibera di giunta del 31 dicembre
1911.
Si verifica che la somma da spartirsi tra le guardie urbane,
derivante dalle contravvenzioni applicate nell’anno 1911, è di lire
217,15. La giunta, comunque, ripartisce tra i vigili anche la sua parte, a
seconda del buon servizio reso dai dipendenti.
L’avvento di Salvioni. Delibera di giunta del 5
giugno 1912.
Dimessosi il capoguardia Francesco Tanci (costretto perché giudicato
colpevole dal Tribunale di Macerata di reato connesso all’esercizio
delle sue funzioni) e dopo il breve periodo di comando di Gustavo
Abbruzzetti, viene eletto Teodosio Salvioni, attualmente guardia a
Urbino. Solo nel 1914, in marzo, gli sarà assegnata una bicicletta
nuova per una spesa di lire 100, visto che riparare la vecchia costerebbe
lire 64,50. La bicicletta sarà acquistata da Umberto Vannini.

|
| |
|
CRONACHE
DELL’ARTE E DELLA CULTURA (maggio-ottobre 2000) (di
Aldo Biagetti)
UN FLASH-BACK IN FEBBRAIO
In occasione del Giubileo anche i Musei Vaticani hanno effettuato
opere di ristrutturazione ed ampliamento per agevolare i visitatori,
previsti in oltre tre milioni . Il 7 febbraio il Pontefice inaugura la
nuova biglietteria, una struttura da 45 miliardi di costo, ove campeggia
un enorme portone in bronzo, unica opera moderna del complesso, con
figurazioni a bassissimo rilievo rappresentanti la Creazione, lavoro del
nostro concittadino CECCO BONANOTTE.
M A G G I O
Sabato 6 = Al Cinema Teatro Adriatico Cerimonia di
Gemellaggio fra il Centro Sociale di Mogliano ed il Centro Sociale Anni d’Argento
di Porto Recanati. Alla presenza dei rispettivi Sindaci Gianni Giuli e
Glauco Fabbracci e della Vice Presidente Nazionale dei Centri Sociali Rita
D’Antonio, Renato Germani e Giovanni Mordini sottoscrivono il relativo
documento. Durante la manifestazione il Centro Sociale di Porto Recanati
consegna una targa a David Crescenzi in segno di vivo ringraziamento per
la sua costante disponibilità ed auspicio per una sempre più brillante
carriera.
VENERDI’ 19 = Organizzato
dall’Associazione Artistica Federico II° ha luogo, all’ Auditorium
della Scuola Media, il primo di cinque concerti previsti dal cartellone
della 1° Primavera Musicale Portorecanatese.
Mercoledi 31 = Al Cinema Teatro Kursaal Cerimonia di Premiazione della 2°
Ediz. del Concorso "Conoscere la propria terra", riservato agli
alunni delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie. Organizzato dal
Centro Sociale e dal Centro Studi Portorecanatesi, con la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale ed in quest’edizione con il tangibile
intervento della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano, il
Concorso ha lo scopo di salvaguardare, valorizzare e diffondere il
patrimonio di storia, usi, costumi e lingua della comunità locale. L’apposita
Commissione Esaminatrice premia, come lavoro di gruppo, "Questo è el
paesu più bellu del monnu" della IV Elementare (insegnante Giusi
Monachesi) e come lavoro individuale una poesia di Mauro Marchei (classe
5° A t.p.). - Sono state pure segnalate delle poesie di Marina Piattella,
Sara Moroni, Elisa Pacella e Valentina Funes. La 1° Edizione del Concorso
si era svolta nel 1998 ed era stata giudicata vincitrice una poesia di
Valentina Funes.
G I U G N O
GIOVEDI 1 = Gabriella Mingardi espone a Parma in una
Mostra Mercato a livello europeo "Artisti in Fiera - Parma
2000". GABRIELLA MINGARDI, nata in Provincia di Bologna, vive a Porto
Recanati da oltre trenta anni, ha esposto in numerose mostre in
Italia(Napoli, Milano, Bologna, Roma, Brescia, Pesaro ,Macerata,ecc.) sia
all’estero (New York, Parigi, Londra). Dei critici che hanno scritto di
lei riportiamo solo una breve frase di Virgì Bonifazi: "la sua
singolare vena espressionistica a sfondo simbolico è affiorante in ogni
sua opera e aggiunge ironia e pathos alle intense composizioni".
Sabato 10 = Al Circolo Cittadino di Via degli Orti "Concerto di
Primavera" con la partecipazione del soprano Cristina Piangerelli e
del tenore Enzo Boccanera. Al piano Ilaria Tramannoni.
Sabato 17 = All’ Auditorium della Scuola Media suona MATTEO SIMONETTI,
ventottenne portorecanatese, diplomato in pianoforte con il massimo dei
voti al Conservatorio di Pesaro, dove ha frequentato per quattro anni
anche il corso di composizione. Autore ed esecutore molto personale,
Simonetti ritiene sia necessario dare alla musica colta una immagine meno
convenzionale e ricerca nel contempo motivi di fusione tra cinema,
letteratura e musica. Si dedica pure all’insegnamento ed ha fondato l’Associazione
Artistica Federico II° di cui ne è tuttora il Presidente.
Sabato 24 = Prima Nazionale di "Commedia Pericolosa" da Carlo
Goldoni e Dario Fo. E’ l’inizio di una interessante ed articolata
stagione al Castello Svevo, con la 4° Ediz.. del Festival Porto Recanati,
con un ricco cartellone comprendente opere di teatro, musica e danza che
vedrà sul palcoscenico dell’Arena Gigli personaggi molto noti al
pubblico ed opere di notevole richiamo (Solenghi, Croccolo, Romano
Mussolini, Elena di Euripide, la Casina con Anna Mazzamauro, ecc:).
Domenica 25 = Nei Giardini Lucangeli, dopo la presentazione della
manifestazione aerea che avrà luogo nei primi di settembre per l’80°
Anniversario della Madonna di Loreto, quale Patrona degli Aeronauti
concerto tenuto dall’Orchestra da Camera delle Marche, diretto dal M.o
David Crescenzi (musiche di Bach e Beethoven).
L U G L I O
Domenica 2 = Al Castello Svevo, salone Biagio Biagetti,
inaugurazione della Mostra "Ricordando Mario Moriconi",
organizzata dal Csp, retrospettiva delle opere del nostro concittadino
scomparso lo scorso anno.
Sabato 8 = Cerimonia di Premiazione della XV° Edizione del Premio di
Poesia Città di Porto Recanati, che ha visto la numerosa partecipazione
di poeti italiani e stranieri (anche un nipote di Bertrand Russel). Vince
Clara Di Stefano dell’Aquila. Presidente della Giuria Sandro Baldoncini.
Lunedi 10 = Inaugurazione, ancora al Castello Svevo,
della Mostra di pittura "Emozioni Portorecanatesi", una
panoramica di scorci e punti caratteristici del nostro ambiente e del
nostro paesaggio.
Sabato 15 = Inaugurazione della XXIV MARGUTTIANA PORTORECANATESE che
vedrà esposte, nello slargo delle Scuole Elementari in Corso Matteotti,
nei tre cicli espositivi (la rassegna chiuderà il 31 agosto), opere di 32
pittori con tecniche diverse e forme espressive che suscitano interesse ed
attenzione.
Sabato 22 = Organizzata dal Centro Studi Portorecanatesi e dalla Croce
Azzurra ha luogo, all’Arena Gigli, la XV° Edizione del PREMIO CITTÀ’
DI PORTO RECANATI.
Vengono premiati :
Per il Lavoro : L’Azienda e le Maestranze del Cementificio Scarfiotti
Per lo Sport : Patrizia Cannuccia (è la prima donna che raggiunge, in una
disciplina sportiva, questo riconoscimento)
Per l’Arte e la Cultura : Nando Carotti
Per lo Speciale Turismo : Alban Scherzinger, docente di sociologia all’Università
di Friburgo
Per lo Speciale C.S.P. : Città di Kronberg Im Taunus. All’alba del
nuovo Secolo il Centro Studi Portorecanatesi, nella prospettiva di più
ampi orizzonti a livello europeo, ha inteso rendere più sensibili i
rapporti che legano Porto Recanati alla Città Tedesca.
A G O S T O
Martedi 8 = Ai Giardini Lucangeli : Concerto Lirico di
Mezza Estate, in ricordo di Beniamino Gigli, organizzato dal Circolo della
Vela.
Venerdi 25 = Cerimonie di Premiazione dei Concorsi di Poesia e di Pittura
annessi alla Marguttiana.
IV° Ediz. Premio di Poesia-Estate. La Giuria Esaminatrice (Novella
Torregiani, Donatella Donati, Salvatore Piscitelli, Angela Senigagliesi e
Aldo Biagetti) così si esprime:
1° class. "Per noi" di ANNAMARIA PELOSI di Ancona
2° "Io non ho nome " di Mara Giovane di Albenga
3° "Un viandante in Provenza" di Lamberto Perlini di Iesi
II° Ediz. Premio di Pittura Estemporanea "Angoli da salvare".
La Giuria Esaminatrice ( Renata Gentili, Rosaria Moriconi, Giuseppe
Perfetti, Giuseppe Guastaferro, Aldo Biagetti) esprime il seguente
giudizio: "Vincitori ex-aequo, Oscar Gricia e Leonarda Venuti
Matteucci, con la motivazione . Seppur con stili e tecniche diverse
entrambi centrano il tema preposto esprimendo con il colore la fisionomia
vivace e ridente della città di Porto Recanati-
SETTEMBRE
Alessandro Mordini, portorecanatese residente in
Ancona, dopo aver tradotto in dialetto il "Cantico dei Cantici"
("Cantegu dei Canteghi"), si rifà vivo con un pregevole
volumetto di poesie in dialetto, "Sai bellu e caru" (titolo
riferito al Porto).
O T T O B R E
Martedi 31 = Relatore il Prof. Nando Carotti il Centro
Studi Portorecanatesi ed il Centro Sociale Anni d’Argento presentano una
raccolta di opere dell’artista Angela Maria Eleuteri, allestita nel
Salone Biagio Biagetti al piano terra del Castello Svevo. Durante la
cerimonia inaugurale il Centro Studi presenta il 1° numero Speciale della
rivista "Potentia", dedicato all’Abbazia di S.Maria in
Potenza.

|
| |
|
Cronache
del 2000 - (1/5/2000
– 31/10/2000)
I fatti e i giorni
- La primavera e l’estate sono caratterizzate da
vivaci polemiche politiche tra maggioranza e opposizione in ordine all’organizzazione
e al sistema di pagamento dei parcheggi pubblici, alla costruzione del
nuovo stadio, alla lottizzazione Bartoloni (collina di Montarice) e alla
pratica di esproprio di una parte della pineta Volpini.
- Un’altra polemica nei confronti dell’Amministrazione comunale la
innestano, con un documento, alcuni vigili urbani, ma di questo riteniamo
dignitoso non occuparci.
- In luglio si dimette il comitato direttivo del quartiere Castelnuovo,
che minaccia la non partecipazione al Palio di san Giovanni, il che, per
fortuna, non avverrà.
- Dopo i tradizionali fuochi artificiali di Ferragosto, si disputa il
suddetto Palio, vinto dal quartiere Europa.
- I residenti al Porto, aggiornati al 31 luglio, sono 9600: gli stranieri
registrati assommano a 929, quasi il 10%.
- Il 28 agosto la coppia Vincenzo Volpini / Sandro Mancinelli vince il
10° Torneo Interregionale di Trucco.
- Il 2 e il 3 settembre si svolge nel cielo del Porto la manifestazione
aerea "Ali per la vita", con la partecipazione delle pattuglie
acrobatiche italiana e inglese.
- In settembre scoppia l’ultima polemica relativa agli aumenti stabiliti
dalla giunta comunale per le indennità di funzione spettanti a sindaco e
assessori: il nostro clima politico non si può davvero definire sereno.
- In ottobre cominciano i lavori per la sistemazione del lungomare.
Ordine pubblico
- Il 19 maggio, verso le 13, tre banditi armati di
taglierino compiono una rapina alla filiale Carilo di via Valentini.
- Il 5 giugno i Carabinieri arrestano due bosniaci autori del furto di un
furgoncino: per sfuggire alla cattura uno dei due cerca di travolgere un
militare, che si salva di poco. L’uomo sarà catturato poco dopo a
Civitanova Marche.
- I rapinatori del taglierino si ripetono il 20 e il 26 ottobre; sempre in
tre e alla stessa ora, circa le 13, prima di nuovo alla Carilo poi alla
Rolo Banca. Ogni volta arraffano "solo" una decina di milioni di
lire.
Sport
- Il 13 maggio è una grande giornata. Le ragazze dell’Adriatica
Basket Italspurgo, dopo una stagione strepitosa, sono promosse in serie B;
i ragazzi della Electa Imballaggi di pallavolo, a loro volta, raggiungono
la serie C. Complimenti a tutti.
- Il 3 giugno i giovanissimi del calcio diventano campioni provinciali di
categoria.
- Il 10 settembre Andrea Pangrazi, del nostro Circolo della Vela, vince il
campionato nazionale nella classe windsurfer.
Vita sociale
- Il 18 maggio si inaugura la nuova sede del CSP in via
degli Orti, 57.
- In giugno viene spedito il secondo numero di questa Rivista.
- Il 2 luglio si inaugura la Retrospettiva delle opere di Mario Moriconi
(Castello Svevo), socio fondatore del CSP, deceduto nel 1999.
- Il CSP collabora alla XVI edizione del Premio di Poesia Città di Porto
Recanati, organizzato dal Casisma.
- Il 10 luglio si inaugura, con il CSP tra i promotori dell’iniziativa,
la mostra di pittura di Oscar Gricia (Castello Svevo).
- In ottobre esce il primo Speciale della Rivista del CSP; è dedicato all’Abbazia
di Santa Maria in Potenza. Nello stesso mese il Centro si dota di un
computer.
- Il 18 ottobre prende avvio il "salotto di conversazione":
incontri quindicinali tenuti nella sede sociale su temi vari.
- Sono in corso contatti con il Comune di Arquata del Tronto per
valorizzare la ricorrenza della Vittoria di Lepanto, celebrata con grande
pompa in quella località.
Dialetto in pillole
Prescia. Vuol dire fretta e nel
Devoto/Oli il termine è definito come voce arcaica regionale, formatasi
dal latino volgare pressia, astratto di pressare e intensivo
di premere. Nella sua forma veneziana lo troviamo nel CONTRASTO del
poeta Leonardo Giustinian (1388/1446), nella dodicesima strofa, quando lei
dice a lui che non gli aprirà la porta di casa perché lo conosce come
uno che va sempre in presse, cioè che cerca di raggiungere prima
possibile il proprio scopo.
Si tratta, quindi, di parola che si trova anche in versi nobili,
come quelli di Giustinian, e con lo stesso significato attribuitole dal
nostro dialetto (e non solo dal nostro, ben inteso).
Del resto, i rapporti con il veneziano sono stati assai frequenti e
intensi nel corso di molti secoli, data la posizione geografica del Porto,
che si affaccia su un mare un tempo indicato, nelle carte geografiche,
come Golfo di Venezia.
Teofilo Folengo, vissuto abbastanza a lungo a Venezia e che lì ha
pubblicato per la prima volta il suo Baldus, offre in quest’opera
parecchie occasioni per confermare quanto il veneto, che traspare con
tutta evidenza dal latino maccheronico (sua felice trovata linguistica),
sia penetrato nel nostro lessico: buganzas per il diaettale bugànze;
coppis > còppi; padire (digerire) > pajedì; sbregas >
sbrégu da un longobardo brehhann; sparagnat > sparagnà.
Sono soltanto alcuni tra i tanti esempi possibili.
Nel dialetto c’è un modo di dire interessante, legato al termine
indagato: ‘ndà più de fuga che de prescia, dal quale si deduce
che la prescia implica sempre la necessità di sbrigarsi, ma non
nella misura della fuga, che comporta un’azione ancora più
precipitosa.

|
| |
|
Gli
Autori e le foto (numeri 1 – 3)
AA.VV. DOCUMENTO 3 (n°2 p.74).
Alessandrini Giorgio. Sacerdote. Parroco in Roma. Socio
onorario del Csp (n°1 p.58).
Biagetti Aldo. Geometra, ex-responsabile dell’ufficio
tecnico comunale di Porto Recanati. Segretario del Centro Sociale Anni d’Argento
(n°1 p.27, p.75 – n°2 p.23, p.81).
Carotti Nando. Pittore. Membro dell’Accademia
Internazionale di Arte Moderna. Ufficiale in congedo della Marina Militare
(n°1 p.20 – n°2 p.17 – n°3 p.63).
Cartoni E. Ex consigliere comunale di Roma nel 1922, anno di
pubblicazione del DOCUMENTO 1 (n°2 p.61).
Fanti Mario. Notaio in pensione. Socio onorario del Csp
(n°2 p.41).
Foschi Franco. Direttore del Centro Nazionale di Studi
Leopardiani, presidente onorario del Csp (n°3 p.38).
Galiè don Vincenzo. Sacerdote, studioso di storia
marchigiana (n.3 p.16).
Giattini Alberto. Medico. Consigliere comunale delegato dal
sindaco alla sanità e ai problemi sociali (n°1 p. 35 – n°2 p.47).
Harbert Claus. Dell’ufficio cultura del Comune di Kronberg
im Taunus, Assia, Repubblica Federale di Germania (n°2 p.33).
Mancinelli don Albino. Parroco in san Giovanni Battista dal
1907 al 1956. Autore del DOCUMENTO 2 (n°2 p.69).
Michelini Andrea. Impiegato. Componente del consiglio
direttivo dell’Ente Palio Storico di San Giovanni Battista (n°1 p.40).
Nobili Benedetti Francesco. Medico, delegato del
Sovrano Militare ordine di Malta per la Provincia di Macerata (n°3 p. 9).
Palanca Lino. Ex-docente di Lingua e Letteratura Francese
nel Liceo Scientifico di Osimo. Presidente del Csp (n°1 p.3, p.49, p.88
– n°2 p.3, p.56, p.87 – n°3 p. 3, p.5, p.7, p.79).
Pirani Francesco. Ricercatore universitario – Laurea in
Lettere -(n°3 p.27).
Ragnini Rodolfo. Sacerdote, autore di un volume sull’Abbazia
di Santa Maria in Potenza nel 1946 (n.3 p.68).
Torregiani Novella. Ex-insegnante elementare. Autrice di
volumi di poesia in lingua e in dialetto (n°3 p.89).
Venusto Bruno. Pescatore in pensione. Ha pubblicato libri di
poesia in lingua e una biografia (n°2 p.13).
Le foto
N°1 Inverno 2000 (p.26). La famiglia di Pietro
Gardano.
N° 2 Estate 2000 (pp.50-55). Giacomo Foresi - Classe
seconda maschile anno 1924 - Pre-militare 1934/’35 – Alfredo Binda
nell’albergo Bianchi 1952/’53 – Il maestro Renzoni con una classe di
Balilla – Mons. Giovanni Pauri – Argentina Palanca.
N°3 Speciale 2000 (pp.56-62). L’Abbazia di Santa Maria in
Potenza nel 1931/’32 – L’Abbazia intorno al 1950 – L’Abbazia
oggi – Velia Simoncini e il cardinale Rossi – Un disegno dell’Abbazia
– Il trittico nella cripta – Il Crocifisso nella cripta.
Gli operatori
Direttore Responsabile: Lino Palanca
Comitato di redazione: Aldo Biagetti, Nando Carotti, Alberto
Giattini, Giuseppe Perfetti
Distribuzione: Vincenzo Panico
Elaborazione grafica: Maura Passerin
Tutti i numeri sono stati stampati presso l’Azienda
BIEFFE di Recanati.

|
| |