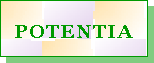
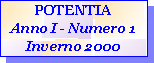
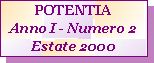
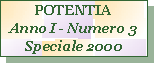
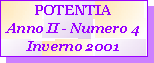
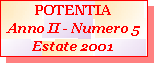
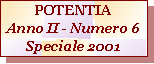
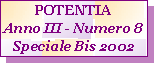
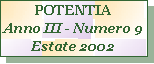
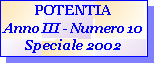
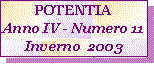
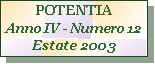
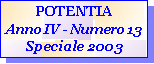
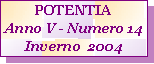
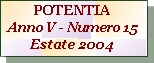
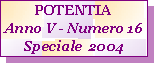
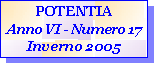
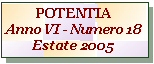
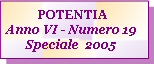
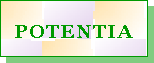 |
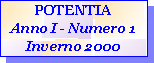 |
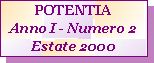 |
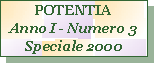 |
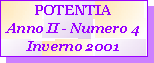 |
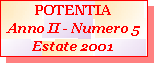 |
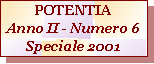 |
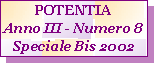 |
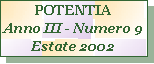 |
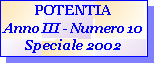 |
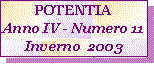 |
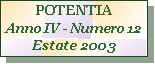 |
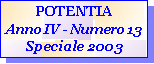 |
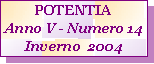 |
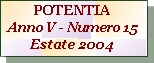 |
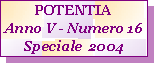 |
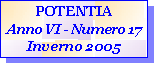 |
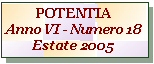 |
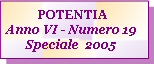 |
|
|
*
Presentazione |
|
L’omaggio
al Poeta era dovuto, e da gran tempo. L’occasione ci è stata offerta
dalla sistemazione delle lapidi sulla facciata del castello svevo, che
ricordano a tutti come il nostro mare abbia ispirato la Musa di uno dei più
straordinari protagonisti della Letteratura mondiale. Esso
vuole anche testimoniare della nostra volontà di mantenere e sviluppare
rapporti proficui con il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, diretto
dal nostro presidente onorario, e amico, Franco Foschi. Nel
contempo non dimentichiamo certo che questo anno 2002, da poco iniziato,
ci sta conducendo al ventesimo compleanno della nostra Associazione. E’
un evento che celebreremo senza trionfalismi, ma con la serena coscienza
di aver cercato sempre di rendere un servizio alla Comunità, per
ravvivarne e salvaguardarne la memoria storica, le tradizioni e gli usi e
la lingua, per contribuire a creare opportunità di confronti, di
dibattiti, di crescita culturale. Oltre
ad essere serena, la nostra coscienza è anche forte, il che ci permette
di essere sempre disponibili ad ogni utile collaborazione e sempre
indisponibili a qualsivoglia tentativo di incapsulamento, di
normalizzazione ad usum senatus, di delegittimazione: siamo nati
gelosi della nostra libertà, un sentimento che, col tempo, è diventato
una malattia. Cronica. Irreversibile. Abbiamo
una speranza: di poter ancora
a lungo a svolgere l’attività che ci compete garantendo agli altri il
più grande rispetto per il loro operato e, naturalmente, pretendendone
altrettanto. Ci auguriamo che i soci, i lettori, i concittadini e quanti altri ci seguono, continuino a pensare che il CSP, come è stato per il passato, continuerà a rappresentare uno dei punti di incontro per chiunque, uomo o donna, giovane o meno giovane, laureato o no, nutra davvero amore per Questo Porto. Il
Direttore
Porto Recanati, inverno 2002.
|
di Carlo
Trevisani
Vedere
volare: immagini di volo catturate da terra nel giro di appena un mese,
eppure distanti anni luce tra loro. “Ali
per la vita”, viste sfrecciare nel cielo e sul mare di Porto Recanati,
in un tripudio di folla festante, affascinata dalle fragorose e ardite
evoluzioni della Pattuglia acrobatica nazionale. Ali
portatrici di morte, viste penetrare e scomparire dentro le due torri di
New York, con la stessa irrisoria facilità con cui una lama rovente
penetra in un pane di burro, nel silenzio irreale della diretta televisiva
mandata in onda dalla CNN, e riproposta ossessivamente sui nostri
teleschermi, quasi ad immortalare l’orrore del terrore, reso ancor più
assurdo dal volo disarticolato di poveri corpi senz’ali, costretti alla
scelta disumana di gettarsi nel vuoto, per evitare lo scempio straziante
del fuoco. Ambivalenza
del volo, dunque, che al pari di ogni altra realtà umana può essere
strumento solidale di vita, se ispirato da sentimenti di amore, e
diventare veicolo distruttivo di morte, quando siano pulsioni di odio a
indirizzarne la rotta, in sintonia con la fondamentale intuizione etica
leopardiana, secondo la quale “L’amore
è la vita e il principio vivificante della natura, come l’odio il
principio distruggente e mortale” (Zibaldone: 59). E,
a proposito di Leopardi, il tema specifico del “volo” è presente
nella sua opera, sia in due passi dello Zibaldone e in un brano della
“Palinodia al Marchese Gino Capponi”, che contengono intuizioni
folgoranti e quasi profetiche sulle prospettive di sviluppo
dell’aeronautica civile, e sia nei versi conclusivi del “Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia”, in cui il sogno del volo
umano affiora, ma solo per un istante, come erronea illusione di felicità,
suscettibile di riscattare l’uomo dalla sua funesta condizione naturale. Nel
settembre del 1821, trattando della casualità di tante invenzioni
scientifiche, Leopardi si pone un interrogativo in cui è racchiusa quella
sorta di intuizione profetica di cui si diceva: “Chi
sa che l’aeronautica non debba un giorno sommamente influire sullo stato
degli uomini?” (Zibaldone: 1738). Alcuni
anni più tardi, nel settembre del 1826, l’intuizione si farà più
precisa e circostanziata: “..se i palloni aerostatici, e
l’aeronautica acquisterà un grado di scienza, e l’uso ne diverrà
comune, e la utilità (che ora è nessuna) vi si aggiungerà, se tanti
altri trovati moderni, come quei della navigazione a vapore, dei telegrafi
ec. riceveranno applicazioni e perfezionamenti tali da cangiare in gran
parte la faccia della vita civile, come non è inverosimile, e se in
ultimo altri nuovi trovati concorreranno a questo effetto; certamente gli
uomini che verranno di qua a mille anni , appena chiameranno civile la età
presente,.. (Zibaldone: 4198). Ancora
a distanza di un decennio, quando Leopardi è ormai giunto all’ultima
fase della sua vicenda poetica e umana, la previsione dello sviluppo dei
collegamenti aerei si fa ancora più nitida, in alcuni versi della
composizione satirica intitolata “Palinodia al Marchese Gino Capponi”: “Da Parigi a Calais, di quivi a Londra, Dai
brani citati dello Zibaldone e della Palinodia emerge l’immagine di un
Leopardi inconsueto, attentissimo all’evoluzione della scienza e della
tecnica del suo tempo, e capace di prevederne gli sviluppi e di intuirne
le influenze sulla condizione umana (l’aspetto che più gli sta a cuore)
con oltre un secolo d’anticipo: basti pensare che Leopardi intuisce
l’evoluzione dell’aeronautica al tempo dei primi palloni aerostatici,
nei primi decenni dell’ottocento, e che i primi collegamenti aerei di
linea saranno istituiti solo verso la metà degli anni trenta del secolo
appena concluso. Un
approccio del tutto diverso al tema del “volo” è quello dei versi
conclusivi del “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, in
cui Leopardi, dopo aver posto a raffronto la tranquillità della
condizione animale con l’inquietudine e il tedio della condizione umana,
si abbandona al sogno del volo come estrema, quanto illusoria, prospettiva
di felicità: Forse s’avess’io l’ale L’immagine di sconfinata libertà del pastore che sogna di volare sopra le nubi contando le stelle, e di correre tra le cime dei monti come il rombo del tuono, quasi evocando il mito di Icaro, può lasciare intuire le sensazioni che deve provare il pilota solista delle “Frecce tricolori” durante le sue mirabolanti acrobazie. L’interesse di Leopardi per il tema del volo costituisce un ulteriore punto di contatto della terra marchigiana compresa tra le valli del Potenza e del Musone col mondo dell’aeronautica, oltre a quello rappresentato dalla Madonna di Loreto, universalmente riconosciuta come “celeste patrona” degli aviatori. |
di Nando
Carotti
Ci sorge il dubbio che non sia stato facile
l’approccio di Giacomo Leopardi alle arti figurative se, non più
all’inizio della propria esperienza terrena, egli può ancora
raccogliere nello “Zibaldone” pensieri che paiono più critici che
esplorativi. E forse il dubbio nasce proprio leggendo e rileggendo quanto
scrive un poeta che eleva il proprio ammirevole monumento basandolo sulla
sofferenza, sulla solitudine, sulla incomprensione riservatagli da quel
suo mondo racchiuso tra la finestra sulla piazzetta e le antiche mura. Nessuno riuscirebbe ad immaginare il poeta
recanatese nell’atto di inebriarsi di entusiasmo e di gioia quando mosso
dall’osservazione del creato. Come nessuno si meraviglia che quel
medesimo creato lo induca alla introspezione ed a nuova sofferenza, questa
volta interiore, anche se l’artista sa bene che esse, introspezione e
sofferenza, sono i veri motori capaci di produrre ed alimentare l’opera
d’arte. Ma come potrebbe meravigliare che lo spirito leopardiano sia un
continuo contrasto? La verità è piatta: è la fantasia che la rende
dinamica. Così può sorprendere che Leopardi affermi “...Par che tutto
lo scopo che si propone uno scultore (siccome un poeta) sia che la sua
opera paia una statua antica (come un poema antico), dovendo solamente
cercare ch’ella sia tanto bella quanto un’antica, o più bella ancora,
quantunque, se si vuole, nel genere del bello antico” (19 Set.1823). Può
sorprendere, abbiamo detto, ma non tanto se si considera quando, dove,
perchè: per convincersene sarebbe sufficiente una sua affermazione
successiva (24 Gentile. 1824) “Una statua, una pittura, con un gesto, un
portamento, un moto vivo, spiccato ed ardito, ancorchè non bello questo,
nè bene eseguita quella, ci rapisce subito gli occhi a sè, ancorchè in
una galleria d’altri mille, e ci diletta, almeno a prima vista, più che
tutte queste altre...”. Non potendo mettere in dubbio la sua assoluta
buona fede, e riconoscendogli quel nonsochè di più che evidenzia il
genio, attribuiamo le sue idee in materia d’arte a condizioni temporali,
ambientali e psicofisiche non trascurando, anzi tutt’altro, il suo
sforzo penetrativo ed interpretativo. Oggi sappiamo bene che l’arte
figurativa, ben lontana dal voler soltanto imitare l’antica, si
appropria delle doti del genio non per negare la realtà ma per andare
oltre la realtà, non per modificarla ma per immaginare come potrebbe
essere se tutti possedessimo le doti necessarie per vedervi “dentro”
ed “oltre”. E questo, con buona pace del poeta, nemmeno Leopardi
poteva immaginare che sarebbe accaduto. È anche vero che altrove, sempre nell’opera
citata, Leopardi scrive battute e commenti del tutto differenti:
certamente non per incostanza, più probabilmente perchè lo
“Zibaldone” non è, e non voleva essere, un trattato, un libro di
testo, ma semplicemente una raccolta di pensieri buttati giù man mano che
il poeta li formulava tra sè e sè, appunti, giudizi, ricordi
occasionali, riflessioni; al Poeta doveva essere caro quel “...io mi son
un che quando amor mi spira noto, ed a quel modo ch’ei ditta dentro vo
significando” di dantesca memoria. Forse con un pizzico di troppo di
malinconia, di tristezza non sempre idonea, per sua stessa natura,
all’apprezzamento dell’arte figurativa. Il che contrasta, a nostro
parere, con l’affermazione di due anni precedente (19 Lug. 1822), che
“in ultima analisi la forza dell’arte nelle cose umane è maggiore
assai che non è quella della natura”: ci balena il dubbio,
piacevolissimo del resto, appagante, che il Poeta intravedesse che non
tanti anni dopo di lui, appena un centinaio per la storia, l’artista
figurativo si emancipasse, si svincolasse dalle pastoie della tradizione e
del mitologico e, rischiando l’ostracismo ma in un supremo anelito alla
libertà di espressione, mirasse alla “costruzione” di una verità
che, non rinnegando quella fino allora nota ma prendendo lo spunto da
quella, somigliasse di più alla realtà che, appunto perché tale, non
poteva essere statica né limitata nei soggetti e nelle forme. Ci balena
il dubbio, insomma, che Leopardi sia stato, almeno nei confronti delle
arti figurative, un indicatore “ante litteram”, un precursore della
spinta alla ricerca dell’arte totale. Ci sarebbe piaciuto poter disquisire di persona con
il Poeta intorno all’argomento: perché è molto probabile che
l’istinto alla ricerca della vera dimensione della realtà ci
accomunasse, accomunasse i nostri sforzi; anch’egli infatti rimane
perplesso di fronte ad “un corpo che non sia nè largo, nè lungo, nè
profondo...cambiamo la parola: diciamo uno spirito: a noi par di avere
un’idea. E pur che altro abbiamo che una parola?”. E noi artisti
moderni, noi derivati da quei figurativi cui fa cenno il Poeta, non siamo
forse partiti dalla parola per tentar di giungere, ciascuno per la sua
strada ma tutti insieme nell’unica direzione possibile, a rappresentare
il concetto nascosto nella parola astraendo dal mito? Non abbiamo forse
dipinto e scolpito l’amore, la sofferenza, l’angoscia, la gioia,
l’amicizia e l’inimicizia, la pace e la guerra, la carestia e
l’abbondanza, la vita e la morte? Forse il Leopardi, se potesse vedere
le opere d’arte figurativa del secolo che l’ha seguito, non
apprezzerebbe certi stili, certi modi: ma sicuramente troverebbe in esse
un lodevole, anche se non sempre ben riuscito, tentativo di far diventare
corpo apprezzabile quella “parola” che da quando mondo è mondo
scoraggia i geni più agguerriti. |
|
di
Aldo
Biagetti
Getulio
Cingolani nasce il 1° febbraio 1891 a Porto Recanati, in una modesta casa
a due piani sita lungo l’attuale Corso Matteotti al civico 168
(all’epoca n. 91), da Domenico e da Giacinta Zaccari. Domenico
svolge una faticosa ma saltuaria attività come bracciante agricolo e pur
avendo l’infaticabile moglie aperta una piccola attività di mercerie
nella casa per il Corso, decide di partire per l’America Latina volendo
assicurare, alla numerosa famigliola, un introito sufficiente per le
esigenze della vita e per sostenere adeguatamente i figli che intendono
dedicarsi agli studi . Va a lavorare nelle miniere di rame, ritorna dopo
11 anni con un’artrite deformante e con diversi malanni. Compra subito
due piccoli poderi in Comune di Loreto ed
un’altra casetta per il Corso, non lavora, ma cura i due campi
tenuti a mezzadria, partecipa alla vita cittadina. È molto attivo nella
Confraternita di Don Albino Mancinelli, sempre presente nelle numerosi
processioni per portare i lampioni di vetro sostenuti con aste in legno
dorato. La moglie è la cassiera dell’Associazione delle Madri
Cristiane, due figli sentono la vocazione religiosa. Maria
si fa suora e dopo anni di attività a Porto Recanati diventa Superiora
dell’Istituto del P.mo Sangue ad Ascoli Piceno. Padre Alfredo
(Nazzareno) è Beatificiario della Basilica Lauretana, Canonico della
Cattedrale di Recanati, ove muore il 29/10/1968, è tumulato a Loreto. Attilio
non prosegue gli studi e preferisce l’attività artigiana (falegname),
Getulio frequenta il Ginnasio all’Istituto Salesiano di Loreto e poi il
Liceo Classico in Osimo, si iscrive a Bologna alla Facoltà di Agraria
ma un anno dopo passa a Medicina. Muore ora il padre (22/08/1911)
ma per le consolidate risorse finanziarie della famiglia non vi sono
problemi per Getulio, per continuare gli studi. Appena
scoppiata la Prima Guerra Mondiale parte volontario per il fronte, nel
1916 – approfittando di una licenza- prende
la laurea, per ritornare immediatamente in prima linea, come
Tenente Medico della Croce Rossa. Congedato
alla fine del 1918 esercita la professione a Porto Recanati ed è subito
un acuto ed attento osservatore dei costumi e dei sentimenti della sua
gente che più avanti, quasi al termine della sua vita, illustrerà in una
serie di poesie nel dialetto locale, sempre così vivo e frizzante. Getulio,
dopo un anno di assistentato in Ancona, con il Prof. Baccarini, si
specializza a Roma in pediatria. Nel 1925, l’11 luglio, si sposa con
Wanda Sirà, un’insegnante nata a Perugia il 25 gennaio 1896, da Andrea,
di Lione, ufficiale postale e
da Maria Fringuelli di Perugia, sarta. Ottenuto il diploma magistrale in
Ancona, ove la famiglia si era trasferita per motivi di lavoro, Wanda, a
seguito anche della prematura morte di entrambi i genitori, si dedica
all’insegnamento prima a Penna S.
Giovanni, poi a Treia. Nel 1919 è a Porto Recanati, ove alloggia,
fino al matrimonio nella Pensione Roma, di Antonio Biagetti, sul
Lungomare di Viale Lepanto. Getulio
e Wanda hanno tre figli, la primogenita muore a soli sei anni. Nel
1932 Getulio è a Roma, quale assistente di uno studioso tedesco, segue
pure un corso di specializzazione sulle malattie tubercolari (all’epoca
molto diffuse), con studi approfonditi sulla cura della tubercolosi
polmonare, con tecniche d’avanguardia per l’epoca. Una
mattina mentre sul ciglio del marciapiedi è in attesa di un mezzo
pubblico, viene investito da una macchina condotta da un alto esponente
del Fascismo, il generale Pariani, che però subito si allontana. Riporta
un trauma cranico e fratture multiple, portato subito all’Ospedale avrà
una guarigione lenta e non completa. Ritornato
a Porto Recanati riprende la sua attività come medico condotto,
professionalmente ancor più preparato, ma sempre attento alle ansie ed
alle aspettative della gente. Gira sempre con due ricettari, su uno
riporta di continuo impressioni, battute umoristiche, frasi che poi
traduce in sonetti nel locale dialetto. Sollecitato
dagli amici si presenta ad un concorso per poesie in vernacolo indetto
dall’Ente Fiera della Pesca in Ancona (1936), ottenendo un buon
successo, classificandosi al secondo posto dopo il maceratese Affede. Sull’onda
del felice risultato, raccoglie una cinquantina di sonetti in un volumetto
che intitola “Al Portu de Ricanati c’è l’usanza”, edito dalla
Tipografia Pupilli, che si presenta con un bel frontespizio, opera
dell’amico Cesare Peruzzi, già affermato pittore. E’ questa, ed è
doveroso sottolinearlo, la prima opera in dialetto portorecanatese, Nel
1937, nell’assistere alcuni ammalati, componenti del Circo Arata che si
sta esibendo a Porto Recanati, Getulio si ammala seriamente, sorgono
complicazioni, gli viene riscontrata una pericardite. Aggravandosi la
situazione decide di farsi visitare – siamo nell’aprile del ’38; va
a Roma dal Prof. Frugoni, uno dei più grandi clinici di quegli anni.
Frugoni lo trova molto debilitato e gli prescrive particolari cure prima
di un necessario intervento, ma un attacco di cuore porta Getulio
precocemente alla tomba, la mattina del 18 maggio 1938. Wanda
provvederà ad ogni necessità e cure dei due figli (sette e nove anni),
continuerà ad insegnare con grande impegno ed elevato rigore morale fino
al 1958, si spegnerà poi – dopo lunga malattia – il 31 gennaio 1983. Sono
passati 65 anni dalla
pubblicazione de “Al Portu de Ricanati c’è l’usanza”,
una raccolta di 50 poesie, forse una cernita fra tante altre che
solo la prematura morte impedirà all’autore di dare alle stampe. Molta
simpatia ed interesse suscitarono subito i sonetti nell’ambiente locale,
anche per questo non si comprende il successivo lungo oblio da parte di
settori della Comunità locale, forse dovuto alla devastante Seconda
Guerra Mondiale, forse al sorgere tempestoso di nuove mode, di altre
attenzioni. In
tutto questo lungo asso di tempo infatti, oltre ad alcuni
appassionati articoli di Sanzio
Flamini sulla “Voce Adriatica” in occasione dei venti anni della morte
e ad una schematica segnalazione a pag 54 di “Porto Recanati nostro”
di Antonio Galieni (Editore Micheloni – Recanati , 1980) registriamo
solo la conferenza tenutasi a cura del CSP nella Sala Consigliare di
Palazzo Volpini il 27 febbraio 1993 su: “GETULIO CINGOLANI – UOMO E
POETA”. Relatore
fu Marino Scalabroni, che volle tracciare un profilo completo del nostro
personaggio, riteniamo giusto e doveroso riportarne integralmente i più
importanti passaggi: “Il
Centro Studi Portorecanatesi nella sua continua ricerca per dare alla
nostra comunità una
coscienza del suo essere e una identità storica ha potuto riscoprire
figure eminenti che, pur ben figurando nei vari campi della cultura,
dell’arte e della fede, per aver operato lontano dai confini limitati
della terra di origine e spesso fuori degli stessi confini nazionali,
hanno perduto ogni riferimento con Porto Recanati, scivolando via dai
meandri della memoria storica del nostro tempo. Non si può dire la stessa
cosa per un eminente figlio di questo paese, la cui voce, dopo quasi 50
anni dalla morte, continua ad essere viva e calda e appassionatamente
cercata dai portorecanatesi: GETULIO
CINGOLANI, medico e poeta, dalla vena popolare vivace e fresca. Per i
portorecanatesi Getulio Cingolani è il poeta locale unico, perenne, il
poeta per antonomasia. Senz’altro è stato il primo a pubblicare una
raccolta di versi in dialetto portorecanatese, ad affrontare una opinione
pubblica impreparata, senza il supporto di circoli di cultura aperti
al gusto del vernacolo, allora piuttosto trascurato dalla cultura
ufficiale. Getulio Cingolani, però,
non era limitato da problemi estetici di sorta. La sua preparazione
umanistica, scaturita da una scuola come il Ginnasio Salesiano di Loreto e
il Liceo Classico di Osimo, era tale da rendere sensibile il cuore ed
agile il pensiero, la sua professione di medico chirurgo gli permetteva un
contatto costante e genuino con il popolo, con la gente comune del paese,
marinai e artieri, in un tessuto sociale ancora omogeneo e pittoresco. La
sua origine, in fondo, era popolare…e la conquista di una laurea non sarà
sufficiente ad imborghesire un carattere indipendente ed anticonformista
come quello di Getulio, che sceglie, per esprimere i suoi sentimenti, il
linguaggio del popolo, il linguaggio che era allora vivo e corrente. È un
linguaggio che consente di toccare il cuore e di esaltare i sentimenti, ma
è anche un linguaggio che può potenziare gli spunti picareschi
e maliziosi tipici della poesia popolare. L’uomo d’altronde
respira a pieni polmoni quest’aria salmastra, perché la sua natura non
subisce forzature, la vena scorre leggera, la rima dei sonetti guizza via,
i ritmi e gli accenti raggiungono l’armonia. Sono acquarelli che non
cadono nel concettoso e artificioso. La prima sensazione, leggendo, è
quella di credere che il poeta abbia
scritto tutto per un suo, personale intimo godimento. Solo l’insistenza
di qualche amico, scopritore di talenti, poteva convincere Getulio
Cingolani a dare alle stampe il frutto della sua ricerca di tipi e di
fatti visti con l’angolazione della sua ottica di osservatore acuto,
malizioso e ricco di “humor”…; “Al Portu de Ricanati” è una selezione accurata di
50 poesie tratte da un cassetto che a parere nostro ne doveva con tenere
molte di più e, forse, ancora più incisive e
più esclusive di quelle prescelte. Probabilmente l’autore si
riproponeva di presentarsi ancora al pubblico degli estimatori con un
altro volume, perché il
successo dell’opera era stato evidente in quel lontano ’36, oggi
estremamente remoto rispetto a questo nostro tempo così pretenziosamente
ricco di facile sapere. Ma Getulio Cingolani, medico e poeta, a soli 47
anni, in quel lontano mattino del 18 maggio del 1938, stroncato da una
malattia indomabile, moriva. Moriva un uomo, padre e sposo, moriva un
medico e moriva un poeta. Lasciava un profondo vuoto nella famiglia, ma lasciava anche un gran
ricordo tra la gente, tra
quel popolo del quale era stato il cantore. Lasciava un vuoto nel campo
del costume del suo tempo che dopo di lui per decenni restò nell’oblio.
Un taglio netto, verticale, una perdita di valori preziosi ed irripetibili
che nessuna ricerca odierna potrà completamente restituirci. Un
patrimonio immenso, linguistico, lessicale, folcloristico è disperso
ormai nella memoria profonda di pochissimi sopravvisuti. La crudeltà del
destino, sottraendo Getulio Cingolani, allora e in quella realtà, ci
derubò dell’unico attento, curioso testimone di un tempo che gli eventi
della storia e del costume costituivano quale cerniera di due modi di
essere di questo paese. Travolto dal progresso, culturalmente colonizzato
dalla televisione, dal turismo, dalla immigrazione massiccia, dalla scuola
che per tanti anni ha concorso ad abbattere le ultime resistenze della
cultura popolare, questo paese si è visto crescere in termini di spazio e
di abitanti, più macchine, più ricchezza, più godibile livello di vita.
Ma resta una grave crisi di identità, reale e concreta. Per questo
abbiamo sentito il bisogno, pressante come un debito di coscienza da
pagare, di ricordare l’anniversario della morte di Getulio Cingolani,
cui tutti dobbiamo riconoscenza.” Continuando
il suo intervento Marino Scalabroni ricorda come nel 1958 Sanzio Flamini
avesse sollecitato l’Amministrazione Comunale e la Pro-Loco per una
commemorazione del “nostro unico testamentario della poesia
dialettale”. Anche
quella di Sanzio Flamini fu una voce nel deserto. Né
allora – conclude Scalabroni – venne raccolto l’appello affidato
alle colonne di un giornale,né oggi è stato ancora accolto l’appello
che il nostro Centro Studi ha lanciato affinchè il nome di Getulio
Cingolani sia onorato dalla città che gli diede i natali, dedicando a
quest’uomo eminente una strada, una piazza, una lapide a perenne
testimonianza. Oggi, mentre si conclamano i valori e si esalta l’uomo teorico e metafisico, facilmente si dimenticano quei valori che, qui tra noi, hanno veramente incarnato e vissuto le virtù civili, meritando il ricorso delle future generazioni. |
|
di
Alessandra Cerioni
Pubblichiamo volentieri il breve omaggio, ma quanto
sentito!, che la giovane jesina Alessandra Cerioni rivolge al nostro
Porto. Ne siamo felici e ringraziamo di cuore. Se
giunsi volontariamente o involontariamente in quel Porto non credo di
averlo capito ancora. Perché quando ti volgi verso qualcosa o ne sei
attratto, non sai, nel momento in cui avviene, se dipende da una tua
volontà o si tratta di altro, qualcosa di diverso, superiore alla
coscienza, che da quella parte ti spinge. Lì
dovevo andare per lavoro, questo è ciò che con lucida coscienza e
certezza sapevo, ma sempre lì era anche che sentivo di voler andare. Da
quella piccola piazza, fiera di fronte al suo mare, quella passeggiata
infinita che lo fiancheggia e che con esso va a congiungersi al termine
dell’asfalto e delle mattonelle. Le
vie così regolari nella loro disposizione, nei colori e nella fattezza di
quelle case. In una di quelle alloggiavo e mi piaceva pensare che proprio
lì, chissà, molti prima, qualche lancettaro si accingeva a dormire, con
la preoccupazione che quella brezza, che aveva accarezzato il suo viso al
rientro, fosse l’avvertimento del mutare della direzione del vento
buono: per lui quel mare era materialmene fonte di vita. Vivevo
spesso di notte e proprio con la notte capii che il fascino di quei luoghi
non era dato solo dalla luce del sole che li illuminava e mostrava. Io
non sono nata in un posto di mare e mi ritrovavo così a pensare
continuamente a quella presenza, al rumore delle onde che senza fine si
infrangono sulla riva e su quella punta di scoglio e continuamente si
ricreano. Nella città senza mare la gente, per ritrovare il proprio
equilibrio, credo si rivolga alla luna….però la luna è così lontana e
piccola! Ora
non mi trovo a Porto Recanati, ma una gioia illumina il mio essere e
quando riesco a chiudere gli occhi ed incontrare nuovamente quei colori,
ricordo la luce del sole riflettersi sul mare. Tornerò, carissimo Porto, |
|
di Gabriele
Cavezzi
Pubblichiamo con piacere (anzi, per noi è un onore) questa comunicazione di Gabriele Cavezzi, presidente dell’Istituto per la ricerca delle fonti della storia marinara del Piceno di San Benedetto del Tronto, letta in occasione delle giornate sulla poesia sambenedettese del gennaio 2000. Con ciò, i nostri ‘dintorni’ si allargano, ma ne siamo assai felici. In
questi pomeriggi in cui abbiamo incontrato la poesia ed il dialetto, i
poeti e la loro lingua, sono state dette molte cose, per cui ritornarci su
mi sembra ozioso. Affronterò pertanto subito quella che ritengo “na bella presura che me scjete date” (una bella presura che mi
avete dato), ossia il tema che
mi è stato assegnato. Ma
prima bisogna che mi liberi di un peso che riguarda una questione che
forse non farà piacere a tutti, e
che comunque fa male anche a me che la debbo dire: il dialetto come
strumento di pensiero, come mezzo di comunicazione verbale e scritta, come
tramite di anelito poetico, è morto, o sta morendo, e noi nei nostri
incontri ne abbiamo celebrato gli ultimi sussulti. Per
dirla in sambenedettese, il dialetto “fa
i cazette” (fare i calzetti
a significare i movimenti incontrollati che fa il morente prima di tirare
le cuoia). Questo per parlarci chiaro, affinché non si confonda la
memoria con l’attualità e si riesca a veder chiaro su ciò che ci
aspetta – rispetto a questo problema - come dovere di sambenedettesi,
come compito civile e culturale di testimoni privilegiati di una delle
stagioni più straordinarie della storia dell’umanità, il XX secolo, in
uno dei posti più belli ed
interessanti del mondo tra Tronde e
Tescjé (Tronto e Tesino i due fiumi che ne limitano il territorio
storico e culturale). Pensare di riportare alla fruizione corrente il
dialetto, di difenderlo sino alle estreme conseguenze, significherebbe
compiere un’operazione delirante che non sarebbe compresa da quelli ai
quali invece dobbiamo far pervenire, accettare e vivificare la nostra
testimonianza. Anni
fa avevo ideato di programmare un Corso di Riqualificazione sulla Storia
ed il Dialetto Sambenedettese destinato a uomini politici, funzionari
comunali, operatori economici, giornalisti, insegnanti scolastici, in
quanto avvertivo il sempre più forte distacco, soprattutto da parte delle
prime due categorie, come “corpus movens” dalla vita e dalla cultura
sambenedettese. Ovviamente seguito da un esame per accertare il profitto
dei discenti. Ma poi ho intuito che sarebbe stato frainteso e forse se ne
sarebbe colto solo l’aspetto provocatorio, peraltro molto evidente, e
sarebbe andata perduta la finalità meramente didattico-formativa. La
mia era una proposta indirizzata anche ai tanti autentici sambenedettesi
ridotti a semplici “zombie” dai processi di espropriazione e di
promozione al consenso, condannati a recitare solo il ruolo di fruitori
dello spettacolo di una montante alienazione con il proprio passato, la
propria memoria. Ma
c’era anche una difficoltà che avvertivo ed era quella della sempre più
rarefatta presenza e disponibilità di docenti, per cui non se ne fece
nulla. Ed ora, per uscire da questi paradossi dialettici…sul dialetto
(mi si perdoni il bisticcio), da queste cattiverie un po’ leghiste ma
non secessioniste…dope che so
messe le ma ‘nnanze pe nen sgrugnamme lu mose (dopo che ho messo le
mani avanti per non cadere di faccia a quindi farmi male al viso) …dico
che dobbiamo prendere coscienza che viviamo in una società che sempre di
più va verso processi di omologazione, dove i diversi apporti culturali
ed i valori che li esprimono non subiscono mediazioni solo ponderali ma
soggiacciono a leggi mercantili. E sarebbe quindi altrettanto colpevole
non impegnarsi per conferire, all’interno di questa sorta di Giudizio
Universale che è il Mercato Globale degli oggetti e dei valori, anche il
nostro contributo, affinché tutto non scompaia per sempre ed
irrimediabilmente. Dicevo
del nostro futuro o almeno del futuro di un impegno, per rispondere al
quesito della nostra enunciazione … “préme
che se fa notte”. Anzitutto
occorre affermare un principio che se riguarda tutti i contesti dove una
lingua locale ha rivestito o riveste carattere di peculiarità, ancora di
più riguarda S. Benedetto, dove essa si è andata formando attraverso un
sovrapporsi ed un integrarsi di circostanze originali assai diverse nel
tempo e nelle modalità: la storia di S. Benedetto è anche la storia
del suo dialetto. La lettura della prima (la storia) ci consente di
comprendere il secondo (il dialetto), ma anche studiando il secondo (il
dialetto) si può capire meglio la storia di questo posto e della sua
gente. Quindi
il dialetto come risultato delle sue diverse forze geniche ma anche come
fonte della storia.
Sulla scorta di questo principio di duplicità e di integrazione
occorre ricostruire il nostro passato, non più preda di processi di
idealizzazione, di esaltazione campanilistica, ma frutto di rigorosa
ricerca delle fonti, avente presente sempre il limite di queste. Su tale
argomento credo che si stiano facendo dei buoni passi; e S. Benedetto
risulta uno dei paesi d’Italia con il più alto grado di qualificazione
nell’indagine e di quantità di indagatori, in rapporto al suo peso
demografico ed alla sua storia. Ma la quantità di ricerca prodotta e di
ricercatori supera quella dei lettori e qui sta uno dei nodi primari da
sciogliere.
Avvicinare un numero sempre maggiore di utenti a quei risultati
consentirebbe di capire quanto ricca sia stata di apporti universali la
storia di S. Benedetto e quanto universale sia stato il contributo dei
sambenedettesi alla storia di altri paesi per rispettarla e comportasi di
conseguenza in tutti i campi dell’operare umano locale.
Il territorio ed il mare non sono state solo metafore di un
racconto ma le cause prime degli eventi, degli arrivi e degli esodi. Sulla
spiaggia non sono approdate solo barche, “ciuschie” (residuale della marea) e “quanne jè arbé, cucchie de secce e loffe de talafé” (quando è
Garbino si pescano solo ossi di seppie e “loffe” di delfini, ossia le
muccillagini), per intenderci, ma anche uomini che parlavano la lingua
franca dei mestieri alieutici provenienti da tutte le isole e le coste
dell’Adriatico. Lungo le sue strade e i suoi slarghi hanno camminato e
sostato eserciti di tutta l’Europa medievale, rinascimentale,
napoleonica e delle alternanze successive: e quelli non hanno lasciato
solo “cacarozze de sumare” (escrementi di asini) e “bresciate i pajò” (bruciare i pagliericci, ma anche abbandonare
repentinamente una situazione dopo averne procurato i guasti) degli
accampamenti. Attraverso la frontiera meridionale non sono passate solo
“trendarole” (venditrici di pesce che giungevano a piedi
attraversando il fiume Tronto con i panieri sul capo) e “cundrabbannire” (contrabbandieri) , ma anche parole e modi di dire
che si confondevano con quelle degli altri del retroterra che affluivano
man mano che le opportunità di vita vi diventavano più propizie.
I riscattati dalla schiavitù delle diverse piraterie non hanno
riportato solo la voglia di riabbracciare i loro cari, quando l’hanno
avuta, ma anche i saperi ed il linguaggio dei luoghi vissuti ed
attraversati. Taluni, rientrando 50 anni dopo, parlavano arabo e pregavano
Allah in via delle Conquiste (oggi
solo Conquiste e conduce al
Cimitero)! In una nemesi del nostro dialetto oggi si sente parlare
sambenedettese a bordo di navi oceaniche da equipaggi di colore!
Basta ripercorre le genealogie delle nostre famiglie per capire
quale crogiolo genetico e linguistico deve essere stato S. Benedetto in
questi ultimi tre secoli! Dal 1798 al 1944, in uno spazio inferiore ai 150
anni abbiamo registrato 50 passaggi di eserciti più o meno regolari,
acclamato decine e decine di bandiere, persino i cosacchi sono dovuti
intervenire con i loro scudisci per sedare i tumulti davanti al forno del
pane! Abbiamo subito 12 guerre di cui due mondiali con effetti devastanti
e duraturi sul nucleo abitato e sul tessuto demografico; abbiamo visto
percorre il vento della morte endemica ben 5 volte, tre per il colera, una
per la spagnola ed una per il tifo petecchiale. E stiamo parlando di una
popolazione uscita da privazioni e fatiche immani, lutti in terra e tanti
sul mare, nei mestieri più umili e disagiati, che hanno finito con il
plasmarne il carattere ed innegabilmente la lingua, unico strumento di
comunicazione in un universo elementare per quei bisogni. Sino
alla fine del XIX secolo l’analfabetismo era quasi totale negli uomini,
ma nella donna era la regola; nel periodo napoleonico gli editti e le
ordinanze dovevano essere lette in chiesa “nel linguaggio degli
idioti” perché il popolo non capiva nemmeno l’italiano, quindi la
voce ed il dialetto erano giornale e televisione, internet e fax per
tutti. Allora si comunicava più con i simboli delle vele ed i pennoni che
con il foglio di carta, con le fochere più che con la posta. Nel
suo libro su S. Benedetto, Guidotti ci racconta di quando le barche
facevano “conto” e quella che aveva incassato di più aveva diritto di
fregiarsi con i pennoni più numerosi e sgargianti, parlando quindi con le
sferze colorate: ed ogni movimento con il corpo della barca assumeva un
significato nel linguaggio muto per prendersi in giro tra equipaggi,
scambiarsi allusioni e saluti. Un tempo era più importante comunicare con
gli elementi che con le creature viventi e gli uomini dovevano saper
decifrare il linguaggio del vento prima di poterlo tradurre in codici
sonori, in parole. Ed i confini materiali erano gli unici da superare, non
esistendo quelli della paura ed ancor meno quelli politici. Il curato si
trovava in difficoltà persino a somministrare i sacramenti a sud dell’Albula
quando sopravvenivano le pive de lu
fusse (la piena del fosso) Solo
nel XVII secolo si è aperta una strada litorale lungo la marina e quindi
le barche hanno costituito il veicolo privilegiato per scambiare merci e
fonemi per un lungo periodo. E non mi si venga a dire che questa è una
storia eguale a quella de Carrassà (Carassai comune del retroterra marchigiano, allusivo
delle origini del Capo-Servizio della Cultura del Comune) o de
Curruppele (Corropoli, comune
del retroterra abruzzese, idem dell’Assessore comunale ai Servizi
Sociali). La nostra storia non ce la regala nessuno, dobbiamo recuperarla
da soli prima che altri, magari in sede accademica e quindi non più
discutibile, ci confezionino le alternative per il loro uso mediatico,
strumentale rispetto a sistemi gerarchici interni ad altre culture. Il
cognome più diffuso a S. Benedetto, ormai da qui sparso in tutta Italia e
nel Mondo è Palestini,
evoluzione di quello che nel XVIII sec. era Palestrina,
designante di calafati e pescatori di Palestrina in quel di Chioggia, qui
emigrati alla fine del secolo precedente! Sarà un Palestini, Francesco, a
metà del XX secolo, a scrivere la grammatica su questo nostro dialetto, a
raccogliere e consegnarci con essa un glossario ricchissimo, con la storia
del suo formarsi. Ho
qui in mano un cartoncino augurale dell’Assessore Regionale alla Cultura
in cui ci si dice NEL 2000 COME 3000 ANNI FA UNITI PER LA CULTURA DELLE
MARCHE : direbbe il coatto
romanesco Ma dde che?! L’abruzzese
acculturato: Ma che ciazzecca!
L’ascolano sfrigne, cioè ironico, Che
jè ditte? Il sambenedettese maschio Ma
levite ambù de jesse! (Ma levati di torno)..e
la donna..Ma nen sciapenejete! (non
siate scipiti, da cui il verbo
sciapiniare) Dico
io, come si fa a mandare auguri più stupidi e falsi di questi quando per
3000 anni ci siamo scannati, prima tra Galli e Piceni, poi tra quelli che
erano amici di Roma e gli altri, tra quanti finivano sotto i barbari e gli
occupati dai Bizantini, più tardi tra gli amici della Chiesa e quelli
dell’Imperatore, tra soggetti
ai comuni e gli altri alle signorie del nord della Marca, ai Malatesta, e
quelli e questi tra loro…fino ad oggi che, ci sentiamo occupati e
governati da un potere culturale che parla solo romagnolo, al massimo
anconetano! Ma
per tornare a noi dobbiamo anche dire che occorre altrettanta
determinazione nello studiare questi nessi a cui facevo cenno ed i
risultati finali che ci sono giunti e di cui abbiamo fruito nella nostra
fortunata adolescenza, nella nostra giovinezza, consumato nella maturità:
un dialetto ricco di assonanze e con un potere evocativo straordinario,
forte e duttile nel contempo, che consente di esprimere il banale e
l’indicibile con la stessa semplicità lessicale, con la stessa
mediterranea sonorità. Ed è
questa una delle componenti più difficili da preservare come prova
testimoniale. Prima
che il tempo ci divori e con noi la nostra lingua, pardon, il nostro
“dialetto”, occorre codificare soprattutto i fonemi, per salvare
quella che viene localmente definita “la calata”, da non confondersi
con “culate o culature”,
“culate nel senso di fortuna, culatore
nel senso del bucato con la cenere”, oppure “calata de rete”, “calate
de sole” nel senso l’una da discendere in mare (la rete) e
l’altro dietro i monti (lu sole) (Mosce
d’immerne, Brescecce d’estate) (i due colli che caratterizzano
altrettanti luoghi del tramontare del sole). La “calata” nelle diverse
varianti femminili e maschili, de “su dendre” e de “jo la marene”,
de i “pajarà” o de i “menderò”, de “Sanda Lecì” e de “jo
bescì”, de lu “ponde rotte”, vicino “lu fusse de i zenghere”,
dei momenti di conflittualità verbali e di invocazione, di
“rifrecazione” o di ammonimento, di relazione: “Ua cì”, “uà cò,
“uà ze”, “uà nepò”, “serella mmine”…coordinate ormai
riconoscibili solo da pochi in una socialità frantumata dal progresso,
privato dell’onomatopeico, deturpata dalla sintesi tecnologista,
ingannata in “tempo reale”. Occorre recuperare tutti i modi di dire ed i personaggi caratteristici, i soprannomi (quanti di questi sono diventati cognomi!) ed i luoghi, le usanze ed i riti, i simboli e gli scongiuri, insomma portarsi in questo secondo millennio - che ancora deve giungere – con il più prezioso dei tesori che ci hanno lasciato i nostri padri: la loro storia e la loro lingua! Un lavoro questo che già è iniziato grazie ad alcuni volontari, e tra questi i “puete nnustre”, i morti ed i viventi. Attenti, qui il possessivo nnustre sovrasta il sostantivo di poeti: noi diciamo pardete, mammete nella seconda persona, ma nella prima babbe mmine, mamma mmine, i fratjie nnustre; quindi nnustre viene impiegato per sottolineare una complicità, un’appartenenza quasi parentale con quei poeti, a privilegiarne questi aspetti di legame prima. |
di
Giovanni
Mordini
Una ricerca meritoria di
Giovanni Mordini, che da tempo chiede un riconoscimento del sacrificio
delle vittime civili delle due guerre mondiali del secolo scorso da parte
dell’Amministrazione Comunale. Ci auguriamo che il suo appello sia
ascoltato. Ci auguriamo anche altre
segnalazioni per l’eventuale completamento dell’elenco. GUERRA
1915 – 1918
GUERRA
1940 – 1945
Nel
ringraziare Giovanni Mordini per averci ricordato dei concittadini da
troppo tempo dimenticati, rileviamo che sui diciassette nomi in elenco ben
quindici erano di età tra i 5 e i 23 anni, giovani e giovanissimi dunque;
solo Annita Gasparini era in età adulta mentre Vincenzo Matelicani era
l’unica persona anziana. |
|
di Sanzio
Flamini
Nella nostra storia non si
parla troppo spesso delle donne, relegate nella mitologia del matriarcato.
Sanzio Flamini ce ne ricorda una, Maria Boyer, di cui si è già scritto
in ‘A Marcello non piacciono le fave’ (Recanati 1999), a proposito del
suo energico intervento in favore di un ragazzo che stava per essere
fucilato dai tedesch nel marzo 1944 (pp.49/50). L’episodio che segue
riguarda un momento critico della vita del ragazzino Flamini nel quale la
signora Mazza mostrò ancora una volta di essere figlia del colonnello dei
Bersaglieri Andrea Boyer, uno di quelli che entrarono a Porta Pia nel
1870. Ricordate
la signora Mazza? Sì, proprio lei, la moglie dell’indimenticato dottor
Mazza. Anche la cicatrice dei cinque punti di sutura alla mano sinistra me
lo ricorda ogni tanto, specialmente quando tira ‘el vento de leante’
(il vento caldo-umido, est-ovest). Abitava
laggiù, in fondo al paese, a ‘Sammarì’, vicino al campo di Trucchia,
praticamente estrema periferia di allora. Erano piazzate lì le ultime
abitazioni, il fiume Potenza sembrava assai lontano e Leopardi insisteva
“..e chiaro nella valle il fiume appare..”. Lo era effettivamente a
quei tempi. Dunque,
la signora Mazza, circa duecento metri da casa mia in via Garibaldi.
Venuta a conoscenza che i miei genitori avevano programmato di mandarmi
tra i ‘discoli’, cioè in riformatorio, affrontò come mi è stato
riferito, mia madre, donna mite e suggestionabile, talvolta vittima
caratteriale di ‘Battinello’ (Giovanni Battista, n.d.r.), mio padre
(soprannome non dedotto da qualità fisiche o morali, ma dovuto all’uso
scriteriato di mutare la naturale etimologia in senso più che altro
comico o grottesco. Ne sanno qualcosa i nostri poeti dialettali). Lo
scontro-incontro avvenne in mezzo alla strada, tra via Garibaldi e viale
Lepanto, di fronte a uno dei rinomati ristoranti locali. Il classico
brodetto, è sottinteso. Quasi un alterco. La signora del Dottore, alta,
snella, elegante, di ottima famiglia borghese, si ricompose com’era nel
suo stile di donna ben educata. Disse a mia madre, tra l’altro, che
stava commettendo un grosso sbaglio. Sanzio, il sottoscritto, non era
certo da considerare un delinquente sciolto o a pacchetti, e nemmeno i
suoi compari di cordata, ragazzacci della banda cui si accompagnava
quotidianamente. Eravamo
vivaci, forse anche troppo, rompiscatole senza apriscatole, disturbatori
della quiete pubblica, quiete forzosa nel periodo ventennale fascista;
vandali in sedicesimo per gioco, assolutamente innocui se raffrontati con
i ‘mostri’ dei giorni nostri. Dopotutto,
che facevamo? Lo sparo col botto: carburo dentro barattoli di conserva
Cirio, specialmente davanti le porte dei palazzi e nelle pubbliche piazze;
si rubacchiava qualcosa nelle campagne vicine, per fame, purtroppo; i
lampioni di viale Lepanto presi a fiondate, così i vetri di alcuni
finestroni di case abbandonate e diroccate. Da
annotare le rincorse disperate e buffe sopra biciclette sgangherate del
capo guardia Salvioni e di Giggio Fabbracci, l’altro pizzardone
portolotto. La
faccenda dei ‘discoli’ fu archiviata. Buon per me. La signora Mazza,
fervente religiosa, fuori dal bigottismo comune, aveva diffuso,
pressappoco lo strano messaggio: “Chi frequenta i Salesiani non esce
mascalzone!” Dal
mio armadio di scheletri, zeppo di rimembranze e riferimenti infantili
riemerge sempre con affetto rispettoso la signora del Dottore che dietro
le inferriate del piccolo giardino ci vedeva passare, mezzi stracciati,
scarpe di cartone, visi veramente pallidi, quasi tutti i pomeriggi verso
le nostre bravate e scorribande dentro e fuori il paese. |
Sentenza
Cintioni-Scalabroni
L’amico e socio Vincenzo Rosati ha risolto il nostro
dubbio sul destino di Tommaso Cintioni e Crispino Scarafoni, entrambi
giudicati autori dell’assassinio di Biagio Budini, avvenuto al Porto
l’11 febbraio 1849, come narrato nel primo numero di Potentia (Inverno
2000 – pp.12/19). Fascicolo
236/484 Anno 1861. (I documenti che riportiamo sono tratti dai
fascicoli A e C). Sentenza
del 20 maggio 1851
Sagra
Consulta – Martedi 20 maggio 1851. Il secondo turno del Supremo
tribunale….si è adunato nelle solite stanze del Palazzo Innocenziano in
Monte Citorio per giudicare in merito, ed in forma di legge, la causa
intitolata Macerata-Recanati ossia Porto, di omicidio contro Tommaso
Cintioni di Liberato, in età di anni ventisei, coniugato con figli, nato
e domiciliato in Porto Recanati di professione falegname e Crispino
Scarafoni del vivo Bonaventura di anni ventisette celibe, nato a
domiciliato come sopra di professione calzolaio. Viste e ponderate le
risultanze degli atti processuali. Inteso il rapporto della causa fatto
dall’Ill.mo e R.mo Monsig. Luigi Fiorani Giudice Relatore. Scoltate le
conclusioni Fiscali e le deduzioni verbali del Difensore, che ebbe per
ultimo la parola dichiarando di non avere altro da aggiungere. Chiusa la
discussione e rimasti soli i Giudici per deliberare. Invocato il Nome
SS.MO di DIO, il Supremo tribunale ha reso e pronunciato la seguente
SENTENZA Visto
e Considerato quant’altro era da vedersi e considerarsi Il
Secondo Turno del supremo tribunale della S.Consulta ha dichiarato e
dichiara constare in genere di omicidio con animo deliberato a danno di
BIAGIO BUDINI avvenuto la sera degli undici Febbraio
milleottocentoquarantanove e che in specie ne furono, e sono, colpevoli
per spirito di parte TOMMASO CINTIONI e CRISPINO SCARAFONI, ed in
applicazione degli articoli duecentosessantacinque e centotre
dell’Editto Papale a maggioranza di voti li ha condannati e condanna
all’ultimo supplizio, avendo uno dei Giudici ritenuto la semplice
provocazione. Inoltre li ha condannati alla rifazione dei danni verso la
parte offesa, al pagamento delle spese processuali ed al rimborso degli
alimenti a favore del pubblico Erario da liquidarsi a forma di legge. Però,
la mancata unanimità diede luogo a una revisione del processo, stabilendo
così il regolamento organico e di procedura criminale in vigore nel Regno
Pontificio. Il 17 febbraio 1852 la sentenza, questa volta pronunciata dai
due turni riuniti del Supremo Tribunale, venne confermata con nove voti
contro tre. Nel documento relativo si legge comunque, sul lato sinistro
della facciata di copertura del fascicolo la dicitura COMMUTAZIONE, e poi: Dall’Udienza di Nostro
Signore del 4 maggio 1852 – Sua Santità si è degnata per grazia
speciale di commutare a TOMMASO CINTIONI e CRISPINO SCARAFONI la pena
dell’ultimo supplizio in quella della galera in vita sotto stretta
sorveglianza.
Quindi,
mentre Scarafoni e Cintioni avevano già subito la prima condanna si stava
svolgendo (in Ancona?) un altro processo all’uccisore di Camillo Budini,
fratello del povero Biagio, ammazzato poco dopo di lui da questo tale
Silvestro Bocci. |
Soprannomi
Non esiste nella
letteratura relativa alla storia del Porto una documentazione
storica sui soprannomi. Di quelli più recenti si può trovare un
lungo e ancora incompleto elenco nell’appendice de ‘FATTU PE’
DESCURE’, il vocabolario del dialetto portorecanatese (pp. 297/301),
disponibile presso la sede del CSP. Tuttavia, nel corso delle nostre
ricerche, ci siamo imbattuti qua e là in soprannomi dei quali oggi non si
ha più traccia, almeno per la maggior parte. Ne diamo un elenco nella
speranza che in futuro se ne possano presentare altri. In parentesi,
l’anno in cui è attestato il soprannome. TANFANO (1685) – è
il più antico che conosciamo. Attribuito a Domenico di Nicola di
Domenico, anni 32, componente dell’equipaggio della barca di Domenico
MEZZALINGUA (anche questo è certo un soprannome). Di lui ha dato notizia
Antonio Eleuteri nella sua relazione al primo seminario sulle fonti per la
storia della civiltà marinara del Piceno svoltosi a S. Benedetto del
Tronto nel 1995. La moglie, 31 anni, si chiamava Maria: la coppia aveva
sette figli, di cui due maschi. SCIALACQUATO (1713) – Era un tale Simone, caduto prigioniero dei
pirati nel 1713. Citato nel nostro Dizionario del Porto, inedito. GABRIELLINO
(1802) – Se ne ignora il nome vero, citato nei documenti relativi
al processo contro Crispino Valentini (Carte del CSP), accusato di
‘delinquenze’ varie in qualità di Deputato di Sanità del Porto. PITTORETTO (1806)
– Stessa fonte, ma di lui si ignora tutto. Forse era un anconetano. SGRANONE
(1807) – Di nome Domenico, stessa fonte che il precedente. CIANFRONE
(1807) – Domenico Bufalari, ancora nei documenti del processo
Valentini. Era incaricato di pesare il pesce per conto della dogana. IL
soprannome ha resistito fino ai nostri giorni. DROGHETTO
(1831) – Domenico Paoltroni, citato nei documenti relativi alla
commisssione istituita nel Porto nel 1831 per fronteggiare l’epidemia di
colera (Carte del CSP). SPORTOLONE (1831)
– Angelo Lucangeli, iniziatore della fortuna della famiglia, all’epoca
commerciante. Citato in E con la pelle dei Monsignori, in Potentia
– Archivi di Porto Recanati e dintorni, n° 1. VINCENINA
(1849) – Vincenzo Budini, citato in Potentia c.s.,
fratello di Biagio Budini, ucciso l’11 febbraio 1849 durante il breve
periodo della Repubblica Romana. PULENTINO
(1849) – Citato in Potentia c.s.; di lui non si sa altro. PORTUCCHIO (1849)
– Bonafede Onofri, Potentia c.s., sospettato di aver partecipato
all’assassinio di Biagio Budini o di aver istigato gli autori. FERRETTO
(1849) – Citato in Potentia c.s.; nessun’altra notizia. CAGNA’
(1850) – Giovanni Leonardi, chiodarolo (Carte del CSP tratte
in fotocopia dalle Carte della Parrocchia di san Giovanni Battista).
BOTTIU’
(1853) – Vincenzo Braconi. Soprannome valido anche per la moglie
Vincenza. Carte CSP c.s. SBICICCHIATO (1858) – Ferdinando Solazzi di
Fiore. Carte del CSP c.s. PIGNOCCO
(1858) – Gino Salerni. Carte del CSP c.s. |
Rame
per la Patria
Il documento che riproduciamo risale al maggio 1941
ed è una testimonianza dei sacrifici richiesti agli italiani in sostegno
delle necessità della guerra. Ci è stato fornito da Elvira Pasqualini.
La fotocopia tratta dall’originale è conservata tra le Carte del CSP.
4.parte (da rilasciarsi a chi cede il rame)
ENTE
DISTRIBUZIONE ROTTAMI Sezione
metalli non ferrosi Il Sig. Pasqualini Francesco Ai sensi dell’articolo 6°
del RDL 13 Dicembre 1939 – XVIII n. 1805 il Ministero delle Corporazioni
ha fissato i seguenti prezzi: Sono state consegnate parti non in rame come segue: Il regolare documento di vendita verrà redatto dai
contraenti. Porto Recanati 30 maggio 1941 – Anno XX. Il
Rappresentante del Comune
Il
Negoziante |
Una
lettera per Gigli
Beniamino Gigli dovette
difendersi, dopo la seconda guerra mondiale, dall’accusa di
collaborazionismo con i tedeschi, accusa dalla quale fu ampiamente
assolto. Lo fece anche con un opuscolo di 35 pagine di cui il CSP possiede
copia, stampato in 50 mila esemplari dalla Società Tipografica Editrice
Italiana di Roma (nel ’45?), in vendita al prezzo di 20 lire (ricavato
devoluto in beneficenza). Corvetta Danaide (con
disegno della nave) Compagno Gigli, Il sentiero popolare non si chiuderà per voi, signor Gigli vi ho
sentito per la prima volta nell’estate del 1947 in un film musicale; un
impressione sbalorditiva! E’ difficile esprimere la gioia che voi
procurate con la vostra apparizione; come se nel teatro fosse apparso il
sole con la sua luce, ed il suo calore avesse scacciato le tenebre
notturne e la fredda nebbia. Ora la vostra voce canta ovunque. Se mi trovo nel bosco, nelle vie della
città, a casa sul lavoro, dappertutto una meravigliosa voce canta
nell’animo. Voglio di nuovo vedervi e risentirvi: per questo i film con
la vostra partecipazione si vedono venti volte. Non vi sono ora dischi di
vostra esecuzione, perciò l’unico modo di sentirvi sono i film. Nella
stupidaggine sentimentale dei film, Voi rimanete sempre un semplice e
grande uomo, perché non solo vi si ascolta con massimo godimento, ma vi
si vede anche con grande piacere. Forse in questo è il segreto del vostro
invincibile fascino. Se
voi sapeste come ci sono necessarie le cose veramente belle, veramente
umane. Abbiamo sofferto l’assedio della città, abbiamo visto e sofferto
tante cose terribili, ed ora noi lavoriamo molto, moltissimo: è per
questo la vostra incomparabile arte solleva le forze e dona fiducia nel
bello. Vi
si ama con amore illimitato, si crede senza reticenze alla vostra verità;
ci si abbandona alla vostra arte con la fedeltà e felicità con la quale
ci si abbandona ai grandi artisti. Di
voi non si può discutere, si può solo godere del vostro canto. La
necessità di vedervi e sentirvi e d’amare la vostra arte, diventa tanto
naturale ed inevitabile, come la necessità di respirare l’aria
vivificatrice della primavera e riscaldarsi ai raggi dorati del sole
estivo. Voi
forse non amate i russi, perché non avete onorato di una visita il nostro
paese. Forse questo non dipende da voi, e certamente non da noi. Se per
vedere i vostri film ci sono sempre file, potete immaginare, cosa
succederebbe se ci fosse un vostro concerto. Voglio
credere che siate vivo e vivrete ancora a lungo, voi che date tanta
felicità agli uomini, dovete essere sempre felice; per questo, mai una
ruga dovrà essere sulla vostra fronte e mai una piega amara sulla vostra
bocca.
NICOLAJEVA LENINGRADO Via TOLMACIOV 18
|
di
Aldo
Biagetti
MAGGIO
SABATO 19 - Presentazione, al Teatro Kursaal, dell’evento culturale di maggior rilievo di questi ultimi anni, la Mostra sui reperti archeologici dell’antica “Potentia”, dal suggestivo sottotitolo “Quando poi scese il silenzio…”, che si potrà ammirare fino al 26 ottobre nei locali al piano terra del Castello Svevo. LUGLIO
DOMENICA
1 -
Il romano CLAUDIO ANGELINI, con la poesia “Lente
voci” vince la XVI^ Ediz.
del Concorso Internazionale di Poesia “Città di Porto Recanati.
SABATO 14 -
Organizzata dal Centro Sociale “Anni
d’Argento” dall’Associazione
Culturale Coro a Più Voci si apre la XXV^ Ediz. della Marguttiana
Portorecanatese, nello slargo delle Scuole Elementari, a margine di Corso
Matteotti. Nell’arco dei tre cicli espositivi, che avranno termine il 30
agosto, esporranno 38 artisti.
SABATO 21 -
All’Arena Gigli, organizzata dal Centro Studi
Portorecanatesi e dalla locale Croce Azzurra e con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale, AZZURRA 2000, cerimonia di premiazione
dei vincitori della 1^ Ediz. del concorso di poesia dialettale marchigiana
“Emilio Gardini”, cerimonia impreziosita dal concerto della Banda
Dipartimentale della Marina Militare di Taranto. Risulta vincitore, con la
poesia “A lume de cannela”, Aldo Leoni di Apiro (ritira il premio la
figlia Liana, perché purtroppo l’autore è deceduto). Secondo Franco
Ferri di Pesaro, terzo Elio Morelli di San Benedetto del Tronto. AGOSTO
-
Alla palestra Diaz inaugurazione della Mostra
Antologica di GABRIELLA MINGARDI SENIGAGLIESI, che presenta 150 tele, a
testimonianza di un percorso artistico che ha ricevuto lusinghieri
consensi da critici, riviste d’arte e pubblico. Presenta Donatella
Donati che ha anche curato il catalogo della mostra.
SABATO 25 -
All’Auditorium all’aperto (Cortile Sud delle
Scuole Elementari) cerimonia di premiazione della IV^ Ediz. del Premio di
Pittura Estemporanea “Porto Recanati e dintorni”. L’apposita giuria
proclama vincitore SAVERIO MAGNO di Grottammare, secondo classificato
Oscar Gricia di Roma. OTTOBRE
DOMENICA
7 -
All’Auditorium della Scuola Media presentazione
del volume monografico della rivista “Potentia” del Centro Studi
Portorecanatesi su “LA SCIABICA”. Ricorrendo, in tale giorno, il 430°
anniversario viene ricordata la Battaglia di Lepanto, relatore Aldo
Biagetti. |
(1/5/2001 – 31/10/2001)I
fatti e i giorni
-
Il 30
maggio, in consiglio comunale, viene conferita una onorificenza civile ai
carabinieri Vito Cappilli e Nicola Centonze per aver salvato la vita di
una bambino in procinto di cadere da un balcone. -
Il 24
giugno, a cura del Comitato degli ex dipendenti, si inaugura una lapide a
ricordo dell’attività del cantiere navale Gardano & Giampieri nella
facciata dell’edificio che ospitava gli uffici. -
Alla data
del 30 giugno risultano residenti al Porto 5089 maschi e 5007 femmine, per
un totale di 10 mila e 96 persone. -
Il primo
luglio, il concittadino Marcantonio Trevisani è promosso Ammiraglio di
Divisione. -
Primi di
agosto: muore Goffredo Jorini, sindaco di Porto Recanati dal 1946 al 1959. -
18
agosto: Castelnuovo vince il Palio di san Giovanni per la quarta volta. -
Agosto/Settembre.
La General Electric decide la vendita del Pignone Porto Recanati a un
privato osimano. Contestazione delle maestranze e scioperi. -
11
ottobre. A cura dell’Ammistrazione Comunale due alberi sono piantati in
piazzale Europa a ricordo dei gravissimi attentati terroristici
di un mese prima a New York. -
Ottobre.
Si rinnovano le proteste dei residenti in zona S. Maria in Potenza:
l’aria, dicono, continua a essere irrespirabile. Lo
sport
-
Mese di
maggio, fine dei campionati nelle diverse discipline sportive: la Conad
Electa sfiora la promozione nella B2 di pallavolo; la Tennis Tavolo
Quadrifoglio è promossa in C2; buono il campionato dell’Adriatica
Basket, che partecipa agli spareggi per la C1; seconda retrocessione della
squadra di calcio dalla prima categoria. Ordine
pubblico
-
Tra la
metà di maggio e la fine di giugno assistiamo preoccupati a una serie di
incendi dolosi: ristorante Brigantino, un’auto parcheggiata di fronte a
un ristorante di Scossicci, una
roulotte e due cantieri edili nel centro cittadino. Le forze dell’ordine
individuano e arrestano il piromane. -
17
giugno: furto con scasso dalle suore del Prez.mo Sangue. -
31
luglio: svaligiato il supermercato dell’Hotel House. Prelevata merce per
un valore di circa 60 milioni di lire. Pizzicati i ladri dalle forze
dell’ordine. -
27
settembre: tre sconosciuti penetrano di notte nell’albergo Mondial e
picchiano la portiera. Rubano 300 mila lire. -
Ottobre.
I Carabinieri di Ascoli e di Porto Recanati recuperano, in località in
provincia di Ancona, tre delle cinque tele sparite anni fa dalla
pinacoteca Moroni. Sono: ‘Canale con Barche’ di Celso Baldassarri,
‘Presentazione di Gesù al Tempio’ di Francesco Maffei, ‘Mandorlo
fiorito’ di Dante Ricci. Vita
sociale
-
14
maggio: la sezione leopardiana del CSP propone la collocazione di due
lapidi con versi di Giacomo Leopardi relativi al mare di Porto Recanati. -
Giugno:
esce il numero 5 di questa Rivista. -
21
luglio: cerimonia di pemiazione del primo concorso di poesia dialettale
marchigiana ‘Emilio Gardini’. All’Arena Gigli si esibisce la Banda
Dipartimentale della Marina Militare di Taranto. -
Ottobre:
viene diffuso il sesto numero di Potentia. Dialetto
in pillole
Due
analogie con usi linguistici e sociali della nostra tradizione, che
abbiamo riscontrato là dove era davvero difficile aspettarselo. Liete
sorprese, dunque, che testimoniano come tutto il mondo sia sovente paese. Nelle
nostre ricerche sulle strutture scolastiche al Porto abbiamo letto che un
tempo, parliamo della prima metà del XIX secolo, i maestri delle scuole
elementari avevano tra i loro obblighi anche quelli di provvedere alle
pulizie dell’aula dove insegnavano e poi di prestare alcuni servizi al
parroco. Eravamo nello Stato Pontificio; nessuna meraviglia. Stupore
invece lo abbiamo provato scoprendo che lo stesso avveniva nella laica
Francia della Terza Repubblica. Lo racconta Jean Anglade, scrittore nato e
cresciuto nell’Auvergne, regione del Massiccio Centrale, nel suo Les
ventres jaunes – Saint Amand, 1981 – p. 39, un libro nel quale
viene raccontata la vita dura dei celebri couteliers di Thiers,
antagonisti di quelli di Toledo per la raffinatezza della loro produzione
di lame di ogni genere. Scrive Anglade (la traduzione dal francese è
nostra): A quell’epoca (1883, n.d.r.) in molte piccole
parrocchie il maestro delle scuole comunali doveva anche suonare le
campane, spazzare in chiesa, spolverare il mobilio… Un’altra
usanza nostrana è che i giovani chiamano, o meglio chiamavano, zi’
(zio) le persone più anziane, le quali rispondevano dando loro del nepote. Bene,
ecco quanto si legge in un libro dello scrittore inglese Arthur Clarke,
l’autore di Odissea nello spazio: a pagina 96 del romanzo Voci di terra lontana, scritto
nel 1986 e edito in Italia da Rizzoli tre anni dopo, c’è scritto: ‘Davvero
non vuoi cambiare idea, zio?’ chiese Kumar sorridendo. Loren fece di no
con la testa. Le prime volte l’appellativo l’aveva imbarazzato, ma ora
si era abituato al modo che avevano tutti i giovani di Thalassa di
rivolgersi agli adulti…Nel romanzo, Thalassa è un lontanissimo
pianeta colonizzato dai terrestri; nella realtà, chissà da dove Clarke
ha tratto spunto. Canzoni
Bruno
Benedetti continua nella sua preziosa ricerca di vecchie canzoni popolari,
di stornelli e dispetti e di quanto è ancora possibile recuperare dagli
angoli della memoria canora collettiva della nostra comunità. E mentre
lui ne ‘ricostruisce’ la musica imprigionandola in cassette che
saranno disponibili nella sede del CSP, qui pubblichiamo i testi come ci
è possibile, sempre invocando l’aiuto di chi se li ricorda meglio di
noi. Al
Porto si raccontava, in una canzone di tipo narrativo, la storia del
giovane soldato che torna a casa e scopre che la sua fidanzata è morta.
La chiameremo La canzone di Giulia anche se, probabilmente, il
titolo è un altro. E’ un tema presente nella tradizione popolare
nazionale, vedi La sposa morta, che si canta a Volterra, oppure la
veneziana C’era un dì un soldato. Ecco il frammento di cui
disponiamo: Il cielo è una coperta ricamata, la luna con le stelle fa l’amore. Cerco la Giulia, dove dormendo sta, angelo del cuor mio, angelo di bontà. Le undici di notte e l’aria oscura, tutti in silenzio dormono gli augelli. Oh Giulia, Giulia, dove dormendo stai, angelo del cuor mio, angelo di
bontà. La
chitarra, fedele compagna dell’innamorato canterino. La chitarra, però,
anche come metafora che introduce doppi sensi non sempre eleganti. Nei
versi che seguono, se un significato nascosto esistesse, esso potrebbe
essere solo quello, malinconico, del venir meno della giovanil virile
baldanza. Le corde si spezzano una dopo l’altra con il passare del
tempo, finché non ce ne saranno più. Addio, perciò, ai piaceri della
vita; tutto passa. Viene
in mente lo sbalordimento del poeta François Villon, che si chiedeva dove
fossero le nevi dell’anno scorso (mais où sont les neiges d’antan?);
svanite, dissolte, proprio come svanisce e si dissolve il tempo: Sona chitarra, sona, che me s’è rotta ‘na corda; se pure l’altra se scorda ho finito a sonar. Amici cari, bona notte; le corde si son rotte, non si può più sonar. Da
notare, come succede abbastanza spesso, che il dialetto convive con
l’italiano. Riteniamo che ciò sia l’effetto del tentativo di
conferire un tocco di raffinatezza al testo in questione. Appello
Nel
luglio 1901, Vincenzo Pio Rossi, fermano di origine, ma residente nel
Porto, venne accusato di aver cantato una canzone sovversiva istigante
alla violenza di classe e rimandato a giudizio davanti al regio pretore di
Recanati. Il quale, al termine di un clamoroso processo (Rossi fu difeso
dal deputato socialista di Iesi, Lollini), assolse l’imputato
dall’accusa. La canzone incriminata, dove si minacciava di affondare il
pugnale nel petto dei ricchi, era La canzone di Peppino Amato. |
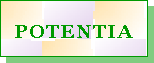 |
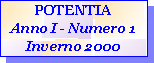 |
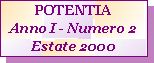 |
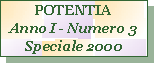 |
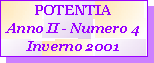 |
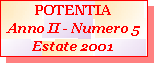 |
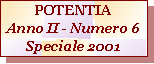 |
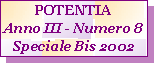 |
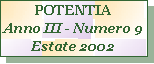 |
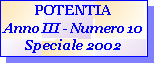 |
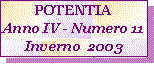 |
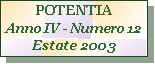 |
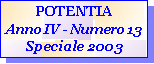 |
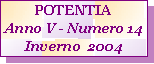 |
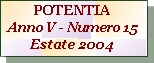 |
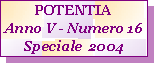 |
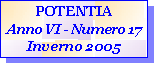 |
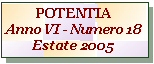 |
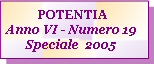 |
|