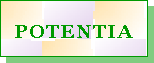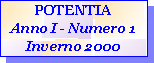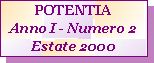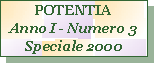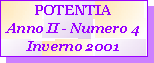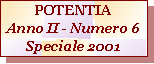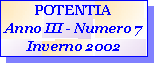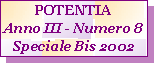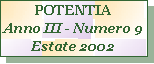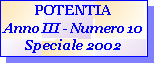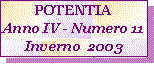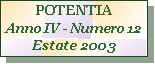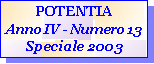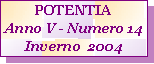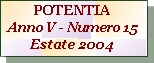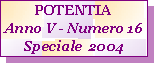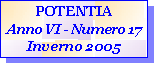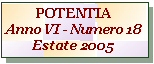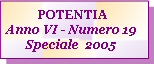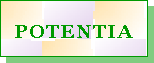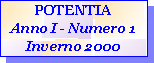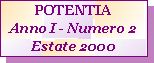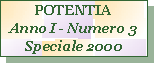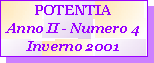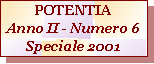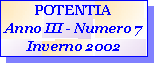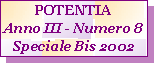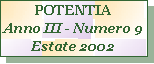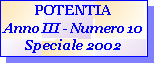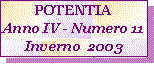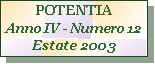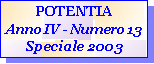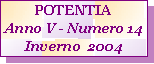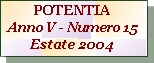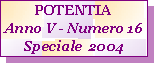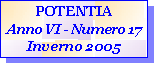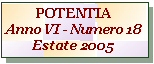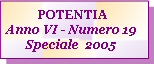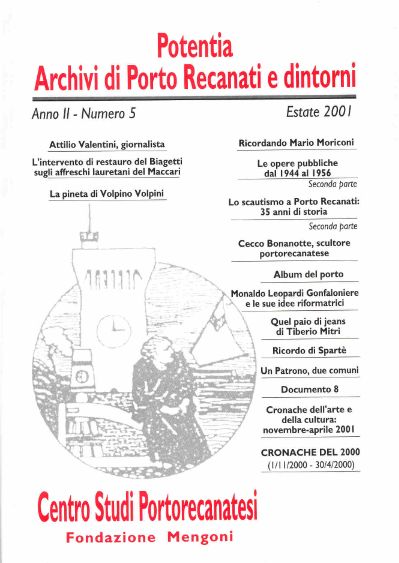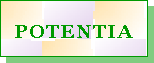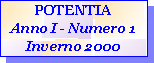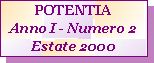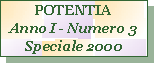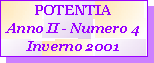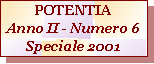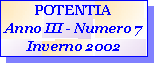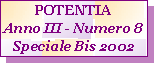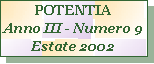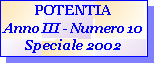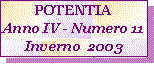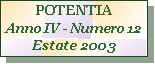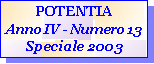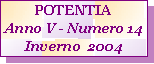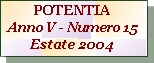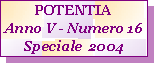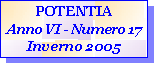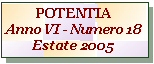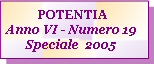| |
|
Presentazione
La Rivista è giunta al suo
quinto numero, riscuote un consenso che ci onora e conforta mentre
comincia davvero a meritare il "dintorni" del titolo.
Nelle pagine che seguono ci sono, infatti, importanti
articoli di amici "forestieri": Franco Foschi, direttore del
Centro Nazionale di Studi Leopardiani; Giuseppe Santarelli, direttore
della Congregazione Universale della Santa Casa; Carlo Pesco, sindaco di
Camerano.
Buona
lettura, quindi, sempre con l’invito a starci vicino e ad arricchirci
con proposte, suggerimenti, critiche (oneste e competenti, ché delle
altre facciamo senz’altro a meno).
Approfitto
di questa pagina per alcune comunicazioni:
il
nostro numero di telefono, con segreteria telefonica, è 071/7590087;
Il
nostro E-MAIL è: c_s_moroni@libero.it
l’orario
di apertura della sede, nel periodo di ora legale, è dalle 18.00 alle
20.00;
chi
di voi volesse iscriversi al CSP o rinnovare la tessera, può servirsi
del modulo di conto corrente allegato (n° 11434628 intestato a Centro
Studi Portorecanatesi) o versare la quota (20.000 lire) direttamente
nella sede di via degli Orti 57 (non vale per chi si è già iscritto
nel corso del 2001);
la
cerimonia di premiazione del primo concorso di poesia dialettale
marchigiana intitolato a Emilio Gardini avrà luogo sabato 21 luglio
nell’Arena Gigli, nel corso del concerto della banda Dipartimentale
della Marina Militare di Taranto.
Porto Recanati, estate 2001.
Il Direttore
 |
| |
|
Attilio
Valentini, giornalista. (di
Lino Palanca)
Quello che segue è solo la traccia di un lavoro sulla
vita di Attilio Valentini, che anni fa il professor Attilio Moroni mi fece
promettere di compiere; lo farò, nella speranza di riuscire finalmente a
reperire i documenti necessari per non lasciare zone d'ombra troppo vaste
in un percorso che di ombre, come sarà facile constatare, è piuttosto
ricco. Il CSP possiede copie di un buon numero di edizioni dei giornali
diretti da Valentini dalle quali sono tratte le citazioni da me riportate.
Attilio Valentini nasce il 5 luglio 1859, qui da noi.
Non so dire con esattezza in quale casa; l’ho chiesto negli uffici
anagrafe dei Comuni di Recanati e del Porto, ma l’informazione non è
ancora disponibile. Presumo, tuttavia, che l’evento sia accaduto in una
delle case che i Valentini possedevano nelle vicinanze dell’incrocio
delle attuali vie Garibaldi e Gardini. Il padre, Valentino (era un
medico), discendente in linea diretta di quel Crispino creatore e
distruttore della fortuna della famiglia più importante del nostro borgo
marinaro nel XIX secolo fino all’arrivo dei piemontesi, aveva sposato
Annunziata Valentini, probabilmente una parente, e dall’unione erano
nati Elvira, Rosa (1858?), Attilio, Emilio (1863) e Cesilde (1864).
In quell’anno 1859, mentre al Nord è in corso la
seconda guerra di indipendenza, è nato anche Giuseppe Ridolfi, che sarà
vescovo di Todi e di Otranto nonché delegato apostolico in Messico; nelle
vie del centro urbano giocano Enrico Volpini, nato nel ’55, futuro
sindaco (1895/1911) e Alberto Cittadini, di due anni più
"vecchio", che sarà il capo dell’opposizione
repubblicano-radical-socialista: fra poco verranno al mondo Enrico (1862)
e Giovanni Lucangeli (1863). Tutta gente di cui abbiamo assai discorso nel
numero 2 di questa rivista. Come che sia un decennio davvero fecondo
quello dal 1853 al ’63.
Attilio dovrebbe aver frequentato le elementari al
Porto (non si dispone dei registri scolastici precedenti gli anni
Settanta) mentre il ginnasio lo ha fatto a Recanati, come ricordava il
fisiologo recanatese Mariano Luigi Patrizi in un suo scritto del 1928, Due
poeti minori della città e del secolo di Leopardi, edito presso la Tipografia
Simboli di Recanati: "Condiscepolo di costoro (cioè di
alcuni illustri recanatesi, come Giovanni Falleroni), forse nella
camerata dei piccoli, era un altro giovinetto, segnalato fin da allora per
le caratteristiche cerebrali, Attilio Valentini, del Porto, arrivato
presto alle file primissime del grande giornalismo, che per fermezza di
pensiero e drammatiche vicende ebbe con Falleroni somiglianza…"
(p.36).
Le tre classi di Liceo Attilio le ha frequentate a
Macerata, al Leopardi, scuola della quale Carducci, che la visitò nel ’76,
disse che ci si studiava bene. Non so se si sia trasferito con la famiglia
nel capoluogo di Provincia; certo vi abitava al momento dell’accesso
alla facoltà di Legge (viveva presso la famiglia, come si legge
nel libretto di iscrizione conservato nell’Archivio di Stato di
Macerata, fondo Università, Busta n°9, in piazza De Vico, civico 2,
credo la moderna piazza Battisti), ma è probabile che il movimento
mare-collina sia avvenuto in corrispondenza dell’inizio dell’avventura
liceale.
Che alunno era Valentini? I voti ottenuti in prima
liceo non sono di uno studente modello; nel quinto bimestre gli avevano
assegnato solo 6½ in italiano, 6 in storia e geografia e addirittura 4 in
matematica; però, aveva avuto 9 in latino, 7 in greco, 8 in filosofia,
chimica e fisica e storia naturale (il voto si calcolava già in decimi).
I professori annotavano nel registro degli scrutini che Attilio era negligente
nelle Matematiche, pigro, indisciplinato.
L’anno successivo gli rimane l’indisciplina, ma i
voti sono ben altri: 8 in italiano, latino, matematica e filosofia; 7 in
greco; 9 in storia e geografia con menzione onorevole; idem in fisica e
chimica come in storia naturale. Il nostro otterrà la maturità liceale
il 16 luglio 1879, più o meno con gli stessi voti dell’anno prima, ma
con un bel 9 in italiano; avrà 9 pure in Disciplina.
Ciò non può giustificare appieno quanto abbiamo
trovato scritto, a firma del preside del Leopardi, nella succitata Busta
9, il quale presenta così, il 2 novembre ’79, il suo ex alunno al
Rettore dell’Università: …Attilio Valentini frequentò questo
Regio Istituto e ivi compì gli studi liceali appalesandosi di sveglissimo
ingegno, e mantenendosi assai sempre studiosissimo e disciplinato, onde il
sottoscritto lo crede ben meritevole d’aiuto e protezione.
Va bene per l’ingegno (ne darà ben ampia prova!), ma
studiosissimo e disciplinato….E poi non si capisce bene il
perché dell’invito ad aiutare e proteggere il Valentini; forse è un
riferimento a condizioni economiche famigliari non floride.
Il giovane portorecanatese dovrebbe essersi laureato
nel dicembre ’83, almeno è quel che si deduce dai Registri n° 66 e
67, Carriera Scolastica, Archivio di Stato Macerata: ha sostenuto gli
esami previsti ottenendo in genere buoni voti, spesso buonissimi, tranne
che in Diritto Romano, superato con soli 18/30, il che contribuisce ad
abbassargli la media, tanto che il risultato finale sarà di 108/120.
Durante gli anni dell’Università, Attilio ha
prestato la sua opera a diversi giornali locali, manifestando così fin da
giovanissimo il suo amore per la professione giornalistica. E’ quanto
scrivono alcuni suoi colleghi commemorandone la memoria, in particolare su
La Provincia di Mantova, nell’ottobre 1912, a venti anni dalla
morte.
Non so davvero dire quali fossero quei giornali; visti
gli orientamenti repubblicani e democratici di Valentini è possibile, ma
solo possibile, che abbia collaborato a fogli come La Vedetta e
L’Educatore, che quegli orientamenti difendevano e propagandavano.
Fatto sta che tra la laurea (dicembre 1883) e il suo arrivo a Mantova,
alla direzione de La Provincia di Mantova (primo maggio 1887),
corrono quattro anni difficili da ricostruire.
Nell’appena citato giornale, sempre in occasione del
ventennale della morte, si legge che fresco di laurea andò a insegnare
latino nel Liceo Classico Paolo Diacono di Cividale del Friuli, ma le
ricerche presso quell’Istituto e presso il Provveditorato agli Studi di
Udine hanno dato esito del tutto negativo. Riacciuffiamolo, allora, mentre
si presenta a Dario Papa, direttore de L’Italia di Milano, con
una lettera di raccomandazione niente meno che di Filippo Turati. Come
aveva conosciuto il futuro leader socialista riformista? Tramite chi?
Papa aveva fatto del quotidiano lombardo, fondato nel
1883, un giornale di tipo anglosassone, che conduceva una campagna in
favore di Francesco Crispi, antico garibaldino, ora assai critico nei
confronti del leader della sinistra liberale Agostino Depretis, capo del
governo dal 1876; in più, il direttore non disdegnava aperture
democratiche e filorepubblicane ( Valerio Castronovo, Stampa e
opinione pubblica nell’Italia liberale, in La stampa italiana
nell’età liberale, Bari, Laterza, 1979, p.103).
Dario Papa non dispone di posti liberi nell’organico
del giornale; tuttavia cede alle insistenze di Valentini e lo manda a La
Spezia, dove c’è il colera, con la città isolata da un cordone
sanitario formato da reparti militari. Il nostro entra in città
spacciandosi per infermiere e da lì invia in redazione pezzi già
degni di un grande inviato speciale, padrone della tecnica moderna del reportage;
tornerà a Milano nascondendosi in un treno merci diretto nella capitale
lombarda.
Subito dopo lo troviamo a Roma, impegnato a inviare a L’Italia
le sue Lettere Romane e titolare delle Chroniques de La
Riforma, foglio della sinistra liberale. Questo giornale, fondato, tra
gli altri, da Crispi, Benedetto Cairoli, Agostino Bertani nel 1867, era
trainato per la via di una graduale adesione alla Monarchia e di un fermo
unitarismo, che poi era la stessa percorsa da Francesco Crispi e che
condurrà l’uomo politico siciliano a diventare il successore di
Depretis.
Non molto diverso, forse con qualche spruzzatina di
radicalismo, si presentava Il Messaggero (fondato nel 1878), al
quale pure Valentini collaborò. La vita da pendolare tra Roma e Milano,
con i famigliari lontani, nelle Marche (al Porto o a Macerata o altrove?)
finì, come ho accennato sopra, con l’assunzione della direzione de La
Provincia di Mantova.
Chi era, politicamente, il ventottenne direttore, che
nell’aprile 1887 sbarcava nella città dei Gonzaga?
Il bisnonno Crispino era stato un servitore fedele,
oltre che di se stesso, del governo del Papa, così come suo nonno Simone.
Il prozio Biagio, addirittura, aveva seguito san Gaspare Del Bufalo nelle
missioni in tutto il territorio del Regno Pontificio diventandone il
successore alla direzione della Congregazione del Prez.mo Sangue.
Valentino, suo padre, era stato anche lui commissario del governo
pontificio.
Attilio, invece, nato e certamente cresciuto nella fede
degli avi, era uscito dal seminato, probabilmente in età liceale o, al
massimo, universitaria. E la famiglia si ritrovò in casa un
anticlericale, impulsivo e senza misura nella polemica contro la politica
della Chiesa, giudicata reazionaria; un repubblicano amico di Arcangelo
Ghisleri, del radicale Cavallotti e del padre del socialismo riformista
italiano, Filippo Turati. Il Vessillo delle Marche, giornale
maceratese di orientamento moderato, lo definì addirittura, nell’ottobre
’92, a pochi giorni dopo la morte, un socialista convinto (la tradizione
famigliare di fedeltà all’ordine costituito fu salvata dal fratello
Emilio, che scelse la carriera militare fino a raggiungere il grado di
generale di brigata nell’Esercito).
Credo si possa pensare a Valentini come a un
democratico convinto della necessità di grandi riforme sociali (in ciò
assai vicino al pensiero turattiano), ma lontano da tentazioni anarchiche
o rivoluzionarie; vale a dire, le stesse caratteristiche de La
Provincia di Mantova di cui egli fu il rifondatore. Creata da Alberto
Mario, una delle penne più prestigiose del giornalismo italiano dell’epoca,
la testata ebbe un primo breve periodo di vita dal 1872 al 1874 e nel 1887
arrivò Attilio Valentini a resuscitarla.
Mantova era territorio socialmente procelloso: nel 1885
vi si era svolta l’agitazione contadina nota come la boje, dal
grido degli scioperanti: la boje, la boje e de boto la va de fora (bolle,
bolle e tutto a un tratto scoppia) e nel dicembre di quello stesso anno
aveva ospitato il congresso di fondazione del Partito Operaio Italiano
(POI).
La leadership politica di Depretis, come del resto la
sua vita, sono agli sgoccioli mentre la questione sociale esce dai salotti
e dai casolari per deflagrare nelle campagne come nelle piazze e persino
nella letteratura.
Francesco Crispi sta per inaugurare la sua prima
stagione a capo del governo (1887/’91): avrà l’appoggio, più o meno,
dei liberali di destra e di sinistra; gli si opporranno radicali,
repubblicani e la nebulosa anti-sistema comprendente anarchici, operaisti,
internazionalisti, protosocialisti.
Il primo maggio 1887, dunque, Valentini firma l’editoriale
del giornale che dirige dagli uffici di via Orefici, civico 13: nell’editoriale
di saluto scrive che il giornale sarà profondamente democratico, aperto
al nuovo, aderente alla realtà; non starà con coloro che vogliono tutto
e subito, ma accetterà meglio l’uovo oggi che la gallina domani,
sosterrà il metodo sperimentale, difenderà la massima libertà in
politica, il massimo decentramento, sarà nemico della reazione. E poi: …La
Provincia non dimenticherà mai che gli interessi locali devono premerle
sopra ogni altra cosa. Essa se ne occuperà con alacrità e abnegazione.
La sua ambizione sarebbe di poter conciliare quanti non rifuggono dal
progresso, quanti vogliono andare avanti senza la podagra della reazione e
senza le convulsioni delle utopie…
Carattere generoso, tenero addirittura secondo i suoi
amici, Valentini era comunque incapace di governare la sua impulsività
nella polemica con gli avversari, tanto che si trovò a sostenere più di
un duello prima di quello fatale in Argentina.
A Mantova, per esempio, se la vide con Giovanni
Mastuzzo, ventunenne campano di Vico Equense, ufficiale del 69° fanteria,
il quale aveva giudicato offensive alcune frasi rivoltegli da Valentini.
Il duello ebbe luogo, alla spada, il 24 gennaio 1888 e i due protagonisti
si procurarono reciprocamente lievi ferite. Il regio pretore mantovano,
però, non intese ragioni e giudicò Attilio e il suo avversario colpevoli
di aver infranto la legge che vietava il duello condannandoli al pagamento
di 50 lire a testa (Archivio di Stato di Mantova, sentenze penali 1887-’88,
busta 64).
A fine maggio ’88, Valentini si trasferisce a
Cremona. Egli risulta iscritto all'anagrafe del Comune (Impianto 1865,
foglio 1070, come ci ha comunicato l’Archivio di Stato della città
lombarda) il 26 maggio 1888 proveniente da Mantova insieme alla madre
Annunziata e al fratello Emilio; il 2 giugno arriverà da Macerata anche
la sorella Cesilde.
Cremona non è più tranquilla di Mantova. Anche qui
non manca di forza il movimento contadino, protagonista di agitazioni
importanti; alle elezioni politiche del 1886 il Partito Operaio ha
registrato un successo ottenendo 3.359 voti. Ed è qui che Valentini viene
a far nascere Il Democratico, che dirigerà per qualche mese, prima
di trasferirsi di nuovo, questa volta a Genova.
Il giornale debutta il 2 giugno; nell’editoriale di
indirizzo il direttore ribadisce la sua posizione progressista, ma non
rivoluzionaria, si dice fautore della scienza positiva, della cooperazione
nel lavoro, del diritto allo sciopero, all’emigrazione, all’impiego e
sottolinea la necessità di riforme burocratiche. Questa volta, Valentini
evidenzia anche il suo anticlericalismo manifestando l’avversità alla
conciliazione con il Vaticano (parla addirittura di …mala pianta del
cattolicismo…), attacca di nuovo quelli del partito del tutto e
subito, predica il suffragio universale, accusa l’Italia ufficiale
di aver rinunciato agli ideali del Risorgimento, attacca il trasformismo
politico, sopravvissuto a Depretis, mette in guardia contro la china
spaventosa dei debiti, delle imprese folli (Africa) e delle alleanze
nefaste (Triplice Alleanza). Per lui, il sistema di governo è senza
principi, reso possibile solo da una coalizione di interessi
privati, mentre il Parlamento è tisico. Niente male.
Il direttore de Il Democratico si occuperà
della polemica tra il POI e i radicali di Cavallotti, invitando tutti alla
moderazione e alla solidarietà; avrà parole di fuoco nei confronti di
Ruggero Bonghi, padre della legge sulle guarentigie per il Vaticano, e del
vescovo Bonomelli, tessitori della trama conciliatorista; si dichiara
evoluzionista anche in rapporto al problema istituzionale
(monarchia/repubblica); definisce il giornalismo una scuola, una missione
e, soprattutto, un tribunale in cui regnano il coraggio e la sincerità;
scatena una campagna contro i professori clericali, usciti ..da quella
grande fabbrica di sfruttatori dell’insegnamento pubblico che è la
sagrestia.. (anima del prozio Biagio!!).
Nel settembre ’88 gli avversari del giornale moderato
di Cremona, Il Minuscolo, lo querelano; non è improbabile che
abbia trasceso in qualche scontro verbale o scritto. E non è nemmeno
improbabile che abbia fatto seguito un duello, sul quale, però, al
momento non sono documentato.
Secondo quanto risulta all’Archivio di Stato di
Cremona, Valentini lascia la città il 21 aprile 1889, senza famigliari,
diretto a Genova. C’è un problemino circa la data della partenza di
Valentini. Roberto Beccaria, responsabile della sezione periodici della
biblioteca Berio di Genova, scrive che Valentini (I periodici genovesi
dal 1473 al 1899 – Genova 1994 – p.203) ha diretto il genovese L’Epoca
dal n. 32 del 1 febbraio 1889 al n. 164 del 13/14 giugno successivo. Ed è
senz’altro così: le copie del giornale in nostro possesso lo attestano.
Può anche essere che la data del 21 aprile si riferisca solo all’atto
ufficiale di cambio di residenza mentre Valentini era già a Genova da
quasi tre mesi.
Come che sia, nel capoluogo ligure il nostro si trova
alla testa di un giornale di tradizioni democratiche, che raggiunge anche
gli emigrati nelle Americhe, lotta contro il militarismo e la triplice
alleanza, è assertore della lotta passo per passo, critica la politica
crispina, il Parlamento pecorone e lo scrutinio uninominale. Insomma,
anche a L’Epoca (fondato da L. Lavagnino e Enrico Arisi nel 1877,
30 mila copie di tiratura) Valentini conferma le convinzioni già espresse
e propugnate nelle precedenti esperienze di direzione.
Breve, l’esperienza di Genova. Dopo quattro mesi e
mezzo, a metà giugno, Valentini saluta i lettori. È in partenza per l’Argentina
dove è stato chiamato a dirigere un importante giornale per gli emigrati,
La Patria degli italiani, fondato nel ’76 (fino al 1883 si
chiamò solo La Patria) da Basilio Cittadini, che lo ha diretto per
tredici anni e che adesso vuole tornare per un po’ in Italia.
Attilio si imbarca sul piroscafo Regina Margherita, a
Genova, salutato da amici e colleghi. Di là dell’Atlantico, la grande
Repubblica sudamericana vive uno dei rari periodi di tranquilla
prosperità della sua storia. Dopo la sanguinaria dittatura del generale
Rosas, il Paese è stato governato da presidenti che hanno pensato, pur
tra mille difficoltà e contraddizioni, più a costruire che a sparare:
Urquiza, Derqui, Mitre (1862/’68, amico di Garibaldi), Sarmiento (1868/’74),
Avellaneda (1874/’80), Roca (1880/’86). Nel 1889 il presidente è
Juàrez Celman, che dovrà però dimettersi nel ’90 a causa di una grave
crisi economica, seguita da una rivoluzione, domata, contro gli uomini di
governo.
Gli emigrati italiani cominciano ad essere piuttosto
numerosi; stanno anzi avviandosi a costituire la colonia straniera
quantitativamente più consistente in Argentina. Nel 1884 sono già 280
mila; gestiscono una florida banca, una cassa per il rimpatrio e un
ospedale in Buenos Aires, hanno costituito una sessantina di società di
mutuo soccorso e istruzione, associazioni filarmoniche e filodrammatiche.
Gli agricoltori sono circa 35 mila, nelle colonie agricole di Santa Fé e
10 mila, in quella di Entre Rios.
Nella capitale federale hanno impiantato molte piccole
industrie; il 68% delle somme introitate dal fisco nella metropoli
proviene dagli italiani, il cui capitale immobiliare ammonta a 60 milioni
di scudi mentre assommano a una decina di milioni di lire i depositi nelle
banche.
I giornali in lingua italiana sono La Patria degli
italiani, diretta da Basilio Cittadini, L’operaio italiano da
Annibale Blosi, Il Maldicente da Carlo Allara e L’amico del
popolo da Gaetano Pezzi.
L’opinione pubblica argentina alternava momenti di
sostegno e solidarietà nei confronti degli emigrati ad altri in cui
emergevano sentimenti xenofobi. A ciò si aggiungevano episodi di tensione
tra emigrati di diversa nazionalità (parecchi tra italiani e francesi),
tensione che rispecchiava quella esistente tra i rispettivi governi
nazionali in Europa. Non fa perciò meraviglia che i nostri fossero
protagonisti dei non pochi fatti di cronaca conseguenti, che spesso
consistevano in duelli; capitò a Cittadini e Blosi tra gli altri e,
purtroppo, anche a Valentini.
In attesa di disporre delle copie dei pezzi di
Valentini ne La Patria degli Italiani, che ho richiesto alla
Biblioteca Nacional di Buenos Aires, mi devo accontentare di segnalare la
presenza del nostro concittadino in alcuni momenti importanti della vita
della colonia italiana nella capitale argentina. Lo posso fare grazie a
quanto riportato nel volume di Giuseppe Parisi, Storia degli Italiani
nell’Argentina – ed. Voghera – Roma 1907.
Qui leggo che al primo congresso delle società
italiane, tenutosi in Baires nel settembre 1891, al quale aderirono 130
società con 667 delegati, Valentini intervenne su alcune questioni
procedurali (p.471) e sulla questione dell’istruzione: …Il
dottor Valentini dice che l’istruzione delle Società di Mutuo Soccorso
dev’essere eminentemente popolare, ché l’introduzione di scuole
superiori o di licei potrebbe anche generare sospetti verso l’autorità
Argentina che già in altre circostanze si mostrò gelosa delle nostre
scuole, oltreché dal lato pratico il titolo che lo studente potesse
ottenere in questo liceo non sarebbe poi valido per questo paese e neppur
per l’Italia; propugnerebbe quindi maggior moderazione in questi
desideri per stare nei limiti del possibile e dell’efficace.
Non conobbe moderazione, Valentini, quando si trattò
di difendere l’onore nazionale a suo avviso offeso da un certo sig.
Herminio Torre, un argentino. Sulle cause di quel tragico duello, sappiamo
solo, per il momento, quanto scrisse vent’anni dopo, in una
commemorazione su La Provincia di Mantova un collega di cui sono
riportate le sole iniziali O.Z.: Morì il 5 ottobre 1892 in
duello per una sciocchezza: per una parola sottolineata in un verbale di
chiusura nel quale egli era stato secondo. Le condizioni di quello scontro
erano terribili: pistola a sette metri di distanza. E questo, ripetiamo,
per una parola sottolineata! (probabilmente riferita all’Italia).
Fu colpito da una palla, quattro dita al di sopra della mammella sinistra.
La cronaca racconta che dopo un istante da che fu colpito, si toccò il
cuore esclamando: Toccato! Poi sorridendo e battendo le mani aggiunse:
Bravo, Bravo! e cadde fulminato.
Il quotidiano La Prensa rivelò, il giorno dopo,
che il duello si era svolto en la Colonia (R.O.), credo una
località di Baires, alla presenza di due padrini per parte: i soccorsi
prestati da alcuni medici a Valentini furono inutili poiché il proiettile
aveva reciso di netto l’aorta procurando la morte istantanea.
Il giorno 7 ci furono i funerali. Grandiosi. Le
cronache parlano di migliaia di persone che vi parteciparono (pare fino a
20/30 mila), compresi i tanti colleghi della stampa italiana e no di
Buenos Aires, l’ambasciatore e il console italiani, gli amici, la Banda
(musicale?) sannitica, i Reduci delle patrie battaglie, rappresentanti
della massoneria e di varie associazioni. Tra i parenti figurò un Biagio
Valentini di cui non so nulla se non che rinnovava nel nome il celebre
prozio prete di Attilio.
Nel luglio del ’93, il signor Felice Oddone (?) vide
soddisfatta dal Prefetto di Macerata la sua richiesta di rimpatrio della
salma di Valentini, che giunse a Genova, a bordo della nave Andrea Doria,
il 27 o 28 di quel mese e a Porto Recanati col treno di mezzanotte del 28
(se non abbiamo letto male le date nei documenti relativi); fu accolta dal
presidente del comitato per le onoranze funebri Alberto Cittadini. Il
giorno dopo ebbero luogo i solenni funerali, con l’intervento del paese
intero, delle autorità, delle associazioni democratiche del Porto e delle
località vicine, della banda musicale locale e di quelle di Loreto e
Montegranaro. Il tutto sotto lo sguardo attento del delegato di polizia di
Recanati e dei regi carabinieri.
Valentini è sepolto in una tomba sul lato sinistro,
per chi entra, del viale centrale del civico cimitero (parte vecchia). La
tomba è abbandonata a se stessa, il che non ci fa davvero onore.
Di lui si sono ricordati, almeno fino al ventennale
dalla morte, La Provincia di Mantova, Olindo Pantanetti ne L’Esposizione
Marchigiana del 1905, il Comune di Porto Recanati che gli ha dedicato
una lapide sulla facciata del castello svevo, scoperta nel 1912 con
discorso di Mariano Luigi Patrizi, alcuni autori di volumi sull’emigrazione
italiana in Argentina; e poi, Attilio Moroni con una sua conferenza al
Porto nel 1986 e il C.S.P. in ripetute occasioni e pubblicazioni.
La lapide, dettata da Patrizi, recita così: Attilio
Valentini di Portorecanati/ onore della stampa e della fede repubblicana/
ebbe la sdegnosa anima forte quanto l’ingegno/ cadde in tragico duello a
Buenos Aires/ con lo stoicismo dei combattenti per l’ideale.
C’è anche una testimonianza diretta della vita
condotta in Argentina, pubblicata su L’Epoca nei giorni
immediatamente successivi al duello. Rivolgendosi a un amico di Roma,
Valentini scriveva, in data non precisata, da Buenos Aires: Avrei una
voglia matta di venire al più presto a passare due o tre mesi in Italia.
Finora l’unica America che io ho fatto è stata la cambiale per conto
altrui. Parecchie e pregate garanzie per conto altrui mi hanno messo in
bolletta. Pazienza; torneremo a lavorare e ad ogni modo…vivremo. Io non
voglio chiedere niente alle Società di navigazione, tu però potresti
farmi avere un biglietto di andata e ritorno per e dall’Italia. Con
questo in saccoccia, assai probabilmente fra cinque o sei mesi, verrei in
Italia a farmi passare un po’ di quella nostalgia e ipocondria che tanto
mi fanno pentire di essere nato…
È tornato, pagando un terribile prezzo.
 |
| |
|
L’intervento
di restauro del Biagetti sugli affreschi lauretani del Maccari
di
Giuseppe Santarelli
E' noto che Biagio Biagetti, artista dalle molteplici
espressioni, si occupò in maniera consapevole anche di restauro tanto sul
piano teorico quanto su quello pratico. Qui si vuol prendere in esame la
sua opera di restauratore degli affreschi della cupola della basilica di
Loreto, eseguiti da Cesare Maccari.
Gli antefatti
La cupola lauretana fu elevata fino al tamburo da
Giuliano da Maiano e voltata nella calotta da Giuliano da Sangallo dal
settembre 1499 al maggio 1500. Tra il 1610 e il 1616 fu affrescata da
Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio, con una "gloria
celeste" calata nell'ampio invaso. Deperiti quegli affreschi e
staccate alcune loro porzioni ad opera di Ottavio Ottaviani nel 1888-1890,
la cupola fu nuovamente decorata da Cesare Maccari di Siena. Questi, dal
1890 al 1895, affrescò la calotta con emblemi e figurazioni simboliche
delle Litanie Lauretane, e dal 1895 al 1907 dipinse le pareti del
tamburo con grandiose scene della Storia del dogma dell'Immacolata,
decorando anche i contigui sottarchi e arcate con episodi devozionali e
con immagini di santi e di pontefici.
La cupola nel secolo XX ha subito due incendi: uno nel
1926 per corto circuito, durante il quale si adoperò per lo spegnimento
del fuoco il celebre aeronauta Umberto Nobile, e l'altro, assai più
grave, nel 1944, in periodo bellico, per un pesante bombardamento.
Il bombardamento
del 1944
Il santuario di Loreto, in applicazione dell'articolo
29 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede (1929), era tornato a
essere proprietà pontificia. Di conseguenza, durante il secondo conflitto
mondiale, come Roma, anche Loreto fu considerata città aperta,
vietata a ogni stazionamento di truppe combattenti. Il maresciallo
Kesselring aveva fatto affiggere manifesti in questo senso, nei quali
spiccava un marcato Achtung!. Ogni quindici giorni il comandante
tedesco della piazza di Ancona, residente a Osimo, si portava al santuario
per informarsi dal rispettivo rettore se gli ordini venivano osservati.
Dopo lo spostamento delle truppe tedesche verso Ancona,
Loreto fu occupata dalle truppe alleate il 1° luglio 1944. Per tre giorni
si sviluppò una lotta accanita nelle adiacenze di Loreto, fino a che, il
4 luglio non fu espugnato Castelfidardo da parte degli alleati. Il peggio
per Loreto sarebbe arrivato nella notte tra il 5 e il 6 luglio successivo
con un gravissimo bombardamento.
Le cause del funesto avvenimento non sono chiare.
Secondo testimoni oculari ancora viventi, si andava dicendo che le truppe
alleate usavano la città di Loreto come base di operazioni belliche,
mettendo un posto di osservazione perfino nel campanile, smantellato poi
per le vive rimostranze di Mons. Gaetano Malchiodi, amministratore
pontificio del santuario. Il comando tedesco era al corrente di tutto
questo perché alcune radio clandestine lo tenevano continuamente
informato. Probabilmente, quindi, si trattò di una rappresaglia da parte
dei tedeschi che avevano rispettato Loreto quale città aperta,
mentre le truppe alleate giudicarono di non doversi impegnare a tanto.
Le prime avvisaglie di un attacco aereo si ebbero alle
ore 21,30 del 5 luglio quando alcuni aerei tedeschi, rombanti lungo la
costa adriatica, sganciarono spezzoni incendiari presso la stazione
ferroviaria e lungo la Scala Santa. Il bombardamento iniziò alle ore 23 e
centrò la cupola della basilica che andò in fiamme. Il fuoco trovò esca
nel legname al di sotto delle lastre di piombo che colavano liquefatte. Un
vento di poppa favorì l'espandersi dell'incendio che sfiorò persino la
statua bronzea della cupola.
Cominciarono i primi tentativi per spegnere le fiamme,
ma l'impianto antincendio di cui disponeva la cupola risultò
inutilizzabile per mancanza di acqua corrente e l'improvvisata
attrezzatura delle pompe e dei motori risultò inadeguata al caso.
Alle ore 3,45 del 6 luglio ci fu una seconda incursione
aerea. Una bomba squarciò il tamburo della cupola dalla parte ovest per
un' estensione di 15 mq di superficie. Così descrive la scena un
testimone oculare:
"Nella basilica un polverone enorme; detriti
ovunque, le oscure sagome dei confessionali trasformate in bianchi
fantasmi. In alto sulla cupola occhieggiava sinistramente una grande
buca. Tuttavia la Santa Casa era in piedi. Ci recammo là per la
porta, l'unica porta aperta, vicino al santo camino. Da fondo ci viene
incontro p. Remigio da Cavedine, il custode della Santa Casa, che
aveva passato la notte lì dentro, in cotta e stola, pregando alla
luce delle candele accese davanti alla Madonna. Bianco ed emozionato,
disse semplicemente: - La Santa Casa è salva, ringraziamo la Madonna
-".
Spegnimento della
cupola e bilancio dei danni
L'opera di spegnimento delle fiamme che divoravano la
cupola riprese dopo lo sgancio della micidiale bomba, ma risultò
laboriosissimo. Vi si impegnarono arditamente i soldati polacchi, corsi a
Loreto da Macerata con pompe antincendio. L'acqua però poteva essere
attinta solo dalle cisterne poste sotto la pavimentazione della Piazza
della Madonna, perché l'acquedotto era stato fatto saltare dai tedeschi
qualche settimana prima. Alcuni soldati stavano in Piazza addetti alle
pompe, altri stendevano la tubatura verso la facciata, altri erano saliti
sul tetto della basilica con l'intento di spruzzare l'acqua dove divampava
l'incendio. I tubi però erano di tela e non reggevano alla pressione. Una
soluzione efficace fu quella di salire sulla cupola con le scale e di
tagliare il piombo per isolare le fiamme.
All'opera di questi generosi soldati, che è stata
immortalata da Arturo Gatti nella vetrata della cappella polacca, si
aggiunse l'efficace soccorso portato dai muratori della basilica di
Loreto. Uno di loro, Genuino Maccaroni, nel 1984 rilasciò questa
dichiarazione:
" Verso le 5 [del 6 luglio] andai al santuario
[...] Salii sopra il tetto della basilica per tentare di raggiungere
la cupola attraverso l'apposita scaletta, ma le fiamme ardevano da
tutte e due le parti della stessa. Allora, con una scala di legno
tentai di salire fino al cornicione della cupola. Ebbi un attimo di
esitazione, ma poi mi feci coraggio e andai avanti. Constatata la
situazione, scesi, presi i tubi dei pompieri e risalii. Con me
salirono altri, come Gigino Marta e Vincenzo Rocchetti, il quale per
tutta la notte aveva vigilato intorno alla basilica, durante i
bombardamenti. Con i tubi cominciammo a smorzare le fiamme ancora alte
e dure a spegnersi, perché erano penetrate tra i legni.
Successivamente, con lattine di benzina riempite d'acqua dell'orto dei
frati, avemmo più successo. Leonello Montanari portava le lattine a
me che poi le trasportavo dal tetto della basilica fino alla cupola. E
così, a poco a poco, riuscimmo a domare le fiamme".
Il muratore loretano fa rilevare con malcelato
compiacimento l'efficacia della opera sua e dei compagni quando osserva:
" I polacchi dal cornicione interno della cupola con sifoni
inefficienti poterono ben poco contro l'incendio".
I danni provocati dal bombardamento furono assai gravi.
Lo squarcio di 15 mq aperto nella cupola dalla bomba provocò uno
spostamento di detriti, che precipitarono in gran parte intorno all'altare
del coro o cappella tedesca. Il rivestimento marmoreo non subì danni di
rilievo, salvo la perdita di minuscole sezioni in qualche statua, come
l'alluce del Profeta Balaam. Si disse che fu una fortuna il fatto
che la bomba avesse colpito la parte più robusta del tamburo e che fosse
scoppiata lassù, limitando i danni. Comunque sia, la decorazione della
cupola fu seriamente compromessa. Scrive un testimone dell'epoca:
"Pareti, intagli, sculture, pitture, tutto ha
preso il tono uniforme di polvere lattea. Le macerie violentemente
proiettate nella parete opposta hanno completato la rovina del
mirabile ciclo pittorico del senese Cesare Maccari. Accanto alla Santa
Casa cumuli di rovine: lampadari, vetri istoriati, rottami di ogni
genere".
Anche le vetrate della cupola subirono danni
irreparabili. Cinque di esse andarono definitivamente perdute.
Osservò il Biagetti che i danni all'esterno della
cupola furono causati principalmente dai numerosi spezzoni incendiari,
mentre quelli all'interno si dovettero a un'unica bomba che, abbattutasi
con grande violenza su una parete esterna del tamburo, verso ovest, vi
procurò un grande squarcio ellissoidale di circa 20 metri quadrati.
La fasi preliminari
del ripristino della cupola
Già dal luglio del 1944 decine di operai e di tecnici
specializzati diedero inizio a un primo restauro della cupola,
"risanando le ferite che in un primo tempo non sembravano di così
complessa portata". Si trattò di lavori in muratura, richiesti
dall'urgenza del caso per rendere stabile la cupola.
Nel maggio del 1945 si pose mano a un restauro
sistematico della stessa, sotto la direzione dell'ingegnere
dell'Amministrazione Pontificia Amerigo Staffolani. In un primo momento fu
procurato un notevole quantitativo di legname per l'impalcatura, che fu
subito avviata. Mons. Gaetano Malchiodi, però, paventando un altro
incendio per il materiale infiammabile, preferì sostituire i pali di
legno con tubi metallici. La messa in opera della seconda e definitiva
impalcatura durò più di un mese. Vi fu allestita una scala a ripiani,
schermata con cannicciata, che dalla parte superiore della Santa Casa
raggiungeva il lanternino. Furono acquistate anche diverse tonnellate di
piombo grezzo per la copertura esterna della cupola a lastre, lavoro
preliminare indispensabile. Fu necessario rinnovare e ricoprire di lastre
di piombo tre spicchi della cupola. Vennero eseguite riparazioni anche nei
tetti, con la sostituzione di non poche capriate e di un ingente quantità
di tegole, in quel momento quasi irreperibili, come annota il Biagetti.
Il restauro
pittorico e decorativo ad opera del Biagetti
Biagio Biagetti fu incaricato a dirigere le operazioni
del restauro pittorico e decorativo della cupola. Nel primo semestre del
1946 egli promosse ed eseguì studi ed esperimenti preparatori prima di
dare inizio al restauro vero e proprio. Il Biagetti anzitutto rilevò che,
attraverso lo squarcio sul lato ovest del tamburo della cupola, una
congerie enorme di frantumi laterizi, di calcinacci e di polvere fu
violentemente scaraventata sulle pareti interne opposte, "rendendo
irriconoscibili le pitture sotto un densissimo strato di polvere, e
piagando in numerosi punti la malta su cui è dipinto l'affresco, composta
di calce e sabbia e avendo uno spessore di centimetri quattro; dei quali
uno d'intonaco e tre di arricciato". E annota ancora: "Nella
parete squarciata dalla bomba, oltre a danni consimili della malta, si
debbono lamentare gravi danni agli stucchi e la completa distruzione di
circa quaranta metri di affresco".
Il Biagetti, negli assaggi preliminari al restauro,
verificò anche un fenomeno preoccupante. I danni provocati dal
bombardamento erano stati favoriti da "un difetto originario della
malta". Ecco le sue parole testuali che si leggono in una sua
relazione pubblicata nel settembre-ottobre 1946 negli Annali della S.
Casa:
"[La malta] al momento della preparazione
dell'affresco è stata applicata sulla costruzione laterizia quasi
liscia e ricoperta di idrofugo grasso, che ha impedito alla malta di
far salda presa sul muro. Si aggiunga che la malta è riuscita
friabilissima e si polverizza al semplice stropicciarla con un dito.
Tutto ciò fa temere, purtroppo, che i danni subìti dagli affreschi
non siano da imputarsi esclusivamente alle bombe tedesche, e fa
balenare la necessità di una revisione totale dell'opera maccariana,
per constatare se - il che non è improbabile - la difettosa
preparazione iniziale abbia influito, anche prima del bombardamento,
sulla debole adesione della malta nel muro. In tale deprecabile caso,
si dovrà procedere al graduale risarcimento di tutti gli affreschi
con l'identico sistema che si sta attuando con indubbia efficacia
nelle tre pareti del tamburo, verso oriente, dove sono rappresentati:
la V sezione del Concilio di Trento; la definizione del dogma
dell'Immacolata; la cacciata dei protoparenti dall'Eden e la
presentazione di Maria al Tempio".
Purtroppo, il timore del Biagetti era fondato, perché
l'11 agosto 1946, mentre si stava lavorando al ripristino della
decorazione, cadde dall'intradosso della cupola una porzione d'intonaco di
circa 1 metro quadro. Annota il cronista del santuario:
"Ciò che sembrava solo un'induzione del
professore direttore dei lavori divenne una dura e costernata
certezza: l'intera superficie pittorica, dal tamburo alla volta,
presentava gli stessi difetti tecnici constatati nella parte
principale. Una generale revisione e un successivo consolidamento
degli affreschi si imponevano con caratteri d'urgenza".
Il sistema adottato dal Biagetti consisteva in una
serie di operazioni, che egli lucidamente illustrò nella citata
relazione.
1 - Anzitutto procedette all'asportazione del denso
strato di polvere che ricopriva gli affreschi, con il ravvivamento della
superficie del colore, irrorandovi con il polverizzatore un'appropriata
miscela liquida.
2 - Con un sistema appositamente studiato per questi
affreschi maccariani, il restauratore, prima di sostituire le parti
mancanti, applicò numerose grappe metalliche a vite per assicurare il
blocco della malta a muro. Usò viti in ottone con borchia allargata.
3 - Praticò, quindi, numerosissime iniezioni a base di
caseina sulla malta, applicando subito sulle singole zone uno speciale
congegno atto a comprimere e ad assicurare l'adesione della malta sul muro
e capace di impedire che la materia iniettata formasse pericolose borse o
aggravasse i distacchi. Questo lavoro, condotto con estrema precauzione
per non allargare le piccole brecce operate in numero impensato dalla
proiezione dei vari rottami, fu portato a termine nell'ottobre 1946.
Il Biagetti osserva a riguardo di questo procedimento:
"Questo sistema di consolidamento - salvo
talune varianti consigliate dalla natura particolare della malta degli
affreschi del Maccari - è in uso da molti anni nel Laboratorio
vaticano per il restauro delle pitture murali, al quale, come è noto,
sono affidati, tra l'altro, i celeberrimi cicli affrescati che
ammiransi nel Palazzo vaticano".
Dopo il consolidamento della malta, il Biagetti
intervenne sul restauro vero e proprio secondo questo criterio:
"integrando scrupolosamente le piccole mancanze, e limitando a
semplici tinteggiature le più vaste zone, nelle quali la completa
ricostruzione pittorica potrebbe risultare arbitraria e inesatta". Fu
guidato, quindi, da un saggio criterio conservativo.
Nessuna pubblicazione accenna alla difficoltà
incontrata dalle autorità del santuario per ottenere dai parenti del
Maccari i cartoni necessari al rifacimento della scena del Capitolo
francescano a Pisa del 1263 e di quella contigua con la Curia
romana che celebra la festa dell'Immacolata nel secolo XII. La
tradizione orale però, confermata da testimoni oculari ancora viventi,
attesta che i parenti del pittore senese pretendevano diritti d'autore
esorbitanti per l'uso di quei cartoni, per cui fu necessario rinunciarvi.
Un cronista del santuario, nel maggio del 1947,
annotava che in questa sezione della cupola i restauri si limitarono
"a delineare rapporti cromatici tonalmente intesi per mantenere
l'equilibrio con le parti esistenti. Le pristine figure [...] si
presentano ora sfumate e non prive d'interesse per gli attuali gusti di
modernità". Non è difficile scorgere in questo linguaggio i
suggerimenti del Biagetti all'anonimo cronista, il quale, con empito
letterario, così conclude:
"Le scene tornate a comparire tra le
smaglianti rappresentazioni sorelle in veste di povere cenerentole,
velate di mestizia e di pianto e ammantate di lutto, diranno più
eloquentemente ai posteri la jattura subìta, e nel linguaggio dei
muri - meglio che delle parole - alzeranno la loro voce di protesta e
d'ignominia sulla [in]civiltà e sulla insensibilità del nostro
tempo".
Dopo il restauro degli affreschi il Biagetti diede mano
al ripristino degli stucchi dorati, per i quali egli non previde grandi
difficoltà, perché si trattava di una riparazione quasi materiale di
sbocconcellature e di contusioni prodotte dai frammenti laterizi,
scagliati violentemente dalla bomba, senza che fosse stata compromessa
peraltro la saldezza dei rilievi e l'integrità delle parti essenziali.
Delle cinque vetrate andate perdute, quattro furono
sostituite dal Biagetti con altrettante vetrate adornate da semplici
motivi geometrici e illeggiadrite da una bordura esornativa a colori, e
una fu decorata con la figura dello Spirito Santo, disegnata dallo stesso
Biagetti - che si ispirò all'analoga immagine di una vetrata della
basilica di S. Pietro - e dipinta a fuoco da Mario Di Nunzio, il quale,
insieme ad altri esperti restauratori, fu a fianco del maestro
portorecanatese durante le operazioni di ripristino della cupola.
Tanto le autorità del santuario, quanto il
restauratore si imposero di portare a termine i lavori di restauro per la
fine di aprile 1947, in vista dell'arrivo dei pellegrini, compresi quelli
dei treni bianchi unitalsiani. E in effetti fu così, perché la rivista
del santuario nel maggio 1947 avvertiva i lettori che i lavori erano
terminati e che tutto era "tornato normale".
L'apprezzamento per l'opera del Biagetti è fortemente
dichiarato nella stessa rivista, che parla di "esperto occhio del
direttore dei lavori" e di "processo originale e sicurissimo di
risanamento".
Il giudizio del
Biagetti sugli affreschi del Maccari
In questo discorso è utile conoscere la valutazione
critica del Biagetti sul ciclo pittorico del Maccari. A riguardo va subito
distinto l'approccio con la decorazione maccariana del Biagetti
restauratore e quello del Biagetti pittore e critico d'arte.
Nel primo caso il suo giudizio, come è comprensibile,
appare positivo, anzi entusiasta. Scrive il restauratore:
"L'opera di Loreto è senza dubbio la più
vasta e complessa del Maccari, ed una delle più eccellenti del secolo
XIX. Qui l'artista - nel pieno vigore delle sue forze - ha cantato con
precisione di forma e con squillanti sinfonie cromatiche l'apoteosi
della Madonna, trattando particolarmente, con alata profondità di
concetti, le Litanie Lauretane, il culto e la definizione del dogma
dell'Immacolata".
In un'ultima analisi, l'eccellenza dell'opera pittorica
da restaurare finiva per esaltare la stessa bravura del restauratore.
Ben diversa invece è la valutazione del Biagetti
critico nei riguardi del complesso ciclo maccariano. Egli se ne occupò
nel 1927 con un scritto apparso nella rivista del santuario di Loreto. Da
un lato apprezza nel Maccari l'eccezionale capacità nella tecnica
dell'affresco che gli consente di "inondare vaste superfici murali di
rutilanti sinfonie cromatiche", ed elogia la sua "padronanza
assoluta delle leggi del disegno e della prospettiva". Dall'altro
lato però gli nega la capacità di muovere i sentimenti. Scrive:
"non seppe sussurrare al cuore dei devoti la parola sommessa, ma
profonda e toccante, che val più di ogni gesto declamatorio".
E muove critiche al pittore senese anche sul piano
delle esigenze decorative, quando parla di "irrazionale partito
decorativo di quel terreno - su cui si sviluppano le grandiose scene - che
turba le buone norme della pittura murale, le quali esigono assoluto
rispetto delle superfici costruttive".
Il Biagetti definisce le scene del tamburo "opera
slegata, episodica, soprattutto antidecorativa e teatrale", perché
il pittore, rotto ogni freno, si compiace dei "contrasti più
violenti", tentando di amalgamare idealismo e verismo, sacro e
profano, scene all'aria aperta e scene al chiuso.
Il Biagetti apprezza di più, invece, i dipinti della
calotta. Scrive:
" Qui il profondarsi delle lontananze, la
luminosità delle scene, la vigoria cromatica dei drappeggi, la
precisione delle forme, la sontuosità delle fogge, l'arditezza dei
contrasti sono quanto di meglio abbia prodotto il Maccari e
rappresentano un insieme pittorico di altissimo valore, oltre che uno
sforzo poderoso di tecnica d'affresco".
Tuttavia, conclude che, "a trattare ancor più
degnamente l'altissimo tema bisognava aver avuto il coraggio di liberare
il pennello da ogni intemperanza e di munirlo d'ali".
Respinge il giudizio riduttivo del Biagetti il pittore
Arturo Gatti, devoto discepolo del Maccari, come emerge in un suo articolo
del 1952, dove parla - con implicita allusione all'artista portorecanatese
- di "certi puristi intransigenti", secondo i quali "i
dipinti non debbono sfondare le rispettive pareti", dato che
"nella pittura murale bisogna rigidamente rispettare l'organismo
costruttivo architettonico delle pareti medesime" .

|
| |
La pineta di
Volpino Volpini di
Giuseppe G. Perfetti
La pineta di Porto Recanati è un luogo ben definito
nella sua ubicazione che i portorecanatesi e non conoscono, di cui tutti,
chi più chi meno, hanno goduto l’ombra e il fascino e che per molti
potrebbe essere lì da sempre.
La ricordiamo sempre lì mentre si deteriora e si
riprende spontaneamente poi ancora viene rovinata, ripiantumata e cosa
altro ancora, ma così non è sempre stata, anzi in molti sanno che agli
inizi del secolo XX al suo posto non c’era altro che sabbia. Ma quei
molti non sono ascoltati, sono quegli anziani che si lamentano delle
trasformazioni del Paese rispetto a quell’ideale rappresentato dal loro
vissuto.
La Pineta è nata perché c’è stato chi l’ha
voluta, chi gli ha dedicato cinquanta anni della propria vita a contatto
con i coloni che prestavano la loro opera e professori le loro idee
riuscendo a tirare fuori il meglio dalle sabbie sterili dei relitti di
mare sperimentando continuamente, non abbattendosi di fronte a sconfitte
temporanee perseguendo sempre l’idea di dover e poter fare qualche cosa
che potesse insegnare ad altri, primi fra tutti i suoi amati nipoti e
pronipoti, che con la tenacia e sacrificio si ottengono grandi cose, belle
e positivamente economiche.
Non si è quindi formata spontaneamente ne tanto meno
facilmente come invece facilmente se ne sta andando dopo anni di incuria.
Non ricordo però di qualcuno che me ne avesse parlato
o che avesse fatto cenno all’azione continua di un uomo che appunto
quella pineta e non solo pineta aveva voluto se non in una lettera scritta
alla redazione della "Tartana" dove appunto
compare il nome dell’Ingegnere VOLPINO VOLPINI…….membro della
famiglia Volpini, fratello di Enrico sindaco di Porto Recanati dal 1895 al
1911.
Pochi mesi fa dagli scaffali di quei nipoti e pronipoti
su accennati sono usciti due libri che proprio della nascita della Pineta
parlano, delle fatiche di quell’impianto e della realizzazione di un
sogno deriso un po’ dai molti, che era appunto COLTIVARE LE DUNE MARINE
(1930) passando poi ai particolari nei FRANGIVENTI NELLA REDENZIONE DELLE
SABBIE MARINE corredate da foto interessantissime dove compare
frequentemente il colono Fortunato Torregiani e solo sporadicamente l’autore
ing. Volpino Volpini.
Perché nulla di quanto fatto vada perduto riproponiamo
la lettura del primo libro intervenendo il meno possibile per non alterare
lo spirito e il desiderio dell’autore nel senso di colui che ha fatto
(operato) e non solo scritto.
Chiaramente scritti in epoca fascista a parte un paio
di riferimenti al regime e alla frase finale dove si afferma che "La
parola difficoltà è sparita dal vocabolario fascista; ora si deve
credere, obbedire, combattere", lo spirito è quello dello
sperimentatore che vuole sì il riconoscimento di un lavoro fatto nella
bonifica, ma offre anche questo lavoro, i risultati di una sperimentazione
a quanti vogliono ripercorrere questa strada del recupero all’agricoltura
di terre altrimenti non sfruttabili.
Titolo: COLTIVATE LE DUNE MARINE (Le mie sabbie
marine verdeggiano 1895-1929) su sfondo di Pino Marittimo e pineta con
scritto sulle radici "TENACIA" e il nome dell’Autore, edizione
Simboli Recanati.
Libri ritrovati con dedica ai "nepoti"
Michele e Francesco perché sappiano che Volere è potere.
L’Autore si rivolge al lettore direttamente, meglio
se appassionato agricoltore, perché ciò è indispensabile per valutare e
capire la portata tecnica e spirituale del lavoro svolto, e indispensabile
cioè l’essenza della mentalità del rurale : attesa per lunghi mesi o
anni, nascita del seme e gioia del vedere il germoglio, felice nella sua
semplicità, nella sua sapiente e provvidenziale tenacia. Seguono le foto
e le biografie dei genitori Giovanni Volpini e Michelina Zaccagnini a cui
questo libro viene dedicato e l’espressione del desiderio che quanto
detto e fatto possa essere un contributo non vano al buon nome della
famiglia con la speranza che i componenti di essa ne calchino le onorate
orme.. convinto che tutto si conquista, in modo stabile, soltanto con
lento e faticato lavoro e con sani e tenaci propositi .
Seguono un indice alfabetico dei capitoli e l’indice
delle 29 fotografie, si arriva così al terzo sottotitolo VOLERE Ė
POTERE.
A destra del fiume Potenza come in tutta la costa vi
era una grande distesa di sabbia di 15 ettari, calcarea, silicea, sterile,
completamente incolta: RELITTO DI MARE arida duna a tre metri sul livello
del mare di proprietà dei Volpini che l’avevano acquistata dai
Cingolani (1879), Brunacci (1894), Borghese (1906).
Prime colture effettuate per rendere la sabbia
discretamente fertile furono, sulla ,erba medica e favette, seguì un
piccolo canale e la piantumazione di numerose viti maritate ad acer
campestris, pioppi di vari genere e pini protetti dalle piene del fiume
con argine di terra rivestito da canneto; la parte in golena fu rafforzata
con salici, pioppi, acacie, tamerici ed altre la cui forza e vigoria è
visibilmente degradante dal monte al mare.
Vi sono poi paralleli al battente del mare, due argini
robusti, uno quasi al confine con la proprietà demaniale litoranea ed un
altro a monte, rafforzati tutti da canne e tamerici. Fra i due argini una
superficie di tre ettari, messa a coltura ordinaria, ad ortaglie, file di
viti basse, frutta. Ma la difesa della siepe di tamerici non è
sufficiente contro il vento salato e le acque del mare che filtrando
danneggiano in parte i prodotti del suolo. Nel 1917 il mare arrivò a
coprire tali territori per alcuni giorni e per risanarli si dovette
incanalarvi dell’acqua dolce abbondante.
Vicino a questo terreno vi è una casa, definita
ordinaria, con capanne ed accessori ad uso del mezzadro e li vicino una
palazzina molto comoda, Villino Potenza tenuta come centro agricolo per l’Amministrazione
dove si radunano piante secche, sementi da selezionare e tenere in
osservazione e vi si mettono in incubazione circa cento once di seme di
bachi.
Togliere quindi al mare e all’azione dei venti
salmastri questa zona di dune sembrò impresa ardua ed insuperabile tanto
da stimolare la sfida dell’ing. Volpino Volpini oltre che i sorrisi di
molti che osservavano i primi piantamenti con scetticismo. Risero in molti
allora….; oggi, all’ombra di saluberrime piante, allietato dal
canto di molteplici uccelli, svagandomi coi piantamenti, colla caccia e la
pesca, OGGI RIDO IO, ed è naturale la mia viva
soddisfazione di godervi la sana, semplice invidiata vita campestre e
potervi raccogliere frutta belle e saporite. (Ricorda una pronipote
che proprio i frutti venivano offerti ai suoi piccoli ospiti in quello che
giustamente riteneva il suo giardino). Certo i risultati sono stati
migliori delle aspettative, ma occorse superare anche le difficoltà
paventate dal vecchio contadino.
Simpatica fu la messa in opera di cassette sui pini per
i piccioni che si avvicinano alle mani dell’ingegnere per mangiare ma
che sono anche preda di gufi, falchi e barbagianni ora tenuti a bada da
una sicura canna di fucile.
Gli unici a sostenere ed incoraggiare nella lotta
contro la sabbia sterile, siccità venti ed altro furono i fratelli Enrico
e Attilio che da affittuari della tenuta di S.M. in Potenza avevano
tentato la messa in opera di una piccola pineta fin dal 1880. I risultati
di quell’esperienza: stentata vegetazione, il parziale e graduale
deperimento furono prezioso insegnamento ed aiuto nella lotta successiva
ingaggiata per il rimboschimento della più estesa zona adiacente.
Prima cosa da fare, l’analisi del terreno: sabbia
lavata dal mare priva di ogni più piccola traccia di materia organica che
si estende fino alla profondità di tre metri e mezzo al livello dell’acqua
freatica alternando strati di sabbia e ghiaia , secolare lavoro delle
acque e del vento. Materiali utili per costruzioni, ottimo per cemento.
A questo proposito si fa cenno all’emancipazione del
Porto da Recanati nel 1893 e all’elezione del fratello Enrico quale
sindaco nel 1895 il quale incaricò il cementista Gabellini a fare la
fognatura bianca per l’acquedotto pubblico, oltre che dotare il paese di
energia elettrica, edificio scolastico, riordinamento delle strade con
contratti tali da fornire utili per altre opere pubbliche (con la luce fa
l’acqua e con questa la fognatura). Proprio al Gabellini cedette
gratuitamente le sabbie per il cemento armato per le opere pubbliche
perché prive di sostanze organiche, ma hanno il pregio di mantenere più
a lungo le piante ivi allevate, senza bisogno di concimarle e lavorarle
profondamente in antitesi alle leggi per le colture dei campi ordinari.
Spiegazione possibile: la forte permeabilità all’aria all’acqua e la
facilità con cui le radiaci si nutrono, moltiplicano e approfondiscono.
Però il trapianto non è cosa facile e per ovviare a tale inconveniente l’ingegnere
mette sotto la sabbia terreno buono dove le radici si fortificano e
diventano adatte al trapianto con pane.
Ma un altro malanno si presentò subito nella
moltiplicazione sorprendente delle lumachelle che distruggevano fin le
più piccole tracce della vegetazione tanto da dover ingaggiare una lotta
secondo un serio programma di applicazione.
Ad un chilometro a monte del terreno vi era una sorgiva
d’acqua (portata litri 12 alla temperatura di 8°C) ed un fosso di scolo
che arrivava alle sabbie. Acqua provvidenziale ma il fosso, 1,3 m.
profondo, permetteva il rapido assorbimento dalle prime sabbie filtranti.
Pertanto prima cura fu sollevare il più possibile il letto e far giungere
l’acqua dove meglio poteva servire e grazie proprio a quelle acque
torbide e ai suoi sedimenti naturali sparsi dentro i fossi che questi si
impermiabilizzarono. A trenta anni da tali interventi, il sistema di fossi
e di piccoli canali viene alimentato a rifolta ed a rotazione, specie in
estate mentre d’inverno sono tenuti pieni per creare e depositare fango.
Ai fossi principali si diede forma di trincea con banchine laterali dove
furono impiantati canneti che diventati robusti fungevano da frangivento.
Ma dato che le canne perdevano le foglie, dovevano essere tagliate
annualmente e si lasciava campo libero ai venti di Greco-Levante durante
la primavera seccandosi le giovani gemme od avvizzendo i rami più alti
e teneri ritardando lo sviluppo regolare delle piante. Si è cercato
di formare ripari con le canne legate ma fu vano, e la sperimentazione
continua con nuove prove.
Lo scopo infatti che si vuole raggiungere è quello di
preservare le piante dai venti salati che dal Conero a San Benedetto
rendono la vegetazione vicino al mare "misera". Tale effetto
sembra essere prodotto dai suddetti venti, i più salati, che deviati dal
Conero risultano più violenti a Porto Recanati e Porto Potenza Picena. I
maggiori danneggiati risultano comunque essere i pini più bassi rispetto
a quelli alti ma ci si chiede: se entrambi sono stati investiti dal salso
depositato nelle foglie e nei rami, perché solo i pini più bassi sono
danneggiati? E perché risultavano danneggiate le foglie verso il mare se
la densità salina si trovava attorno alla pianta allo stesso livello?
Occorreva individuare altra causa che doveva aggiungersi alla prima per
rendere sensibilissimi i danneggiamenti nelle parti più basse.
Dal pulviscolo accumulato dopo forti venti, al piede
delle piante, specie dalla parte di mare, fu naturale dedurre che questo
doveva ferire le foglie (smeriglio) e se nella ferita si inietta il sale
questo fa seccare le foglie lacere. Tale ipotesi fu confermata dal Prof.
Dott. Vittorio Racah nel giornale L’Italia Agricola del giugno 1927.
Perciò vennero adottati mezzi per fermare le sabbie, usando specie di
erbe più comuni lungo il nostro mare o altre fatte venire da fuori (dal
ProF. Borzì, direttore del Giardino di acclimatazione di Palermo ebbe il Saccarum
Spontaneum) ma pochi cespi dei tanti venuti da Milazzo distribuiti
nelle divese posizioni e condizioni ambientali resistono ancora. La
sperimentazione con la Psama suggerita dal Ministero dell’Agricoltura,
anche se migliore di quella del Saccarum non fu positiva sia riprodotta
per seme che per rizoma.
Dopo vari tentativi con diverse specie come cardo delle
sabbie, timo, scotano, salvia, serpillo, trifoglio, crocetta, finocchio
selvatico, erba medica, un beneficio inaspettato si ebbe con alcuni
ramoscelli e piantine d’edera e delle piante di rovo che compiono un
lento ma incessante lavoro nella trasformazione graduale delle sabbie
mantenendo la desiderata verdura ed umidità. Il rovo migliora detti
effetti riparando dal sole e dai venti le piccole e tenere piante nate
sotto di esso. Si è così potuto creare in luogo elevato a piena
esposizione dei venti una bella siepe di sempreverdi, hevonium, lauri,
ginepri, laurine e ligustri. L’edera ferma le sabbie mobili, le ricopre
di verde modificandone la composizione e nello stesso tempo rende
movimentato ed artistico l’ambiente.
Ma l’edera danneggia le piante di essenza dolce per
cui viene strappata da esse e lasciata soltanto nei pini e nelle acacie.
Stressa cosa fu fatta con i rovi divenuti forti a danno di altre essenze:
tagliati profondamente nella stagione calda perché neppure i polloni
potessero vivere. Non si può certo permettere a questi di espandersi
liberamente e a farla da padroni anche se è doveroso ed utile segnalare
ad altri agricoltori la loro opera.
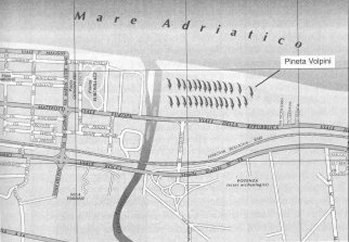 Da tali ragioni ebbe origine la seguente lapide: Da tali ragioni ebbe origine la seguente lapide:
INCULTA ET STERILIS VENTISQUE AGITATA MARINIS
DENSIS SEPTA RUBIS CULTAQUE ARENA VIRET
QUESTO VOLLERO
FIN DAL 1895
I FIGLI
DI GIOVANNI VOLPINI E MICHELINA ZACCAGNINI
Questo perché la famiglia sappia che il rovo
contribuì fortemente alla bonifica delle sabbie desertiche come
fortemente vollero i fratelli Enrico, Attilio e Volpino con opera costante
e tenace in memoria delle parole del padre Giovanni che diceva: " le
tribolazioni, le spine fanno gli uomini grandi. Figli imparate a penare…
chè a godere farete presto ".
Il terreno fu solcato da sei fossi principali paralleli
al mare e da sette perpendicolari a questi. In tutti, per i sedimenti
depositati, possono scorrere le acque con relativa velocità e distribuita
alle vicine piante sitibonde.
All’alba del 24 maggio 1915 cinque navi austriache
bombardarono la costa tentando di distruggere il ponte in muratura della
provinciale e quello ferroviario quando ancora la popolazione non sapeva
della dichiarazione di guerra. Nessun danno alla ferrovia e lievi a quello
viario ma raso al suolo il casello ferroviario con le prime vittime
innocenti della 1° Guerra Mondiale. A Macerata si riteneva bombardato e
distrutto tutto Porto Recanati, dopo di che furono organizzate squadre di
volontari come vigilanti notturni sulla torre del castello di Federico II,
fu inoltre impedita la pesca a vela e limitata al solo giorno quella delle
sciabiche. Disoccupazione e miseria in gran parte delle famiglie anche per
la mobilitazione dei cittadini nelle navi da guerra o inviati al fronte.
Per tutto questo parve opportuno all’ingegnere adibire allo scavo di un
fosso tutti i volenterosi cittadini dai piccoli ai vecchi. La retribuzione
fu uguale per tutti e superiore alla paga normale. Una elemosina natalizia
sarebbe stata umiliante. Quindi dal 15 al 24 dicembre 1915 fu scavato un
fosso maggiore e più vicino al mare lungo quasi un chilometro e la sabbia
gettata solamente a monte formò un secondo argine di difesa (definita
trincea di guerra).
Nel marzo successivo venne piantato il solito canneto
nella banchina verso mare e le altre piante abituali, nell’argine
migliaia di talee di tamerici che non attecchirono mentre fra le canne
verdeggiano pini, sanguinelle, olivelle ecc. ecc.. Fu sparso quasi in ogni
punto della località un quintale di seme di ginepro croccolone che
germoglia anche dopo 5 anni con accrescimento lentissimo, Solo alcuni
esemplari sono cresciuti di 1,5 m. dopo 12 anni ( il maggior numero è
ancora basso) grazie al fatto che hanno spinto le loro radici in sito
umido e ne fu riprova il trapianto di alcuni esemplari lungo un fosso dove
divennero presto alti, filosi e diritti. Il trapianto è possibile ovunque
perché attecchisce facilmente anche senza zolla, resiste bene alla
siccità anche se trapiantato grandicello. Prime bacche dopo 150 mesi e da
queste ci si aspetta un ripopolamento spontaneo e più sollecito.
Il ginepro comune all’inizio della bonifica sembrava
non volesse attecchire, ora con seme ottenuto in sito è presente ovunque
nelle sabbie eccetto nei posti fronteggianti il mare per la poca
resistenza ai venti salati, il ginepro croccolone invece non li teme
diventando sentinella avanzata e resistente alla siccità spingendo
profondamente le sue radici.
Nel 1925 il capo del Governo S.E. Mussolini intese
incoraggiare ed intensificare la più naturale e redditizia industria
italiana, l’Agricoltura. Ingaggiò la battaglia del grano abbracciando
tutto il complesso degli svariati prodotti agricoli, successivamente
proclamò la Bonifica Integrale, volle che i campi e lo sport fossero
sempre meglio coltivati. Fu allora che fra il coro di lodi un numero di
incensatori e cortigiani approfittò per gridare spesso più forte in
ragione diretta della propria ignoranza dimenticando che le esigenze dei
campi e delle piante variano per ogni clima ed ambiente. Parlarono molti,
troppi, di tutti i sistemi di irrigazione ciascuno doveva essere il sana
totum ovunque. Non si badò alla convenienza economica ne alla mentalità
dell’agricoltore diversa da quella dell’industriale, per cui una
disillusione può ritardare per anni ed anni il vero remunerativo e
duraturo progresso.
Tali indicazioni non lasciano indifferente lo
sperimentatore che da 30 anni cerca di sfruttare al meglio il sole e l’acqua
e volle provare l’irrigazione a pioggia e quella sotterranea. Per la
prima con pochi tubi di ferro zincato mandò acqua in un serbatoio, posto
alla piattaforma dell’aeromotore per farla riscaldare prima di
adoperarla e per la seconda costruendo una condotta con mattoni a tre fori
cementati dove far scorrere acqua a pressione.
Dopo vari esperimenti durati alcuni anni, l’irrigazione
per assorbimento risulta la più indicata con minori pericoli per le
piante dato che l’acqua attraversa il suolo riscaldandosi per giungere
alle radici facendole sviluppare ed approfondire. Prove particolari furono
fatte con il grano del quale si stimò una resa di 10 quintali per ettaro
senza concimazione.
Gravi difficoltà di attecchimento di solito si
incontrano nel trapianto dei pini, ma così no è stato per l’ing.
Volpino che ottenne anzi un attecchimento rigoglioso del 93% anche se i
pini non erano stati allevati con cure particolari che anzi davano
risultati del 3-4%.
Come tutto questo? Con una semplice economica trovata
(l’uovo di Colombo), togliendo tutta la sabbia dalle radici, si troncò
il fittone e le radici più profonde lasciando le superficiali
raccorciandole tutte meno tre, si distanziarono con un sasso le parti
tagliate del fittone e si pose della terra vegetale per pane nella buca
scavata. Dopo un anno dai tagli delle radici nuove ed abbondanti
radichette vennero fuori. L’economicità del rimpianto fu individuata in
bosco di pini tropo fitto che doveva essere diradato permettendo il
recupero di piante fin da 25 cm. di diametro da abbattere. Ma anche qui il
lavoro sarebbe stato vano se non ci fosse stata acqua abbondante che
facilita l’emissione ed il rafforzamento delle radici.
Incoraggiato da questi buoni risultati e preso dall’idea
di far verdeggiare la zona prima desolata, si provò con simili trapianti
di ogni specie utilizzando i non pochi soggetti imperfettamente riusciti
nei vivai privati. Fra questi due querce da sughero da sacrificare ad una
strada pubblica che con lavoro di binde, carrucole e operai. Una di queste
fa bella pompa di sé nelle sabbie. Anche qui fattore importante fu l’acqua
che anche se adoperata per parecchi giorni di seguito non reca qui nelle
sabbie danni che si verificherebbero in terreni ordinari dato che il
sistema radicale è molto sviluppato in esteso in senso orizzontale. L’acqua
opportunamente adoperata e non la sabbia fanno vivere le piante.
Fra le numerose specie di pini messe in prova attenzione
maggiore è posta sul Marittimo che cresce più facilmente, si adatta
meglio qui e resiste abbastanza bene ai venti salati. Ma già negli anni
30 qualche campione presenta delle anomalie: la foglia ingiallisce, cade e
la pianta qualche volta muore. L’istituto di Patologia vegetale di
Verona escluse l’esistenza di crittogame o insetti micidiali senza poter
indicare cause plausibili.
Il pino di Aleppo cresce molto bene se riparato dai
venti che facilmente lo schiantano. L’ideale sembra essere quello da
pinoli che cresce lento ma forte e resistente purché sia giunto all’altezza
di tre metri, e produce buona legna e abbondante frutta da qualche anno
vendute con profitto.
La semina può essere fatta in autunno o primavera,
quest’ultima preferita per far si che le piantine nate dopo dodici
giorni segue la vegetazione e sfugge alle sferzate del vento invernale
trovandosi con radici profonde per l’estate. La semina va fatta a
spaglio denso ed il seme poco interrato. È proprio in occasione della
semina che un illustre Ispettore forestale volle assistere ad una semina
partecipando con consigli attivamente a questa, ma dopo parecchi anni di
quei pini sono vivi solo pochi esemplari. La teoria insegnava tali
pratiche, l’esperienza locale indicava altre vie, prima fra tutte il
troncare i rami laterali bassi, concentrata quindi la linfa verticalmente
con sviluppo delle gemme terminali che sfuggono alle smerigliature radenti
(vale più un pazzo in casa sua che cento savi in casa altrui, rida
pure chi vuole). La tecnica agraria va conformata all’ambiente, si
legge pertanto malvolentieri gli scritti di quei sapientoni, che tutto vogliono
regimentare e generalizzare nella nostra bella Italia di suolo
svariatissimo e che simili a se gli abitator produce.
Si sono sperimentati otto semi forniti dal Prof.
Pirotta presi dal giardino del Kaiser prima della guerra che hanno dato
esemplari bellissimi con rami flessibili ed aghi sottili.
Per fermare le sabbie si sono impiantate abbondanti e
rigogliose siepi di rosmarino che periodicamente vanno degenerando ma che
sono preziosissime per allevare fra esse i piccoli pini o ginepri.
Difficoltà si incontrano con l’Aylanthus (americano)
che appena giunto a grandezza di 10-12 cm di diametro sembra colpito da
malattia anche se ripullulano dalle radici propagandosi in quantità
infestante e disordinata per seme ma mai diventano grandi. Che siano i
pini a minacciarne l’esistenza?!
Le canne fra i tanti pregi hanno pure quello di formare
nelle banchine e nei fossi una fitta rete di rizomi rassodanti gli argini
e un discreto reddito considerevole perché sono necessarie per i vivai ed
altrimenti se ne dovrebbero acquistare parecchie ogni anno. Stessa cosa
dicasi per i vimini che si riproducono lungo i fossi solo se ben riparati
dal salso ma non vivono a lungo.
In un avvallamento del terreno da dove era stata
estratta molta sabbia per lavori summenzionati e che serviva come fossa di
assorbimento e il mare libero di entrarvi rendeva impossibile ogni
bonifica e non vi regnava che la cannuccia delle paludi, unico uso era la
caccia. Facendo un cunicolo con tavole prima e tubi di cemento poi, questo
servì egregiamente come scolo delle acque piovane che si richiudeva con
le sabbie portate dalla onde. Il canale lungo una quarantina di metri fu
rinnovato dopo 20 anni nel 1926.
Con tutti questi accorgimenti ed espedienti diversi, la
estesa, brulla radura di 30 anni prima produce ora ricchezza crescente
anche se gradatamente. Produce già legna, canne, vimini, semi e inoltre
questo bosco non è fine a se stesso, ma come folto frangivento parallelo
al mare lungo più di un chilometro e largo 150 metri porta vantaggi alle
terre retrostanti di sua proprietà. Ecco il bosco protettore, veramente
benefico. E considerando che buona parte delle coste marine formate
esclusivamente da sabbie fossero in tal modo bonificate quale immenso
vantaggio ne verrebbe alla Nazione?!
Ci si augura che il nuovo Ente Forestale possa
estendere e sollecitare i lavori privati e pubblici alla luce di questa
esperienza, là dove fosse possibile usufruire di acque abbondanti ed
economiche per bonificare estesi banchi di sabbia.
Ma fermare le sabbie, riparare dai venti sarebbe stato
lavoro inutile, se un più temibile essere, l’uomo, fosse stato libero
di invadere questa zona. Quindi uno studio speciale fu necessario per
recingere di siepi l’appezzamento, dato che il libero ingresso di
uomini, donne e ragazzi aveva già portato danni rilevanti e diversi non
potendo da profani rispettare quelle piccolissime piante ed erbe varie che
erano in osservazione e studio.
Anche la gramigna speciale offerta dal prof. Borzì di
Palermo usata come ferma sabbia venne distrutta per farne cibo per asini.
Un villeggiante non trovò di meglio che tagliare una siepe di rosmarino
fin alle radici ( che vendeva ad una rivenditrice di verdure). Un fante
durante la guerra incaricato di costruire una trincea, pieno di zelo
tagliò piante faticosamente allevate, ed un drappello della Milizia
Territoriale in sorveglianza notturna costiera sentendo freddo bruciò per
parecchie sere pini alti tre metri.
Il recinto pertanto era necessario e fu fatto con filo
spinato su pali di cemento e in alcune parti con rete metallica. Ma non
bastarono a fermare i ragazzi in cerca di nidi e frutta e pesca abusiva di
anguille e tinche nel laghetto artificiale. Siepe senza spine sarebbe
stata inutile e quindi le jucche che crescono bene furono le piante
elette a tale scopo, attecchiscono tutte anche senza radici, provengono
tutte dal giardino di Santa Maria in Potenza dove un vento le aveva
abbattute. Portate sulle sabbie facilmente attecchirono e divennero
robuste. Furono moltiplicate, servendosi di polloni e di pezzi di fusto,
tanto da poter in tre ani recingere tutto i fronte verso il mare impedendo
l’ingresso a chi non possiede buoni calzari…e questi solitamente
mancano ai nostri sciabicotti, assidui ricercatori dei rifiuti del mare. Non
è chiusura ottima non l’ideale ma l’unica resistente alla
smerigliatura della sabbia.
Per il recinto lungo l’Aprutina più lontano dal mare
dopo vari tentativi inutili fu individuata la maclura conosciuta 25
anni prima al Lido di Venezia ed acquistata a Marano, rimasta per 15 anni
sulla sabbia senza svilupparsi molto ma fu solo colpa della mancata
potatura stagionale sviluppando poi più precocemente dei comuni spini da
siepe ostacolando con le loro spine ladruncoli e malviventi. Fra questi
furono collocati fichi d’India ed Agavi, i primi riprodotto dai
pescatori che credendo di distruggerlo, ruppero le pale che toccando le
sabbie emisero le radici e formarono infinite piantine. Le seconde seccano
se il gelo le coglie con radici umide ma muore solo la parte sopra la
terra, ma sorgono intorno molti figli come quando danno il fiore.
Uno dei tanti flagelli che ritardano la redenzione
delle dune fu la enorme quantità di lumachelle che si riproducono con
incredibile celerità ed entità. Queste divorano quasi tette le tenere
erbe anche pseudo sparto e cardi. Per sfuggire i forti calori poi si
incuneano e stringono a forma di grossi grappoli fra le ascelle dei teneri
rami e più spesso intorno alle gemme terminali. I vari mezzi adoperati
per diminuire la intensità e violenza di queste furono vani: calce viva
sfiorita, solfato di rame e ferro al 20%, anitre domestiche, nemici
endofagi e coleotteri vari.
I lumaconi senza guscio furono distrutti quasi
completamente con un gruppo di galline faraone acquistate appositamente a
Reggio Emilia. Ma la lotta alle lumachelle era impari e costosa data la
immensa riproduzione e la grande zona da risanare, fino a che non balenò
un’idea : cingere le piante con carta imbevuta da veleno. Fu provato il
giorno successivo ottenendo un buon risultato dopo di che fu preparata una
funicella imbevuta con lo stesso veleno chiamata Ferma Lumache
Essa le ferma sotto di essa e ne facilita la raccolta (interessante
il metodo di studio frutto di osservazione e sperimentazione).
Le lumachelle fermate furono numerate, riportate ai piedi della pianta per
quattro volte e ad ogni operazione sempre meno salivano sulla pianta fino
a non tentare più la salita, sparivano ma non se ne trovavano morte. In
questo modo furono salvate molte piante.
Tale corda viene preparata con facilità e relativa
economia, ma non se ne dà la ricetta perché il ricavato della vendita va
alla Colonia degli Orfani di Guerra che ne fa la vendita. Il primo incasso
è stato di qualche centinaia di lire inviate dal Principe Aldobrandini di
Roma che lo ha usato e richiesto. Certo che, se si ottiene una fitta
vegetazione, le lumachelle diminuiscono a vista d’occhio e prendono il
loro posto le lumache mangerecce che recano danni minori e non si
arrampicano sulle gemme alte.
Fu fatto un Coclearium recingendo con un canale di
cemento dove scorre continuamente acqua ma non riuscì perché molte
affogarono altre furono mangiate da talpe e topi.
Per rendere attraente il sito dopo il bosco che aveva
come complemento la caccia, fu fatto un laghetto artificiale dove l’idea
della pescicultura già sorta nel 1919 sperimentata in Potenza Picena
nella colonia Zallocco sulla cava di prestito fatta dalle FFSS dove
furono seminate centinaia di carpe e tinche. Queste ultime, si seppe poi,
venivano vendute al mercato del paese vicino (pesca di frodo). Da detto
laghetto l’ingegnere si fece portare carpe a specchio e tinche per
colonizzare il laghetto della pineta e con le prime riuscì ad instaurare
un rapporto per cui queste si avvicinavano a prendere il pane dalle stesse
mani di chi lo offriva tanto da risultare meta gradita dei nipoti.
Di certo tali pesci ed altri presi dal Potenza si
accrebbero in breve tempo. Alla prima vasca se ne aggiunse un’altra
vicina più profonda per la caccia e per seminarvi altre carpe, tinche e
mugelle e fare inoltre un allevamento di anatre. Dopo qualche anno attorno
a queste si raccolgono discrete quantità di erba invernale per vacche
lattifere.
L’acqua non è mai sufficiente come elemento
necessarissimo per ottenere il bosco pertanto oltre ai numerosi fossi,
i due laghetti artificiali e l’aeromotore si è voluto impiantare una
noria (pompa) mossa da un asinello in concorrenza con l’energia
elettrica e preferito ai motori a scoppio che possono sempre venire a
meno. L’asino con il suo lento lavoro dà tempo alle acque fredde a
riscaldarsi nel lungo canale di cemento. Questa servirà per far meglio
attecchire una siepe di pini la quale poi dovrà riparare dal vento le uve
da tavola e di una piccola vigna con 20 diverse qualità.
L’allevamento delle api fu tentato nel 1900
inutilmente perché nella sabbia desertica e assolata non riparata da
venti esse trovano l’ambiente inadatto, inoltre le arnie venivano rubate
tanto che si ideò un alveare di otto famiglie con melario all’americana
assicurato con muratura e tale sistema fu premiato con medaglia di bronzo
all’esposizione di Macerata. Ora le condizioni sono decisamente diverse
e si pensa che potrebbero essere allevate facilmente.
Si conclude: Ad
ogni miglioramento agricolo, che si voglia intraprendere, le condizioni
del sole e dell’acqua debbono essere assolutamente e ponderatamente
studiate.
Segue una Rubrica delle specie vegetali sperimentate e
coltivate nelle sabbie marine e il loro comportamento. Tali specie sono in
numero di 184 ma non pago lo sperimentatore Ing. Volpino Volpini si
rivolge al lettore chiedendo un regalo a questo: indicami una pianta da
me non conosciuta e non sperimentata in queste sabbie; dammi qualche tuo
consiglio, che risponda alle mie finalità…Grazie Anticipate.
Con l’augurio che il suo grande amore ed
interessamento per queste sabbie sia di stimolo agli altri per conservare
le piante e migliorarle, ricordando il motto paterno che "volere è
potere" .. fa presente per la storia che, ai sensi dell’art. 2 D.L.
5 Gen. 1915 n° 60, veniva imposto nel 1919 a questo rimboschimento il VINCOLO
DELLE PINETE. Va così riconosciuta l’utilità nazionale ed
incoraggiata l’opera trentennale, che si è voluta assicurare per il
futuro contro inconsulte distruzioni….
...e mai tanto desiderio fu disatteso cinquanta anni
dopo.

|
| |
|
Ricordando Mario
Moriconi di
Bruno Venusto
Testo dell’intervento di Bruno
Venusto, letto in
occasione dell’inaugurazione della mostra retrospettiva delle opere di
Mario Moriconi, organizzata dal C.S.P. nel luglio 2000.
Non sono un critico d'arte perciò non mi permetto di
dare un giudizio tecnico sull'opera pittorica del nostro Mario. Ma sono
stato un Suo amico da tanto tempo e potrei essere tentato di dire: lo
conoscevo bene. Questo concetto, quello cioè di conoscere bene un proprio
simile o la persona che ti è accanto, è ancora più difficile che fare
il critico. Infatti se "ogni mistero ha un segno che lo svela",
l'animo umano è certamente il mistero più imperscrutabile che possa
esistere.
Tuttavia esso può fornirci, a seconda dei
comportamenti soggettivi, alcune indicazioni le quali dovrebbero
contribuire a darci una idea ben precisa dei suoi valori spirituali.
Quindi non credo di sbagliare se vi dico che Mario Moriconi era
soprattutto dedizione ed attenzione verso "l’amico"; era
essenzialmente comprensione e disponibilità all'ascolto dei problemi
esistenziali altrui e metteva sempre il suo interlocutore al centro
dell'universo mentre lui se ne restava in ombra; era indiscutibilmente un
vero altruista nel senso più nobile della parola ed era irriducibilmente
innamorato della natura della vita e della sua Porto Recanati.
In considerazione di questi pochi ma essenziali
elementi, seppur brevemente esposti e per la ricca personalità dell'UOMO
mi permetto di consigliare che a questa mostra il visitatore dovrebbe
avvicinarsi con accuratezza ed attenzione cercando di vedere anche e
soprattutto quello che non è disegnato nel quadro ma l'anima che l'opera
stessa racchiude. Infatti come non vedere nel vecchio che aggiusta la rete
anche il mare? Come non vedere nel Cristo anche tutta la passione di
Nostro Signore? Ed infine come non vedere nei nudi anche tutto il colore
ed il calore della vita? Colori e calore che non possono essere
riproponibili da un pittore qualsiasi ma che invece brillano di luce
propria e di calore umano nei disegni esposti.
In altre parole se noi diciamo soltanto che "La
Punto" la fabbrica la FIAT non avremmo scoperto niente. Ma se invece
diciamo che la "Punto" ha queste e quest’altre caratteristiche
che la contraddistinguono da tutte le altre auto allora avremmo sì capito
qualcosa.
Questa banale metafora vuole dire che noi ci troviamo
di fronte ad un artista Portorecanatese del quale sottolineare soltanto
l'indiscussa bravura e bellezza del "tratto" potrebbe essere
riduttivo se nella Sua opera non vediamo quello che realmente contiene,
cioè la spiritualità nei Suoi lavori suggerita dal sentimento che lo
spingeva a creare: il desiderio e la capacità di trasmettere EMOZIONI.
Gli amici così ricordano Mario. Ma il CSP ha voluto
questa mostra affinché tutta la cittadinanza possa vederlo per quello che
realmente era: UN GRANDE ARTISTA. E per concludere vorrei dire che se è
vero che dietro un "grande" UOMO c'è sempre una
"grande" DONNA allora permettetemi di nominarla: MARCELLA sua
moglie. Grazie a te Marcella ed ai tuoi figli per la vostra amicizia di
sempre.

|
| |
Le opere
pubbliche dal 1944 al 1956 (II^
parte) - di Aldo Biagetti
All’inizio del 1951 il Comune, nell’intento di
migliorare il decoro del paese, delibera (atto n. 54/2 del 5/3/1951) di
completare la piantagione di alberi in alcune vie del paese (A. Caro e
Pietro Micca), di attuare numerose aiuole da ambo i lati di Corso
Matteotti e di collocare a dimora alberi, già di pronto effetto, in
alcuni tratti del Lungomare e nelle vie S. Giovanni Bosco e Bramante.
Poco dopo la delibera consiliare n. 32/3 del 9/4/1951
si sofferma sui danni causati dalle mareggiate dell’8 e del 13 febbraio,
purtroppo in concomitanza con delle piene straordinarie ed esondazioni del
fiume Potenza e si elencano i danni causati da tali calamità. Vi è stata
anche l’asportazione delle testate dei pennelli costruiti nel 1935 in
difesa dell’abitato (sono 7, tutti realizzati con grosso pietrame
contenuto e bloccato da robusti involucri di rete metallica).
Si è già richiesto - viene precisato nella delibera -
l’intervento del Genio Civile di Macerata che ha presentato un progetto
dell’importo di L.8.000.000, con il quarto della spesa a carico del
Comune, pagabile in venti rate annuali senza interessi, a mente dei
benefici previsti dall’art.14 della legge 14/7/1907. Con questi lavori -
spiega il Sindaco - si ricostruiranno e miglioreranno i pennelli
danneggiati e si realizzerà un braccio in blocchi di cemento verso mare
al termine della sponda sinistra del Fiume Potenza, avendo così un molo
idoneo per eventuali attracchi dei natanti. Per questi lavori, subito
iniziati, si dovrà approvare anche una perizia suppletiva dell’importo
di L. 1.800.000.
Non riguarda i lavori, è di un onere contenuto, ma è
una delibera importante quella del 54/1951, n. 33, - Contributo alla Banda
Cittadina per acquisto strumenti - "subordinandone" il pagamento
alla costituzione in società della Banda stessa e chiedendo anche che la
relativa quietanza venga firmata dal Cassiere e vistata dal Presidente
La delibera n. 40/3 del 9/4/1951 tratta della relazione
inviata dal Prof. Ing. Arch. Bruno Sbriccoli di Roma, incaricato della
redazione del Piano Regolatore. Allegata ad un progetto di massima la
detta relazione viene integralmente riportata nell’atto amministrativo e
qui si stralcia:
... si è studiato a nord della città un piccolo
porto .... ed impianti annessi ... di fronte al porto la Caserma della
Guardia di Finanza.... e nelle zone adiacenti il Cantiere Navale,
industrie e negozi inerenti alla pesca.
Vicino il Villaggio dei Pescatori... la Pescheria non
dovrà subire spostamenti.
A sud della città con lo spostamento del Cantiere
Navale si prevede tutta una vasta zona a villini terminanti con Parco
Pubblico verso il Fiume Potenza.
Tutte le attività sportive sono previste nel grande
spazio verso il Fiume tra la Ferrovia ed il Corso Matteotti.
Dopo il rinvio di un anno per non disturbare l’Anno
Santo vengono indetti i Comizi Elettorali, si vota sempre con il
maggioritario e vince nuovamente il Fronte di Unità Popolare (avrà 16
consiglieri), all’opposizione la Democrazia Cristiana e partiti minori
(4 consiglieri, che sono Luigi Rabuini e Bruno Tesei, repubblicani,
Filippo Feliciotti, indipendente e Giacomo Grilli, democristiano).
Con il Consiglio Comunale del 10/6/1951 vengono eletti:
- Goffredo Jorini, Sindaco (con 19 voti su 20)
- Simone Giorgetti (socialista), Amilcare Caporalini,
Valentino Scalabroni e Luciano Mastini (comunisti) assessori effettivi
- Mario Benedetti (indipendente) e Luigi Scarafoni
(socialista) assessori supplenti
Tra le prime delibere della nuova Amministrazione
riportiamo:
n. 25/3 e n.26/3 del 14/7/1951 = Esame dello Statuto
presentato dalla Banda Cittadina e concessione di un contributo
straordinario di £. 150.000
n. 29/3 del 14/7/1951 = Costruzione di una nuova
Palestra, in Via Bramante, per una spesa di £. 3.200.000, essendo la
Diaz sempre impegnata per gli allenamenti della nostra nazionale
dilettanti di pugilato.
n. 54/6 del 6/10/51 = Monumento funebre ai Caduti in
Mare - "... promuovere l’iniziativa di un monumento marmoreo, che
ricordi i Caduti in mare, aprendo all’uopo una sottoscrizione"
n. 55/6 del 6/10/1951 = Costruzione linea elettrica
Archi, Villa Papa e Banderuola, progettata insieme ai Comuni di Loreto e
Recanati. Quota a ns/ carico £. 400.000.
è l’inizio di numerosi interventi per dotare
completamente di luce elettrica e di acqua potabile le frazioni e le case
sparse in tutto il territorio comunale. I lavori verranno completati nel
giro di pochissimi anni, anche con i rilevanti contributi dell’Ispettorato
Agrario di Ancona.
Tra le numerose delibere in merito si menziona solo
quella del 10/3/1952, n.11/4, ove si approva il progetto dell’impianto
elettrico in Contrada Montarice, per un importo di £. 3.300.000. Qui
viene segnalato che l’UNES si accolla un onere di £. 750.000 e che per
la metà della rimanente cifra verrà richiesto l’intervento dei
proprietari interessati
Si provvede quindi al restauro delle Mura Castellane,
all’asfaltatura di strade interne, previo ampliamento della rete idrica
e delle condotte fognanti (il Centro Urbano si sta ora dilatando su Via
Campanella, Via Loreto e Via Pastrengo) e con la delibera n. 62/8 del
30/6/1952 ad un ulteriore intervento, di ampio respiro (£ 1.800.000),
sull’argine sinistro del Fiume Potenza in esito ad una nuova alluvione
(del 24 gennaio) e conseguente inondazione dei terreni circostanti.
Si costruiscono inoltre i gabinetti pubblici di Via
Bramante (spesa £.1.500.000) e con delibera del 30/6/1952 si affida la
pulizia e la custodia, ad un concessionario a seguito di appalto, per £.
96.000 annue.
Il Comune intanto aveva da tempo programmato una nuova
Stagione Lirica che, pur assente Beniamino Gigli che si sta avvicinando
alla fine di una grande carriera, affronta e gestisce con impegno ed
entusiasmo, con il preciso obiettivo di qualificare la nostra Arena come
polo di richiamo per gli appassionati di musica operistica e nel contempo
quale motivo di spicco della stagione turistica.
Si mettono in scena, ai primi di agosto, per quattro
sere ed intervallate, la Traviata e la Tosca; nell’opera di Verdi
cantano Rosetta Noli ed il tenore greco Nicola Filacuridis, in quella di
Puccini Simona dall’Argine, il baritono Giuseppe Taddei1, di
nota valenza ed il tenore marchigiano Mario Binci che a metà dell’ultima
recita perde completamente la voce. Il maestro Federico del Cupolo, che
dirige tutte le serate, aveva previsto "l’incidente" che ha
indubbiamente mortificato la recita finale della Stagione Operistica. Per
la cronaca i cachet: Taddei £. 200.000 a sera, Rosetta Noli £. 140.000,
Filacuridis e Dall’Argine £. 140.000 cadauno, il M.o Del Cupolo - che
aveva diretto anche la stagione del 1950 - £. 340.000 complessive
(compreso tre giorni di prove).
Per il Comune, a parte l’esito finanziario non
soddisfacente tale da consigliare l’abbandono di una forse troppo
ambiziosa iniziativa, vi fu anche un momento difficile per fronteggiare
parte dei pagamenti per il ritardato arrivo dei contributi regolarmente
definiti. Vi fu allora l’intervento di Filippo Feliciotti, consigliere
della minoranza, che con la sua firma di ricco possidente, e per questo
molto apprezzata dall’Istituto Bancario, consentì di avallare una
temporanea operazione in attesa dell’arrivo dei finanziamenti
governativi.
All’inizio del 1953 vengono eseguiti radicali
restauri del primo piano del Castello Svevo, per una più razionale
sistemazione degli Uffici Comunali e di parte del piano terra per ricavare
un’ampia Sala Consigliare, il tutto per una spesa di £. 1.500.000.
In una riunione del 18/2/1953 i consiglieri esaminano a
lungo un progetto generale di opere a difesa dell’abitato (importo di
£. 60.000.000) ed un progetto di 1° stralcio di £. 14.000.000, redatti
sempre dall’Ufficio del Genio Civile di Macerata, non essendo stato
ancora istituito l’Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime (in
Ancona), cui passerà fra qualche anno la specifica competenza per tale
genere di lavori. Ogni decisione viene per il momento rinviata intendendo
i consiglieri approfondire il dilemma: pennelli o scogliere, dilemma che
sarà presto spazzato via per una categorica decisione governativa
optante, sulla base di studi elaborati da luminari del campo, per le più
costose scogliere.
Nella riunione del 28/9/1953 il Comune affronta, sulla
base di un progetto generale di £. 42.000.000 e di un progetto stralcio
funzionale di £.16.900.000 (per il quale si da corso subito alle
procedure per il finanziamento), il potenziamento del rifornimento idrico,
mediante il sollevamento di acqua potabile dal pozzo trivellato in S.
Maria in Potenza costruendo una idonea stazione di pompaggio a due piani,
la sostituzione dei ponteggi provvisori sul fiume Potenza per il passaggio
delle condotte con strutture in cemento armato e la realizzazione di un
secondo pozzo di prelievo, per riserva.
Contrastato e talvolta burrascoso il rapporto con il
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Ancona per ottenere la
prescritta approvazione degli elaborati progettuali, si ritiene qui
oltremodo elevata, addirittura abnorme, la previsione di una erogazione di
acqua pari a litri 250 pro-capite, il Comune ne sostiene l’assoluta
necessità e per il costante aumento della popolazione residente, su un
centro urbano sempre più vasto, per l’esplosione già in atto del
turismo balneare e per la previsione a lungo termine di anni di un’opera
di tale rilevanza e costo.
Dopo diversi giorni di dispute ed a seguito del
richiesto intervento di ingegneri del Genio Civile di Macerata, che in
prima istanza avevano già approvato i progetti, si ottiene il sospirato
nulla-osta.
Prima della fine dell’anno i lavori vengono
consegnati , alla Ditta Giuseppe Papa di Loreto, per le opere murarie ed
alla Ditta Elettromeccanica Picena per l’intero impianto di sollevamento
questo aggiudicato con appalto concorso e dell’importo di £. 5.250.000.
Dalla delibera n. 101/8 del 3/10/1953 rilevasi :
".. si decide di istallare i contatori con effetto dalla ultimazione
dei lavori di costruzione dell’acquedotto sussidiario", ma solo
alla fine del 1955 verranno istallati gli apparecchi misuratori della
Ditta Siemens e terminerà in tale data il lungo periodo di libero
consumo, soggetto ad un modesto canone forfettario, sorto sul termine
della guerra in conseguenza di un momento difficile per il reperimento dei
contatori.
All’inizio del 1954 vi sono ancora problemi per una
sensibile carenza di posti di lavoro e nella riunione del 18/1 (atto
n.10/1) il Comune approva un progetto di lavori di manutenzione delle
strade di campagna, per £.2.480.000, potrà usufruire di un concorso
dello Stato per il 50% dell’importo, con la riserva che i lavori
dovranno essere iniziati (come in effetti avverrà) subito, al massimo
entro il 31 gennaio.
Con la delibera n. 14/1 del 18 gennaio si approva il
progetto per la costruzione della Scuola Rurale di Montarice, che prevede
un edificio nuovo con due aule e l’appartamento per l’insegnante, per
una spesa complessiva di £. 6.700.000. Finanziamento (con il contributo
dello Stato) e lavori avranno un iter molto rapido. I consiglieri, in
diverse riunioni, esaminano a lungo vari studi per nuovi impianti di
illuminazione per il Corso Matteotti, per Piazza Brancondi e per il Parco
della Rimembranza visionano campioni in opera di vari tipi di diffusori ed
impianti, si esprimono quindi per la soluzione più costosa (delibere n.
46/3 e 50/5 del 54 e 46/3 del 30/4/1955) che prevede un onere di £.
13.500.000 (£. 4.270.000 per opere murarie e £. 9.000.000 per gli
impianti, in appalto concorso). Il nuovo impianto, simile a quelli già
realizzati a Rimini. in Viale Vespucci ed a Montecatini, in Viale delle
Terme, prevede la installazione di colonnine metalliche quadrangolari
colorate, con due tubi fluorescenti da 40 watt ogni lato, schermati da
particolari vetri in plexiglas, nella parte superiori e cavi interrati per
le linea elettrica. I lavori vengono assegnati alla Ditta S.I.M.E.
(Società Impianti Materiali Elettrici) di Ascoli Piceno.
Contemporaneamente ai lavori di cui sopra vengono ristrutturate la Piazza
Brancondi, con fontana rettangolare in botticino siciliano e getti
luminosi d’acqua, con aiuole, panchine, calendario in fiori variabile
secondo i giorni ed il Parco della Rimembranza con la sua fontana rotonda
al centro. È questo un momento di passione generale per le fontane ed il
Sindaco Perugini di Macerata avrà consensi per averne piazzate quattro
nei punti nevralgici della città (anche davanti al Teatro Lauro Rossi) ed
in Ancona davanti alla Stazione, quasi al centro della Piazza, viene
realizzata un’imponente fontana luminosa.
Con la delibera n. 110/8 del 31/10/1955 si definisce,
con la T.I.M.O., dopo sei mesi di estenuanti trattative, l’automazione
del servizio telefonico con il completo riordino e l’ampliamento della
rete di distribuzione e con la realizzazione di una centrale automatica.
Condizioni a carico del Comune: contributo di £.
300.000 (da versare a tre annualità)e cessione in uso, a titolo gratuito,
alla T.I.M.O. di locali al piano terra del Castello Svevo per installare
la Centrale e per il Posto Telefonico Pubblico. Con atto n. 109/10 vengono
assegnati alla Ditta Giulietti Luigi i lavori di ampliamento e restauro
della Palestra Diaz, per l’importo di £. 2.000.000, cifra che verrà
poi rimborsata dal C.O.N.I. -
Nel novembre del 1955 il Comune, per il sorgere di un
nuovo quartiere nella zona sud dell’abitato, tra il Corso Matteotti, l’attuale
Via De Gasperi e la Ferrovia amplia la rete fognante collocando anche un
nuovo collettore a monte del rilevato stradale di Viale Europa, sfociante
nel Fiume Potenza presso il ponte in ferro gettato dai genieri inglesi nel
1944, durante l’avanzata e che presto verrà sostituito da quello
esistente, ad opera del Genio Civile di Macerata.
Si dispone poi la costruzione di un capannone in
muratura in Via degli Orti, da adibire a laboratorio della Scuola di
Avviamento Professionale a tipo industriale maschile e femminile, per una
spesa prevista di £.2.500.000, mentre per le aule si è provveduto per
una temporanea sistemazione al piano terra del fabbricato giustamente
denominato all’epoca Palazzo degli Studi, ora sede della Civica
Amministrazione.
Ritenuto di aver risolto tutti i principali problemi di
prioritarie esigenze (quali acquedotto, fogne, strade, scuole, impianti di
illuminazione) il Comune affronta - inverno ‘55/’56 - con propri mezzi
di bilancio, un’ingente spesa per un’opera che considera di notevole
richiamo e tale da qualificare l’intera cittadina ed il suo aspetto
urbano.
È il Lungomare: mt. 700 di balaustra in travertino,
mq. 4000 di pavimentazione con piastrelle di cemento colorato, tre
piazzali belvedere aggettanti verso il mare, una quarantina di panchine e
35 aiuole pure con alberi di medio fusto. Nel piazzale più a sud vengono
collocati elementi tipici del mondo marinaro, come reti, ancore, ecc. con
l’intento di piazzare al centro di un piccolo laghetto una lastra di
granito con riportati in rilievo i nomi di tutti i pescatori morti in
mare.
Ma il Lungomare di Porto Recanati avrà vita breve:
nemmeno quattro anni.

|
| |
Lo
scautismo a Porto Recanati: 35 anni di storia -
(II^parte)
- di Alberto Giattini
L'81 vedrà impegnati gli esploratori e le guide nel
Campo del Dipartimento dell'Alto Adriatico al Lago di Bolsena, mentre
nell'83 parteciperanno al 1° Campo Nazionale dell'Agesci al Lago di
Barrea che si verificherà denso di esperienze e di scambi di idee.
L'83 è anche l'anno in cui don Giancarlo Manieri dopo
13 anni di onorato servizio lascia per trasferirsi a Civitanova Marche,
avvicendato da don Giovanni Molinari.
Quelli che nel '77 erano dei giovani Capi su cui pochi
avrebbero scommesso, nell'85 si apprestano a festeggiare i 20 anni della
fondazione ripetendo la bella esperienza del Campo di Gruppo.
Destinazione Lago di Suviana, scelto dopo aver vagliato
varie possibilità, sull'Appenino Tosco-Emiliano. La presenza di una base
scout di un gruppo di Bologna e un posto in riva al lago già collaudato
da altri fanno propendere per questa scelta. I lupetti e le coccinelle si
insediano in una scuola a poca distanza, dove in una cucina e un
refettorio attrezzati sotto i tendoni Pina Zaccari con l'aiuto di due
ragazze poi "reclutate" (Lorella Babini e Donatella Mancinelli)
si destreggia tra i fornelli e i pentoloni con grande maestria. La cambusa
era garantita dai coniugi Allegrini che con tutti e tre i figli al Campo
non potevano fare diversamente che armare la roulotte e partire. La loro
dimora diventò anche "l’angolo del pianto"dei malati che
purtroppo, tra cento partecipanti non mancarono. Tra febbricole, un
attacco di appendicite fortunatamente non operato ed un frattura di gomito
ingessata, il bollettino sanitario fu molto vario.
Ma chi si distinse fu il vecchio pulmino FIAT 850
dell'Oratorio, che nonostante fosse ormai in via di rottamazione, resse
per tutto il Campo, anche se tentò pure il suicidio (cedette il freno a
mano e si sgranò la marcia mentre era parcheggiato in pendenza, andando a
finire sull'orlo di un baratro trattenuto solo dai rovi). Resse pure il
viaggio di ritorno stracarico di materiale. Eroico.
L'esperienza maturata fino a quegli anni portò alcuni
dei Capi ad assumere degli incarichi come quadri regionali e zonali. Nel
1985 Rosina Zaccari fu eletta dall'assemblea regionale dei Capi delle
Marche come Responsabile Regionale, altri erano impegnati nelle varie
"pattuglie" (commissioni) regionali: Gianfranco Antognini,
Teresa Zaccari e successivamente Amalia Crescenzi ed Aldo Sichetti.
Nel 1987 si realizza quello che per molte
"generazioni" di scouts e di guide è stato un sogno, il
Jamboree. Il termine viene da jam (marmellata in inglese) e boree (ragazzi
in un idioma sudafricano), voluto personalmente dal fondatore dello
scautismo, Lord Baden-Powell. Ebbene nel dicembre del 1987 Enrico
Torregiani e Rosina Zaccari come Capo, quali rappresentanti del
contingente italiano dell’Agesci, parteciparono al Jamboree in
Australia.
Chi ha vissuto tale esperienza riferisce che viverla da
ragazzo è molto più suggestivo, il mescolarsi di tante abitudini,
usanze, culture, cucine e quant’altro dà l’idea di quanto ci si possa
arricchire dallo scambio di informazioni, di idee e di esperienze, ma
soprattutto di quanto ci si senta limitati dal non parlare neanche un po’
una lingua straniera spesso vista come una mera materia scolastica.
Enrico confermò questa opinione, rispetto a Rosina che
partecipando da adulta, con il peso delle responsabilità era un po’
più legata agli aspetti organizzativi. La stessa interpretazione dello
scautismo evidenziava la diversità di cultura ma inevitabilmente l’omogeneità
di intenti. Dai giapponesi che effettuavano la cerimonia dell’alzabandiera
tutte le mattine con i guanti bianchi ai tahitiani che avevano l’uniforme
con il pareo, agli arabi che oltre all’immancabile turbante dell’uniforme
non rinunciavano ai loro momenti di preghiera, per finire alle cerimonie
religiose multiconfessionali. Per concludere, la calorosa ospitalità
degli italiani emigrati in Australia.
Quell’anno, fu caratterizzato dalle attività
internazionali (le uniche, fatta eccezione per l’ospitalità fatta ad un
gruppo di scouts francesi nel 1982), in quanto Amalia Crescenzi portò
alcune guide ad un Campo Nautico Europeo in Finlandia. Tra i ricordi
impressi nella mente delle ragazze, oltre alle stesse sensazioni citate da
chi ha partecipato al Jamboree, le lunghe giornate boreali di luglio
(circa 4 ore di buio) e la temperatura marmorea dell’acqua dell’estate
finlandese.
La storia del Gruppo Scout continua con altri eventi
determinati dalla voglia di impegno degli adulti e dalla voglia di
avventura dei ragazzi, che dal 1908 quando Baden-Powell decise di fare
questa proposta per la prima volta a dei giovani, non smette ancora di
esistere.
Altri momenti salienti si possono ricordare con il
Campo Invernale del 1992 a Sant’Elia (Fabriano) quando nevicò per 48
ore consecutive e tutti i partecipanti spalarono la neve con tutti gli
strumenti possibili per una intera mattinata per liberare il pulmino fino
alla strada e si tornò a casa nei tempi previsti solo per puro miracolo.
Nel 1993 i reparti maschile e femminile parteciparono
al Campo Nazionale nautico al Lago di Bracciano; sempre in quell’anno i
rovers effettuano una mitica Route (campo mobile) alle Cinque Terre,
massacrante il percorso a piedi in 4 giorni da Monterosso a Porto Venere
ma stupendo sotto il profilo paesaggistico e spirituale.
Il 1995 vide il Campo di Gruppo del 30° al Lago di
Bolsena, maturato dopo una lunga preparazione.
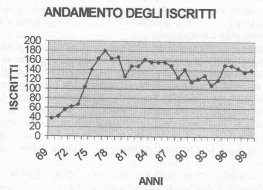 Il resto è storia recente, il cambiamento della
realtà giovanile e delle persone che hanno deciso di dedicarsi ai ragazzi
comporta inevitabilmente di dovere aggiustare ogni tanto il tiro,
modificando obiettivi e strategie ed a volte anche i mezzi. L’importante
è che si continui nel diffondere gli ideali di pace, di fratellanza e di
spiritualità pur nelle loro varie espressioni, considerando che fin dalle
origini lo scautismo ha avuto caratteristiche di universalità a livello
mondiale e tali valori hanno maggiore importanza oggi che il mondo è
entrato praticamente nelle nostre case, sia materialmente che
virtualmente. Il resto è storia recente, il cambiamento della
realtà giovanile e delle persone che hanno deciso di dedicarsi ai ragazzi
comporta inevitabilmente di dovere aggiustare ogni tanto il tiro,
modificando obiettivi e strategie ed a volte anche i mezzi. L’importante
è che si continui nel diffondere gli ideali di pace, di fratellanza e di
spiritualità pur nelle loro varie espressioni, considerando che fin dalle
origini lo scautismo ha avuto caratteristiche di universalità a livello
mondiale e tali valori hanno maggiore importanza oggi che il mondo è
entrato praticamente nelle nostre case, sia materialmente che
virtualmente.
Chi continua l’esperienza dello scautismo svolge
sicuramente opera meritoria, perché dedicare il proprio tempo libero ai
figli di altri, quando la società di oggi ci porta a sottrarne anche ai
nostri è sicuramente da elogiare.
Questa raccolta di ricordi un po’ personali, perché
di questo si tratta, è sicuramente parziale ed incompleta; il ruolo
svolto dalla realtà scout a Porto Recanati merita sicuramente una
maggiore attenzione, ed è per questo che chi scrive, con l’aiuto di chi
vorrà, intende raccogliere le testimonianze in un libro già avviato ma
che risulterebbe sicuramente incompleto se scritto a due mani, pur con i
27 anni (su 35 di storia) passati con il fazzolettone al collo.

|
| |
|
Cecco Bonanotte,
scultore
portorecanatese -
di
Nando Carotti
Tra i portorecanatesi che, residenti e non, hanno
meritato la stima dei concittadini per quello che sono e per quello che
fanno va annoverato Cecco Bonanotte, un artista che circostanze ed
esigenze di vita e di lavoro hanno tenuto lontano dal luogo d’origine
fin da quando era ragazzo.
Nato nel 1942 a Porto Recanati, infatti, già sedici
anni dopo frequentava a Roma i corsi di scultura dell’Accademia di Belle
Arti.. Erano anni, quelli intorno al ‘60, durante i quali nostri amici
carissimi e colleghi sia nella pratica artistica vera e propria che nella
docenza tentavano in ogni modo, peraltro non sempre riuscendovi, di far
accettare tecniche e stili d’avanguardia al nostro mondo provinciale
ancora piuttosto tradizionalistico; un mondo che capiva poco un linguaggio
che distava anni-luce dal classico e che continuava ad essere riservato
agli addetti ai lavori; linguaggio tanto più ostico quando si trattava
della scultura che, non beneficiando del colore, doveva trovare il tono
adatto alla penetrazione nelle menti e nei cuori di chi artista non era in
forme nuove sì, ma non inconcepibili e nell’armonia dinamica delle
composizioni.
Non so se Bonanotte abbia percorso quella strada
faticosa arrancando e soffrendo come tanti artisti che allora ben
conoscevo: a quei tempi non ne avevo mai visto le opere, ma adesso,
fidandomi un poco del senno di poi, credo di non essere lontano dal vero;
comunque ciò che scrivo è ciò che personalmente penso e deduco. Del
resto che il lavoro di Bonanotte sia stato interessante fin dall’inizio
è provato dai numerosi riconoscimenti, la borsa di studio, i premi, le
commissioni, la cattedra di "modellato" nella citata Accademia
ed al Liceo Artistico della Capitale, le importanti architetture e le
sculture sistemate in sedi e monumenti prestigiosi, dal Museo Casa Natale
di Michelangelo al Palazzo Madama, dal Vaticano al Giappone.
Da artista individuo nel dinamismo di figure e
figurazioni della sua scultura due elementi fondamentali ricorrenti: l’eleganza
plastica dei soggetti ridotti all’essenziale e la sofferenza. Il motivo,
che ho già definito ricorrente, è una sorta di tendenza all’infinito
espressa mediante voli, figurazioni aeree di non facile interpretazione ma
emotivamente invitanti a concepire la felicità umana nello sforzo
costante di infrangere vincoli naturali non più tollerabili ed
arrampicarsi fin là dove dovrebbe trovarsi la libertà. Si tratta, a mio
parere, di un motivo quasi ossessivo che diventa oggetto di ricerca di
forme espressive essendo ormai scontato il soggetto; è l’uomo che si
confronta con se stesso, sempre al cospetto di una specie di sole che non
è un sole ma un mondo, "il" mondo, l’universo talvolta
ingentilito dalla presenza di figure filiformi che di umano sembrano avere
soltanto una specie di linea riassuntiva non diversamente attribuibile ma
che non sono, come si usa dire, "ridotte all’osso" ma
essenziali. Ricorre il confronto uomo-uccello, forse l’aspirazione dell’Artista
a paragonare il desiderio dell’uomo con la reale libertà spaziale del
volatile, invidiabile quantunque limitata dal calore del sole cui, come
Icaro, non potrà nemmeno lui avvicinarsi mai, e dal vento, dalla
tempesta, dalla natura stessa di un corpo comunque troppo pesante, anche
quello dei "funamboli", per distaccarsi dalla terra.
A Porto Recanati Bonanotte sistema alcune delle sue
opere meno conosciute, quelle che non compaiono nei cataloghi ufficiali
che dell’Artista presentano i veri successi internazionali. Le porte
bronzee della chiesetta "del Suffragio", nella zona centrale del
corso Matteotti, sembrano, ma non lo sono, una prova per il portale della
basilica di San Paolo in Roma, una struttura che non può non colpire l’attenzione
del passante purché dotato di un minimo di spirito di osservazione e di
curiosità anche quando sia privo di cultura artistica. Così la scultura
che decora il centro della fontana di piazza Brancondi che, più delle
altre, ripete il motivo ricorrente già accennato del
"confronto", una sorta di firma depositata in pubblico dall’Artista
alla presenza di un monumento di grande valore storico qual è il Castello
Svevo. Così anche la decorazione dell’angolo della parete di fondo
della sala al piano terra dell’istituto bancario che, affacciandosi anch’esso
sul Corso, in pieno centro cittadino, costituisce un valido supporto per
una di quelle rappresentazioni aeree leggerissime, estremamente dinamiche,
che sembrano appartenere allo spirito dell’Artista senza riuscire,
tuttavia, a soddisfarlo. Più severa, adatta alla sacralità della
Cappella dedicata ai Caduti di tutte le guerre, quasi schematica, è l’opera
eseguita in omaggio al bisogno istintivo e tradizionale di inchinarsi al
sacrificio di uomini e donne quasi disarticolati, scheletriti, perché
così lo scultore simboleggia la rinuncia, l’offerta estrema, ed eleva
al cielo, cioè al massimo raggiungibile, quanto di più nobile esista
nella storia di un popolo. Infine la piccola "tavola", a nostro
giudizio di ottima fattura, apposta nella cappella funeraria della propria
famiglia: modeste le dimensioni, come si conviene in uno spazio ristretto
ove il decoro è dedica, non abbellimento né arricchimento, perché lo
spazio è e deve rimanere d’Altri; significativo il disegno sintesi del
"volo" ben più arduo cui l’Artista ha ispirato tante opere
più importanti; bronzeo il colore qua e là dorato, non incupito né
marcito come gli altri dal salmastro catturato dal vento.
In tutte queste opere c’è, a ben guardare senza
ignorare la contemporaneità di tutte le altre (contemporaneità intesa
naturalmente secondo il metro della storia dell’arte), di quelle
distribuite nel mondo, il tema fisso di Bonanotte che ne fa il soggetto
costante del proprio lavoro. Ci convinciamo, man mano che approfondiamo l’esame,
che Bonanotte non si distacchi mai dalla terra; né quando commemora, come
nel caso del famedio nel piccolo cimitero portorecanatese o nel portale
della chiesetta lungo il Corso, o quando decora, come nell’interno della
banca o al centro della fontana, o dedica, come nella cappella familiare.
Forse allora è consentito anche a noi il tentativo di
spiccare il volo: la ricorrenza dei motivi dominanti della scultura di
Cecco Bonanotte ci pare finisca per legare la sua città natale al resto
del mondo in una identità di pensiero che è significato e testimonianza
dello spirito dell’Artista. E vogliamo augurarci di avere visto giusto,
che il nostro non sia soltanto un fantasioso volo pindarico che, in ogni
caso, nulla toglierebbe alla validità dell’Artista.

|
| |
|
Album
del Porto
 Foto n°16. La busta paga di Giovanni Pierini,
impiegato della Montecatini, nel settembre 1948. Il documento ci viene
dal figlio Giovanni. Foto n°16. La busta paga di Giovanni Pierini,
impiegato della Montecatini, nel settembre 1948. Il documento ci viene
dal figlio Giovanni.
 Foto n°17. Clara
Riccetti e Franco Medori impegnati nella rivista musicale "La vera
felicità", rappresentata nel 1939. Foto fornita da Bruno
Benedetti. Foto n°17. Clara
Riccetti e Franco Medori impegnati nella rivista musicale "La vera
felicità", rappresentata nel 1939. Foto fornita da Bruno
Benedetti.
 Foto n°18.
Particolare
del portale in bronzo della chiesa del Suffragio a Porto Recanati, opera
di Cecco Bonanotte. Foto di Luciano Monarca. Foto n°18.
Particolare
del portale in bronzo della chiesa del Suffragio a Porto Recanati, opera
di Cecco Bonanotte. Foto di Luciano Monarca.
 Foto n°19. Un’istantanea
della torretta, capanno (ora abbattuto) per i bagni del vescovo
di Loreto lungo il litorale a nord dell’incasato urbano (provinciale
per Numana). Siamo negli anni Cinquanta. La foto è stata scattata dal
colonnello Giacomo Cantalamessa e l’abbiamo avuta dalla moglie
Giuseppina. Foto n°19. Un’istantanea
della torretta, capanno (ora abbattuto) per i bagni del vescovo
di Loreto lungo il litorale a nord dell’incasato urbano (provinciale
per Numana). Siamo negli anni Cinquanta. La foto è stata scattata dal
colonnello Giacomo Cantalamessa e l’abbiamo avuta dalla moglie
Giuseppina.
 Foto n°20. I quattro
fratelli Solazzi in partenza per l’Argentina dal porto di Genova, nel
1946. Sono, da sinistra a destra: Pasquale, Marino, Vincenzo e
Francesco. La foto è di proprietà di Vittorio Solazzi. Foto n°20. I quattro
fratelli Solazzi in partenza per l’Argentina dal porto di Genova, nel
1946. Sono, da sinistra a destra: Pasquale, Marino, Vincenzo e
Francesco. La foto è di proprietà di Vittorio Solazzi.
 Foto n°21. Quinto
Cavallari. La foto, di proprietà di Jole Fabbrizzi, risale
probabilmente al 1914-15. Foto n°21. Quinto
Cavallari. La foto, di proprietà di Jole Fabbrizzi, risale
probabilmente al 1914-15.

Foto n°22. La
carovana del Giro d’Italia del 1946 mentre transita in Corso
Matteotti. In basso la nota: "Guida il gruppo Conti".
 Foto n°23. Pietro
Alessandrini e il suo cane Bibì. Foto scattata a Pola il 12 ottobre
1942. Foto n°23. Pietro
Alessandrini e il suo cane Bibì. Foto scattata a Pola il 12 ottobre
1942.

|
| |
|
Monaldo
Leopardi Gonfaloniere e le sue idee riformatrici
-
di Franco
Foschi
Circa trenta anni fa cominciai a raccogliere i
documenti relativi all’attività di Monaldo Leopardi amministratore.
Quelli in particolare che sono conservati presso l’Archivio Storico del
Comune di Recanati, ma anche quelli che cortesemente la contessa Anna
Leopardi mi ha consentito di consultare e quelli che ho potuto reperire in
varii altri archivi pubblici e privati, fino a quelli che da ultimo è
venuto raccogliendo il CNSL, su aspetti diversi della complessa attività
di Monaldo.
Ho raccolto così un migliaio di manoscritti di
Monaldo, quasi tutti inediti e mai consultati da alcuno, specie per quanto
attiene ai periodi della Gestione del Comune.
Nel corso degli anni ho potuto studiare e pubblicare
alcuni carteggi che mi erano sembrati significativi, ma solo ora ho potuto
compiere uno spoglio delle carte relative agli anni tra il 1815-1826 e
qualche loro seguito.
Le lettere (le minute), le memorie, i pareri, le note,
gli avvisi, i manifesti, che mi sembrano degni di interesse e di
pubblicazione, sono almeno 500.
Nel corso di una breve relazione non posso che fare una
scelta esemplificativa di alcuni titoli indicativi delle idee e del lavoro
svolto da Monaldo in quegli anni, con non poche incomprensioni e
delusioni. Spero poi di poter pubblicare una raccolta dei documenti
originali degni di attenzione e - forse - capaci di far luce sulle ancora
generiche e stereotipate valutazioni sul Monaldo amministratore, che
ricorrono in tutti gli scritti - pur pregevoli per alcuni aspetti - dei
non molti che si sono occupati di questi argomenti senza però aver potuto
leggere i molti carteggi e manoscritti che - soli - possono consentire un
giudizio più equilibrato.
Subito dopo la sconfitta di Murat (3 maggio 1815), la
S.Sede inviò Mons. Tommaso Bernetti, come Delegato, per riprendere
possesso delle Provincie recuperate, ma per mancanza di ordini dalla Corte
di Vienna dové lungamente fermarsi a Tolentino.
Di lì mandò a chiamare Monaldo Leopardi, che non
conosceva. Ma gli aveva parlato di lui Carlo Antici. Con lettera del 9
maggio gli affidò il Governo Provvisorio della sua patria, con il titolo
di vice-Gerente, dandogli ampi poteri, ma pregandolo di tenere riservato l’incarico
fino alla nomina ufficiale del Delegato Apostolico per la Marca maceratese,
fermana e ascolana. Da una nota di Monaldo si rileva che in realtà la
lettera è del 23 maggio. Monaldo, che non aveva voluto accettare l’incarico
conferitogli in precedenza dal Governo Provvisorio Austriaco, prese atto
della nomina. Ma Mons. Bernetti già l’8 di luglio era stato sostituito
da Mons. Tiberi, che il 25 nominò Monaldo come membro della Congregazione
Governativa di Macerata.
Appena un mese dopo il nostro Conte presentò le
dimissioni al Segretario di Stato Card. Consalvi, adducendo ragioni di
famiglia e di salute. Ma intanto allegava una memoria:
1. Mons. Delegato non sembra penetrato dallo
spirito di perdono, di conciliazione e di pace che saggiamente ispira
il Governo.
Aver servito i passati governi è agli occhi suoi
un delitto imperdonabile (inespiabile) e parla pubblicamente di tutti
gli impiegati come di persone infami. Rispetta come un quinto
Evangelio un libro datogli da qualche imprudente [...] Questa condotta
aliena gli animi e [...] Per solo delitto di opinione ha risolutamente
dimesso molti giudici di pace, Cancellieri e Segretari Comunali.
2. Il Delegato non è persuaso di dover lasciare
provvisoriamente l’attuale impianto. Ma detesta tutti i funzionari
di Prefettura, sostituendoli con uomini inabili. Il dimettere in
questi momenti gli attuali capi di ufficio equivale allo spegnere il
lume nel più buio della notte.
3. Manca di ogni esperienza, di cognizioni e di
talenti governativi. Si occupa di affari meschini e inconcludenti e
manca di direzione e di sistema.
4. Non conosce i limiti delle sue competenze.
Con una lettera del 6 settembre il Card. Consalvi
respinse le dimissioni di Monaldo. Ma l’11 settembre Monaldo tornò a
scrivere per ribadire le sue preoccupazioni: «in un mese di
amministrazione debole, inetta, sconnessa, si è rovinata l’opera di
dieci secoli».
Il 13 ottobre poi, comunica che gli avvertimenti della
Segreteria di Stato sono stati ignorati da Mons. Tiberi, persuaso solo
della propria infallibilità. Così si è acquistato la contrarietà e il
disprezzo di tutta la provincia.
Intanto «la provincia è ridotta a una selva
formicolante di ladri e di assassini. Le stesse strade postali sono
intransitabili dopo il tramonto del sole e ogni mattina si geme sui
disordini accaduti la notte». Il 28 ottobre Monaldo confermò le
dimissioni, sperando che «non vorrà condannarmi a comparire più
lungamente il complice delle sue stravaganze (di Mons. Tiberi)».
Finalmente, l’8 di novembre il Card. Consalvi accettò le dimissioni,
lasciando intendere un nuovo incarico. Prese buona nota delle proposte
allegate cui poi non dette seguito, o almeno così sembrava.
Delle proposte di riforma, mi limiterò solo a dare un
elenco (più completo di quello che fu pubblicato nel 1940 da Massimo
Petrocchi)
Per la costituzione degli Atti dello Stato
Civile.
Sulla carcerazione per causa civile («Il Debito
non è un delitto e il debitore non deve trattarsi come uno
scellerato»)
Sul pignoramento dei mobili
Sulla citazione ovvero esecuzione personale
(contro la pratica ‘barbara’ dell’usura e senza precetto di
pignoramento).
Domicilio da eleggersi del creditore committente
una esecuzione.
Corti di appello.
Amministrazioni delle comuni.
Tabacco.
Cancellieri del Censo e Conservatori dei Catasti.
Si tratta di innovazioni che - tutte - presto o tardi
furono in seguito introdotte nel nuovo ordinamento. In questo clima, il 14
novembre 1816 Monaldo fu nominato Gonfaloniere la prima volta
chiamato dal voto dei miei concittadini e dalla
Sanzione Sovrana alla rappresentanza di questa mia Patria avvegnaché
sconfortato dalla infelicità de’ tempi e dalla scarsezza delle mie
forze, ho accettato l’ufficio conferitomi di Gonfaloniere persuaso
che al Principe ed alla Patria si deve quanto si ha [...] è mio primo
dovere il recarmi personalmente a fare omaggio all’E.V.R. […] ed a
raccomandarLe questa Comune che […] merita i Superiori riguardi, e
che li esige per le sventurate combinazioni alle quali è sottoposta.
Permettendomi però qualche giorno di ritardo per prendere una qualche
tintura dei Pubblici affari onde coll’E.V.R. conferire
opportunamente, premetto quest’atto di ossequioso e divoto rispetto
[...]
14 9bre [novembre] 1816
Monaldo Leopardi Gonf.
Il primo intervento del Gonfaloniere appena eletto fu
la liberazione dei pescatori fatti schiavi, dei quali scrissi nel 1978
Erano originariamente ben cinquantacinque e tra essi alcuni bambini di
sei-otto anni. Quindici morirono in schiavitù. Ecco una lettera di
Monaldo del 26 di novembre 1816 al Delegato Apostolico:
i nativi di Porto di Recanati reduci dalla
schiavitù di Algeri e di Tripoli in numero di 39 e le vedove e gli
orfani di altri 14 infelici morti nella schiavitù, gementi tutti
nella più desolante miseria, reclamano in nome della umanità la
beneficenza del governo. Privi di qualunque sostanza e solamente
capaci di guadagnarsi il pane col mestiere di pescatori, sono
attualmente condannati all’ozio e per la stagione non propizia al
loro mestiere e perché i Padroni di Barca sono attualmente provveduti
di marinai e principalmente perché perdettero insieme colla libertà
tutto il proprio capitale consistente in molti cappotti indispensabili
in una professione che li espone dì e notte a tutte le intemperie
dell’aria. Spinti pertanto dalla fame, vanno errando per le
campagne, si pascono di ghiande e di radiche e invocano quella
schiavitù che li teneva almeno un passo più lontano dalla morte.
Un soccorso di dieci o dodici scudi per famiglia,
ravviverebbe in qualche modo la loro speranza e sarebbe di piccolo
aggravio al governo che se non potrà garantirli dal sommo dei mali,
vorrà almeno generosamente accorrere a mitigarne le orribili
conseguenze
In data 20 gennaio 1817 il Gonfaloniere scrive al
Cardinal Albani in Roma:
Ho procurato di alleviare momentaneamente i loro
mali, ma un soccorso capace di liberarneli non è nelle mie forze né
in quelle della comune da me rappresentata. Inoltre, io credo che la
schiavitù non possa riguardarsi come una calamità privata
equiparabile all’incendio e alla grandine, ma che nascendo dallo
stato di guerra in cui si trova il governo colle potenze infedeli,
abbia il governo stesso un maggior titolo per sollevare quei miseri
che ne furono disgraziatamente le vittime.
Supplico pertanto umilmente l’Em. Vostra Rev.ma a
degnarsi di accordare a questi infelici uno straordinario sussidio con
cui possano almeno rivestirsi e riassumere il proprio faticoso
mestiere.
Conviene - risponde il Card. Albani - che la
Congregazione locale esamini, proponga e trovi i mezzi per sollevare
gli schiavi liberati, che debbono considerarsi come gli altri poveri.
Ma - aggiunge - avendo quelli l’industria della pesca debbono in
essa ancora occuparsi, né possono pretendere di essere mantenuti come
gli inabili che hanno bisogno di particolare soccorso e di lavoro
adatto alla loro situazione. Serva a Lei ciò di governo per animare
codesta congregazione ad aver presenti anche gli individui su nominati
e con parzialità di stima resto di V.S. Ill.ma servitore [...]
Non pare si possa ignorare che Monaldo provvede
silenziosamente di sua tasca come può e che nel contempo afferma due
concetti tutt’altro che pacifici al suo tempo (e in gran parte ancora
del nostro). Infatti l’idea che a chi è in condizioni di bisogno
occorre dare ciò che serve per liberarlo e ricondurlo alla parità con
gli altri, è concetto moderno contro le beneficenze che cronicizzano il
bisogno.
Coerente con tale impostazione e ancor più
significativo in termini politici è il concetto di dipendenza della
schiavitù da motivazioni generali di rapporti tra gli Stati, con
conseguente dovere di intervento del Governo per una calamità che non
può considerarsi come un fatto privato. In realtà era invece tuttora
invalso l’uso di considerare la cattura come una disgrazia privata. In
precedenza (1600) era addirittura considerata come la conseguenza della
imprudenza dei pescatori che uscivano in mare malgrado preavvertiti del
rischio delle vedette.
Altro episodio significativo è la risposta data da
Monaldo nel 1816 ai medici condotti:
Sul ricorso avanzato alla Sacra Congregazione del
Buon Governo dai medici condotti nella provincia della Marca, diretto
ad ottenere l’esenzione dalle tasse comunitative del focatico e
della guardia urbana, osservo primieramente che il principio su cui i
Sig.ri medici appoggiano il loro reclamo è falso e sarebbe produttore
di inammissibili assurdi. Se il medico non dovesse considerarsi come
cittadino del luogo in cui esercita la sua professione e quindi non
dovesse concorrere in modo alcuno a sostenere la sua parte dei pesi
comuni, ne seguirebbe che il medico non fosse cittadino di nessun
paese e che, solo in tutta la società, potesse rendersi estraneo alla
medesima ed anzi, privilegiato sopra l’ordine naturale, godesse
tutti i vantaggi sociali senza contribuire menomamente a procurarli
(Recanati, 5 dicembre 1816)
Era tempo di carestia, di fame e disoccupazione.
Il 23 dicembre1816 il Gonfaloniere chiedeva al Deputato
alle provviste per la Congregazione di Pubblica Beneficienza, conte
Benedetto Carradori (suo cugino), di voler provvedere con la più grande
sollecitudine cinquemila libbre di canapa greggia e duecento libbre di
lino rossetto greggio.
Con lettera del 13 Monaldo informava il Governatore di
aver anche provveduto qualche quantità di lenticchie per i poveri vecchi
ed inabili.
È interessante rilevare come il Gonfaloniere
considerasse preferibile questo metodo, piuttosto che quello di mandare a
ritirare la zuppa a distanza; i poveri preferiscono cuocersi le lenticchie
nelle loro case - dice - e poi ciò diminuisce la pubblicità, il tumulto
e i reclami di quelli che non hanno titolo ad essere sussidiati.
Inoltre annunciava di aver ordinato la perizia per i
lavori della strada convenuta, che sarebbe stata fatta compatibilmente con
la stagione e i mezzi disponibili.
Continuava intanto il gonfaloniere di Recanati ad
impartire disposizioni per la filatura della canapa.
Al parroco di Castelnuovo raccomandava che il filo
fosse molto fino, perché la tela potesse vendersi meglio, che il prezzo
si tenesse basso, perché non insorgessero monopoli, che non fosse
maggiore di sette baiocchi la libbra per il filato migliore e 4 baiocchi
per le stoffe. Poi si sarebbe distribuito il filato riconsegnato alle
tessitrici.
La sintesi più chiara del metodo seguito è però
contenuta nella seguente lettera con cui il Conte Monaldo Leopardi, in
data 20 gennaio 1817, ragguagliava il Gonfaloniere di Fermo che gliene
aveva fatto richiesta.
Al S. Gonfal. di Fermo
20 del 1817, Recanati
[…] mi sono limitato al minimo possibile nella
distribuzione dei gratuiti soccorsi e ho calcolato che sia assai più
provvido il fornire al popolo un più abbondante lavoro, onde possa
senza pubblico aggravio e senza timento di inerzia provvedere ai
propri bisogni.
1. Fondo di opere e sussidio […]
2. Sussidio gratuito […]
3. Lavoro alle donne […]
4. Lavoro agli uomini […]
Cercando lavoro per alleviare le condizioni dei poveri,
il Gonfaloniere inviò il 24 gennaio una lunga lettera all’intendente
dell’appannaggio del Principe Eugenio, in Recanati, perché si
compiacesse di ordinare «un qualche grandioso lavoro urbano o
campestre». Proseguiva poi: «comprendo che gli affitti vigenti esimono
gli intendenti del Principe dall’accudire alla coltivazione dei suoi
latifondi, ma sono anche persuaso [...]» e suggeriva così la costruzione
di nuove case rurali, la escavazione di pozzi, una gran piantagione di
alberi, l’apertura di qualche nuova strada vicinale.
Qualche giorno dopo, il 25 gennaio, Monaldo fu
costretto a scrivere allo stesso Governatore, lamentandosi che gli avesse
inviato alcuni contadini perché li provvedesse di grano.
Forse hanno abusato del Suo nome - diceva - ma
certo è che mai è mancato il grano in piazza, che anche al mercato
di questo stesso giorno se ne vendeva; che i forni sono ben forniti,
che i contadini vogliono avere il grano a buon prezzo e non a prezzo
commerciale; ma - concludeva - bisogna essere forti contro le prime
lagnanze, perché il popolo non si creda in diritto di esser
provveduto a suo modo.
Intanto, nel breve lasso di un mese, nell’ultimo
scorcio del 1816, il nuovo Gonfaloniere si era occupato intensamente, come
poi fece sempre, delle varie materie dell’attività quotidiana,
scrivendo personalmente ogni nota.
Scrisse il regolamento orario per i «Servitori del
Pubblico».
Non mancò, naturalmente, di mobilitare tutti sulla
questione annosa della classificazione della Città di Recanati come capo
distretto. Scrisse a Mons. Rivarola, protettore della Città, al
Gonfaloniere di Fermo, perché in nome dell’antica amicizia intervenisse
su Roma, al vescovo di Urbania Leonini, al marchese Girolamo Melchiorri e
a Carlo Antici in Roma.
Intanto, poiché cresceva la miseria e la
disoccupazione, scrisse al Gonfaloniere di Ancona, Clemente Ferrari (2
dic. 1816). Questi aveva avuto l’appalto delle forniture alle truppe e
Monaldo sperava di avere parte delle commesse (camicie e scarpe, ma il
Ferrari forniva i viveri e non il vestiario, che invece era assegnato a
Cesare Mancinelli di Ancona, su decisione di Roma). Scrisse quindi al
Marchese Melchiorri a Roma, perché non si desse pace finché non avesse
ottenuto un contratto subalterno.
Se non si fosse potuto con le forniture militari, si
rivolgesse agli ospedali, per assicurare la vendita di 10 o 20.000 braccia
di tela casareccia. E inviò campioni di tele e prezzi.
Supplicò il Delegato Apostolico di consentire la
somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, (informando che la
faceva chiedendo i rimborsi).
Regolò la vendita del pane e del vino al Porto.
Infine Monaldo avviò col 1816 un rapporto annuale
ragionato sul quadro territoriale dei prodotti e dei consumi nella Città
di Recanati, che meriterebbe da solo di essere adeguatamente commentato,
come fonte di documentazione preziosa che non era concepita come semplice
adempimento a formali quesiti, ma come moderna rilevazione sulle tendenze
evolutive delle attività produttive e dei cambiamenti in atto. Monaldo,
sempre rigoroso nel metodo, ironicamente notava di invidiare
quelle Comuni che hanno saputo evadere i superiori
quesiti, senza esporre un calcolo cabalistico e privo di ogni base e
verità di cui il rispetto che professo alle Autorità Superiori e il
mio attaccamento al Governo non saprebbero farmi capace
Nel 1817 assunse una interessante iniziativa,
proponendo a molti Gonfalonieri di tutto lo Stato di firmare una petizione
perché le disposizioni governative venissero inviate in copia non solo ai
Governatori, ma anche ai Gonfalonieri, ad evitare che essi dovessero
mescolarsi con la folla per leggerle sui muri.
La motivazione più vera si trova in una sua lettera
del 10 marzo (1817) al Gonfaloniere di Macerata. Vale la pena di leggerne
un brano:
è assurdo che un corpo abbia due capi e questo
mostro partorirà sempre effetti perniciosi. Io poi sono intimamente
persuaso che l’Emin.mo Segretario di Stato sia di questo medesimo
sentimento e che abbia solo temporaneamente ceduto al sentimento dei
vecchi cardinali, che vogliono i Governatori come vogliono i
Parrucconi di cui ella è così ragionevolmente scontenta. Qua non si
porta più di Rubboni né di Perucche ed io rinunzierei l’ufficio
prima che espormi in quel buffo corredo alle risa dei miei
concittadini. Se tutto soggiace a riforma e tutto al mondo è caduco,
ai soli Perucconi si vorrà accordata l’immortalità?
Malgrado le legittime speranze, la polizia fece sapere
a Monaldo Leopardi che l’iniziativa non era gradita ed egli dovette
sospendere la trasmissione dell’istanza, nella lusinga che comunque
ormai il governo conosceva i desideri dei Comuni e che presto o tardi li
avrebbe esauditi; non così per la abolizione dei Governatori, che anzi da
loro ebbe non pochi guai.
Nel 1817 Monaldo rilanciò la vaccinazione:
questa provida e felicissima instituzione va
giornalmente perdendo nella opinione del popolo, perché in verità i
sintomi e gli effetti della inoculazione vaccina non sono più tanto
innocenti e miti come lo erano nei primi anni in cui venne adottata.
Io stesso, che primo in tutto lo stato Pontificio, feci inoculare il
vaccino ai miei figli nel 1801, ho verificato l’esacerbamento
graduato dei suoi effetti, sperimentandosi ben diversi negli altri
figli che vi ho successivamente sottoposti, a segno che temerei di
esporvene un altro. Io sospetto che questa dispiacevole varietà possa
dedursi dal non venire il pus desunto ogni anno originalmente dalle
vacche, ma passato già per molti anni dall’uomo all’uomo,
tantoché essendosi a quest’ora soverchiamente umanizzato [...]
Non starò a ripetere ciò che ho scritto tanti anni
fa. Sottolineo però ancora la modernità della metodologia e certe
attenzioni a bambini poveri e delle zone rurali, nonché le multe a chi si
sottraeva senza motivo.
Il 24 marzo 1817, con circolare della delegazione
apostolica di Macerata ai signori Governatori, C. Nembrini metteva in
guardia dal rischio che la carestia si abbinasse con le malattie
epidemiche.
Si istituiva anche una commissione provinciale. Di essa
facevano parte il Gonfaloniere, il primo medico e il chirurgo. In aprile
la commissione fu costituita in Recanati.
Il 7 maggio il Gonfaloniere richiamava i medici all’obbligo
di riferire due volte la settimana, e più esattamente il martedì e il
venerdì, sui casi di malattia, dal momento che in provincia già
serpeggiava il morbo petecchiale.
E purtroppo il morbo esplose anche in Recanati, più
esattamente al Porto, il 10 di maggio.
In dettaglio ho documentato altrove l’andamento di
questa epidemia e le misure adottate dal Gonfaloniere col risultato che a
Recanati negli anni 1816-18 non aumentò la mortalità, malgrado il tifo
petecchiale e la fame.
L’epidemia non cessò completamente nel 1817. Il 26
febbraio 1818 il Gonfaloniere aveva comunicato che
il morbo epidemico petecchiale torna ad assumere la
propria ferocia a danno degli abitanti del Porto [...], la di cui
permanente miseria li sottopone a contrarlo e diffonderlo,
rapidamente. Quella popolazione composta di oltre duemila individui,
privi tutti di ogni mezzo di sussistenza, sarà fra poco distrutta ove
non venga prontamente e solidamente soccorsa.
E continuava chiedendo sovvenzioni per mantenere aperto
l’ospedale dei contagiosi e separare gli infetti, poiché «è fermo
parere dei medici che la nervosa dominante tuttora in questo posto
degenererà in febbre decisa pestilenziale e attenterà la salute di tutta
l’intera provincia».
Vi fu anche un tentativo di creare occasioni di lavoro.
Ne trovo testimonianza in una lettera del 20 aprile, diretta dal
Gonfaloniere al delegato amministrativo del Porto. Da essa si apprende che
si era colà recato in visita il direttore di polizia Guido Mattioli, il
quale aveva preso in considerazione l’ipotesi che il governo provvedesse
e sostenesse barche da pesca. Ma Monaldo dubitava che ciò si potesse
verificare e ipotizzava in alternativa qualche fabbrica stabile e adatta
ai mezzi e alle capacità del popolo. Di fatto non si attuò né l’una
né l’altra iniziativa. Purtroppo il governo non inviò neppure i
promessi modesti sussidi per le minestre e con la metà di maggio il
Gonfaloniere fu costretto a disporre la sospensione sia della
concentrazione in ospedale dei malati sia della somministrazione delle
minestre.
Decise però di continuare nella somministrazione
gratuita dei medicinali. Per fortuna intanto i casi erano diventati meno
numerosi. Ma neanche per i medicinali il governo - che aveva inizialmente
autorizzato - mantenne la parola e non un baiocco fu rimborsato; i
farmacisti al dicembre dell’anno 1818 erano ancora in attesa di ricevere
i primi pagamenti, dopo 8 mesi.
Altra preoccupazione dominante del Gonfaloniere fu
quella delle scuole e della Cultura.
Nella lettera a Carlo Antici, scritta il 2 gennaio
1817, Monaldo scrive:
A togliere questo paese dall’ultimo abbrutimento
conviene assolutamente pensare a rianimare alquanto gli studi,
giacché la cultura delle scienze e delle arti è misura della
moralità e della prosperità sociale. Da Visconti saprete i passi che
ho dati per ottenere i gesuiti e potete farvi comunicare più di
quanto sappia io stesso.
Poco spero di averli e nella mancanza di essi
conviene che provveda il paese, giacché quello che non faremo da noi
nessuno farà per noi. Fra le scuole dunque che abbiamo e quelle da
aggiungere vorrei che qui fossero le seguenti:
1 - alfabeto.
2 - calligrafia.
3 - aritmetica.
4 - grammatica.
5 - retorica.
6 - filosofia.
7 - diritto civile.
8 - medicina.
9 - chirurgia.
10 - ostetricia.
Seguiterò attentamente nella analisi dei miei
castelli in aria. […]
Tutta questa spesa non ammonterebbe a più che
annui 448 scudi cioè meno di quello che Macerata domandava da noi
[per ripristinare l’Università] e meno della metà di quanto si
proponeva di carpirci in seguito. Vorrei che il governo ci donasse o
cedesse in enfiteusi il convento di S. Agostino, nel quale vorrei
raccogliere tutte le scuole e principiarvi un gabinetto fisico e un
piccolo orto botanico e adattarvi camere anatomiche e a poco a poco
praticarvi quanto facesse al caso.
Scrive tra l’altro in data 13.1.1818:
In ordine al mio progetto per attivare e
resuscitare in qualche modo l’amore e la cultura delle scienze in
questa città, tornerò in seguito e vi spedirò un piano più
dettagliato
La questione fu ripresa negli anni 1823-25. Una lettera
di Carlo Antici del 17.7.1825 metteva il suggello alla questione, con una
raccomandazione quasi profetica: che vengano depositati nell’Archivio
comunale tutti i carteggi, i promemoria, i documenti comprovanti il grande
lavoro svolto da Monaldo, perché, se i contemporanei non lo capiscono,
almeno i posteri ne prendano atto.
Non si creda che fossero solo queste le iniziative del
Gonfaloniere.
Nel 1817-18 dette avvio alla costruzione del nuovo
cimitero e per questo cercò dapprima uno spazio nell’orto dei
Passionisti, essendo allora il Convento restato deserto.
Per far fronte alle spese attivò provvisoriamente
un dazio comunale sulla pesa e consumazione delle farine di grano e
frumentone.
Cominciò nel 1817 la annosa pratica per ottenere
che i Gesuiti tornassero a Recanati.
Stilò il regolamento per il Bollo di garanzia nei
pesi e nelle misure, bilance e statere.
Regolò vecchie pendenze per il molino a grano
detto dei Massari.
Chiese la collocazione di una brigata di 8
Carabinieri a piedi e di 8 a cavallo.
Avviò il nuovo censimento della popolazione e i
nuovi registri di Stato civile.
Fece approvare un progetto di ripresa della
costruzione dei Carri e vetture.
Portò all’approvazione del Consiglio una tassa
straordinaria di 10 bajocchi ogni 100 scudi di estimo catastale, per
provvedere al restauro della strada per Osimo e Ancona e per dare
lavoro a una "immensità" di operai e combattere la fame.
Creò un movimento tra tutti i Comuni perché lo
Stato restituisse ad essi una rata Prediale del 1815, pretesa dagli
austriaci.
Riordinò il dazio sul bestiame.
Costrinse il Delegato Apostolico a vietare che a
coloro che non potevano pagare la tassa del focatico venissero
pignorate e portate via le porte di casa.
Provvide a che gli abitanti del Porto non pagassero
due volte il dazio sulle carni.
Estese a tutti i comuni l’azione per evitare che
Macerata procedesse nella apertura di una Università a spese di tutta
la provincia.
Dovette lungamente combattere per il tentativo di
sottrarre il Castello e il territorio di Montefiore al territorio di
Recanati (1818-22). Partendo dal ridicolo errore di considerare
Montefiore come Comune, nella tabella di distrettualizzazione del
1816, esso veniva aggregato a Montefano. Ne derivarono danni economici
notevoli, nel riporto dei proventi e questo si ripercosse però fino
al 1822 sui bilanci comunali.
Nel 1818 abolì il dazio comunale sui Posteggi e
Scarichi e moderò il dazio sul bollo dei pesi e misure.
Regolamentò la professione dei raccoglitori di
ferri, metalli vecchi e stracci.
Malgrado l’ottimo lavoro svolto, alla fine del
mandato nel 1819, la nuova amministrazione approvò, senza aver sentito
Monaldo, un conto da cui sarebbe risultato un netto disavanzo. Monaldo
preparò una nuova memoria dalla quale risulta in dettaglio un largo
avanzo di amministrazione. Ma il nuovo Gonfaloniere Politi, si dimise
rapidamente e la relazione restò nel cassetto.
Il Conte non rinunciò tuttavia ad inviare una nuova
memoria al Card. Albani, Prefetto della Sacra Congregazione del Buon
Governo.
Infine molte energie Monaldo dedicò a partire dal 1816
alla annosa questione dei primi tentativi di distacco del Porto di
Recanati. Su questo problema tornerò brevemente alla fine.
Al termine del mandato fece un nobile manifesto di
saluto:
Il Gonfaloniere
Devo gratitudine, e onorevole testimonianza a tutti
gli Impiegati Municipali, i quali con abilità, con onore, e con zelo
hanno costantemente corrisposto ai rispettivi doveri, e mi hanno
secondato utilmente nel disimpegno dei pubblici affari. Devo stima
riconoscenza ed affetti a tutti i Cittadini di ogni ceto e di ogni
ordine, perché sempre conformi a se stessi, hanno osservate le leggi,
mantenuta la tranquillità, rispettata la Rappresentanza, e compatita
amorevolmente l’imperizia del Magistrato. […] Ho cercato di
deporre religiosamente ogni riguardo ed interesse privato, di
considerarmi Padre, e Fratello di tutti questi Abitanti, di prestarmi
all’utile e al desiderio di tutti, di conciliarne gli animi, e di
tutelarne i diritti. Ho procurato di sostenere le ragioni della Patria
[…]. Ho atteso a mantenere in credito e in equilibrio la finanza del
pubblico, spendendone il denaro senza profusione, e risparmiandolo
senza viltà. […] Ho abborrito le vie del rigore, e resa la forza
insensibile […] avrei voluto insomma che la mia Amministrazione
Tutoria e Paterna concorresse al vantaggio e alla soddisfazione di
tutti, ma pur troppo mi sento lontano dall’avere raggiunto il mio
scopo.
Nel 1820 fu finalmente chiesto a Monaldo di tornare ad
assumere l’incarico di Gonfaloniere, ma egli rinunciò o fu indotto a
rinunciare. Fu invece di nuovo eletto nel 1823 e restò in carica fino all’inizio
del 1826 (biennio 1824-25). Furono anni meno drammatici per certi aspetti.
Monaldo si dedicò con lo stesso metodo all’ammodernamento dell’amministrazione
e della città. Ma il suo lavoro era costantemente turbato da un lato per
l’angoscia dei persistenti tentativi di smembrare il territorio di
Recanati e dall’altro lato dalla ricerca di nuove ragioni di vita per la
popolazione. Ricerca contrastata da molti.
Tra i molti temi affrontati in questo periodo
ricorderò solo:
la realizzazione della nuova illuminazione
notturna della città e il suo appalto, anche a garanzia dell’ordine
pubblico e della sicurezza della popolazione;
la definizione di antiche pendenze sulla
privativa per il sale, la nuova regolamentazione per il suo appalto
e i criteri di fissazione dei prezzi;
il rilancio della vaccinazione contro il vaiolo;
la grande lungimiranza con cui provvide a coprire
le condotte mediche, con concorsi che portarono tra l’altro alla
nomina di Francesco Puccinotti che poi fu eletto professore di
Patologia Medica a Macerata e che divenne celebrato docente a
Bologna e a Siena e fondatore della Medicina sociale moderna, oltre
che amico di Giacomo Leopardi. Bisogna dire ancora che Monaldo non
aveva rinunciato al vecchio disegno di una università e quindi
pensava a medici che avessero anche ruolo di insegnamento;
la rilevazione razionale dello stato della
popolazione (16431 al 30 maggio 1823);
il quadro statistico annuale dei prodotti
territoriali;
il regolamento per il Monte di Pietà e certi
particolari accorgimenti perché gli oggetti di valore storico non
andassero dispersi. Prevedeva tra l’altro la riduzione del premio
percepito dal Monte dal 6 al 2 per cento;
il nuovo regolamento per il dazio sul mosto e il
vino imbottato, ivi compresa la nuova misurazione delle botti;
avendo ottenuto un aumento di altre rendite
comunali, per l’anno 1825 i cittadini furono sollevatati dalla
tassa del focatico (definita in qualche modo arbitraria, giacché
non potendo percuotere nessuna proprietà censita dipende dall’opinione
in cui sta la dovizia dei contribuenti, opinione che non di rado è
fallace e quindi cagiona scontentezza e lamenti. Anche per questo
Monaldo promosse una riforma del sistema);
il regolamento per il dazio dell’affida (o
conta-assegna) del bestiame;
il regolamento per la Chiesa di S. Vito, le
Congregazioni in essa funzionanti, le Confraternite, le Processioni
del Venerdì Santo e di S. Vito;
la rinnovata richiesta al generale degli
Agostiniani per riaprire lo studio e il Convento di Recanati;
lo scambio continuo di corrispondenza,
informazioni, consigli, proposte, con i Gonfalonieri delle Marche e
di altre regioni;
le lettere e delegazioni inviate per la elezione
di Papa Leone XII (1823)
la costruzione del faro del Porto per i
pescatori.
In mezzo ad argomenti di grande rilievo, Monaldo non
mancò di interessarsi di argomenti di costume, pur importanti dal punto
di vista sociale. Citerò per tutti la simpatica nota relativa al lusso e
ai regali tra i fidanzati, che erano regali di discreto valore come
fazzoletti ricamati, zinali, coralli, anelli, corone, di 20-30 scudi.
Quando si rompeva il fidanzamento nascevano gravi dissapori. Le cose
valevano di meno e i giovanotti volevano la restituzione in denaro. Ne
nascevano dissidi, cause e fatti di sangue. Monaldo proponeva una legge
secondo cui i doni fatti dal fidanzato non dovessero restituirsi o lo
dovessero solo in natura.
Per il funzionamento dei Consigli Comunali Monaldo nel
1823 rilanciò la multa di 3 scudi per gli assenti ingiustificati, che gli
era stato già concesso di applicare dal 1816 al 1818. Inoltre ripristinò
l’uso di indire consigli almeno tre giorni prima e di esporre in
Segreteria le proposte perché venissero consultate preventivamente da
tutti. L’anziano (Girolamo Melchiorri) ricorse e la Delegazione
Apostolica ostacolò duramente la prassi adottata da Monaldo. E lui
ricorse al Segretario di Stato (4 agosto 1823) dicendo che non riconosceva
alla Delegazione Apostolica il potere di fare leggi e molto meno di farne
solo per lui, con lettera singolare e su istanza di un solo cittadino
scontento.
Si occupò pure della raccolta e trasmissione delle
mercuriali.
Regolò la macellazione del bestiame, la vendita delle
carni e dei pesci, l’igiene e la profilassi veterinaria, la lotta alle
epizoozie e alle interiora bovine.
Naturalmente connesso ai consumi era il dazio sulle
carni, la questione del "quinto quarto" e delle parti escluse
dal dazio.
Analogo problema che regolò è quello del carniccio
delle pelli (per la colla dei pittori) della segatura delle botteghe dei
calzolai (per ingrasso degli ulivi), dell’ugnola (unghie e altre
frattaglie non commestibili delle bestie) che si vendeva alla fiera di
Senigallia, o in Romagna per ingrasso dei canapeti, dei ritagli o segatura
dei corni per i pettini, sempre per concime.
Ancora si occupò del dazio sui bachi da seta.
In certe memorie dettagliate, si trova l’interesse a
nuovi modi di produzione ad es. sul modo di fermentazione del vino.
Il naufragio di 2 paranze del Porto il 20 maggio 1823
dette luogo all’annegamento di 13 marinai e risollevò la questione
della miseria generale dei pescatori, cui Monaldo cercò di dare aiuto.
I rapporti politici che il Gonfaloniere stilava
personalmente sarebbero fonte di numerose notizie e altrettante proposte
di innovazione.
Un rapporto alla Deleg. Apostolica è dedicato (10 nov.
1824) alla conciliazione delle liti come "ufficio di carità proprio
di ogni uomo da bene. Se non venne mai interdetto a un galantuomo privato,
non potrà interdirsi a un magistrato e rappresentante del popolo, che
anzi dovrà lodarsi quando procura di evitare litigi tra i suoi
amministratori". In risposta alle "censure" rivoltegli
scriveva:
questa magistratura non ha mai preteso di erigersi
a Tribunale e conosce bene che il proferir giudizio e sentenze sulle
cause spetta alla Autorità giudiziaria, ma non perciò è vietato al
Magistrato il procurare di conciliare amichevolmentele questioni che
insorgono tra i cittadini
Tornò ad insistere per il ritorno dei Gesuiti a
Recanati e per questo rispose negativamente all’ospedale S. Lucia che
chiedeva di avere in concessione il fabbricato di S. Vito e la chiesa .
Tra le memorie e proposte di interpretazione delle
disposizioni vigenti non posso tacere della supplica avanzata per l’interpretazione
della Riforma di Procedura all’Art. 717, che consentiva che per ogni
azione esecutiva non si potessero prendere in pegno il letto, le vesti
necessarie all’uso quotidiano del debitore e della sua famiglia, i
viveri bastanti per 10 giorni, gli arnesi di lavoro, i bovi aratori e gli
strumenti agricoli. In tre pagine che sono un documento umanissimo sulla
vita quotidiana della più parte della popolazione, Monaldo spiegava e
chiedeva che si desse disposizione soprattutto che "fosse esente da
qualunque pignorazione un solo caldaio di rame per ogni famiglia,
come strumento necessario alla povera alimentazione familiare di ogni
giorno.
Dettò precise disposizioni perché gli abitanti del
Porto nel proporre istanze davanti al Gonfaloniere per le cause civili di
sua competenza potessero evitare ogni sorta di spesa ed anche quella di
doversi recare di persona all’ufficio municipale.
Si riferiva in particolare al motu proprio con cui si
attribuiva ai Gonfalonieri la facoltà di giudicare le cause non eccedenti
la somma di 5 scudi. Monaldo si fece un personale dettagliatissimo
regolamento provvisorio che trasmise anche ad altri Gonfalonieri che gli
chiedevano consiglio.
Monaldo si occupò anche dello Istituto Provinciale
degli esposti e ne difese i diritti.
In vista dell’anno 1826, anno del giubileo, si
preoccupò persino della compatibilità con la stagione teatrale e il
carnevale. Ma soprattutto scrisse una preghiera che avrebbe potuto essere
usata anche per il 2000!
Curò in particolare l’ordine pubblico, il
potenziamento delle caserme e dei controlli nelle campagne.
Nell’anno 1823 aveva scritto in una lettera
(inedita): «è nella persuasione di tutti che il servizio della Posta sia
regolato assai male»; e proseguiva specificando che alcuni inconvenienti
sono derivati da errori singoli, ma i più sono necessari a conseguenza
dei regolamenti sbagliati. Così - ad esempio - le lettere che partivano
da Roma per Recanati o viceversa al quindici del mese, il 16 erano a
Spoleto e il 17 a destinazione. Invece le lettere scritte da Spoleto
giungevano solo 6 giorni dopo, con il corriere successivo e così le
lettere da Tolentino (a 24 miglia da Recanati) impiegavano 4 giorni in
più di quelle da Roma (170 miglia); e ciò per tutti i Paesi che - pur
essendo sulla strada della corriera - erano solo sede di ufficio di
distribuzione e non di direzione o sottodirezione. Il buon Monaldo non si
capacitava che, essendo Recanati posto tra Loreto e Macerata, le lettere
scritte da queste città verso Pesaro e Bologna giungevano lo stesso
giorno, mentre quelle da Recanati dovevano prima fermarsi chissà dove. Ma
il male peggiore doveva essere il fatto che gli uffici dovevano applicare
la tassa postale sulla base del peso del plico e delle distanze da
percorrere, costringendo così il direttore dell’ufficio e il suo
compagno ad un complesso calcolo delle distanze e dei pesi per scrivere
poi su ogni lettera "la sua condanna" e cioè il valore della
tassa.
Monaldo Leopardi propone allora che il servizio venga
ricondotto al sistema del 1808: il prezzo di due baiocchi applicato
indistintamente a tutte le lettere renderebbe l’amministrazione
"alla sua antica semplicità", diminuirebbe gli impiegati,
compenserebbe l’erario e soddisferebbe i cittadini "levando di
mezzo tanti intralci e complicazioni con le quali una finanza irrequieta
ha deturpato una delle più belle istituzioni sociali"
Dopo questo fiero attacco alla burocrazia Monaldo
conclude, proponendo nientemeno quello che noi chiamiamo "il
biglietto postale" con sopra stampato il bollo da vendere al prezzo
equivalente cosicché «le lettere scritte con questa carta sono franche
di loro natura, perché hanno già pagato alla finanza il prezzo del loro
corso e anche i viaggiatori possono portarle liberamente; l’erario non
perde e i sudditi sono lieti di queste oneste facilitazioni».
Non poche note riguardano usi e costumi. Tra questi
citerò quella sulla caccia e la pesca.
Promosse una campagna tra i Gonfalonieri della regione
per uniformare le istruzioni ai periti stimatori delle terre, affinché i
proprietari delle Marche non dovessero essere gravati più di quelli della
Romagna (colonie parziarie)
Si occupò di tutti i particolari del funzionamento del
vecchio teatro, mentre avviava e sosteneva la costruzione del nuovo, in
mezzo a vertenze ed ostacoli di ogni tipo.
Si preoccupò di regolare le distanze delle case dalle
nuove piantagioni di alberi (23 aprile 1824), definendo per ogni specie di
albero le distanze necessarie.
Interessante è ancora la attenzione che Monaldo portò
sempre alle Poste e al funzionamento degli uffici fin dal 1816. Dispose
tra l’altro che per tutti i giorni dell’anno restasse aperto l’ufficio,
salvo le maggiori solennità (purché non cadesse in esse la partenza o l’arrivo
dei corrieri ordinari). Spedizione e destinazione delle corrispondenze
dovevano avvenire immediatamente. Ma nell’anno 1823 avanzò più serie
proposte alla Delegazione Apostolica.
Non posso poi tacere di quell’interessante relazione
del 1825 sulle industrie manifatturiere dei pettini di corno che è un
esempio raro di documentazione sulla protoindustria: «In questo comune
non esiste alcuna fabrica in grande, che pure sarebbe necessaria per
impiegare tanto popolo mancante di lavoro e riuscirebbe felicemente
perché i viveri e la mano d’opera vi sono a buon mercato». Tuttavia
veniva in breve segnalata l’esistenza di: 1. una piccola fabbrica di
«stoviglie e vasellame ordinario di coccio»; 2. le coperte di lenzi o
stracci lavorate «in dettaglio dal basso popolo»: nelle singole case si
faceva filatura e tessitura e soprattutto tele che venivano smerciate a
Roma; 3. «molte botteghe o piccole fabbriche di petttini da testa ed
altri lavori di corno».
Si apprende così che questa lavorazione era fiorente e
in particolare che i pettini che si vendevano a La Spezia e che si
riteneva fossero importati dalla Francia erano in realtà lavorati a
Recanati. Rinvio molti particolari alla Nota che pubblicai su «Proposte e
Ricerche» nel 1983 (n. 10).
Ma la questione che occupò i giorni e le notti del
Gonfaloniere dal 1816 al 1826, fu quella dei tentativi di separare il
Porto dalla antica città. Al primitivo tentativo di fare del Porto un
appodiato, Monaldo aveva già risposto nel 1818 con l’adozione di un
"Regolamento provvisorio per l’Amministrazione del Porto", che
non fu mai approvato dalle Autorità superiori, ma gli consentì di
continuare così fino al 1823.
Monaldo Leopardi, appena tornato Gonfaloniere, nel
1823, chiede al Delegato apostolico cosa deve fare, rilevando che - per
quanto imperfetto - il suo regolamento - «conosciuto dalla Delegazione
apostolica» - aveva consentito di operare «passabilmente» fino al 1821.
Allora venne abolito, ma non essendosi sostituito
altro metodo migliore, tutto va colaggiù in disordine e giace in
perfetta anarchia […]. Per conseguenza quel popolo vive come vuole,
abbandonato a se stesso ed alla provvidenza e se non fosse un popolo
buonissimo e docilissimo, andrebbe incontro ai più gravi
inconvenienti. […] Duemila abitanti vivono in quel luogo come
vivrebbe un gregge errante senza guida e senza Pastore.
Il fuoco covava sotto la cenere. Ed ecco che il 16 di
agosto del 1825 il Gonfaloniere di Recanati, sempre Monaldo Leopardi,
dovette inviare alla Commissione incaricata della nuova classificazione
dei Comuni una lunga e dettagliata memoria, per controbattere la pretesa
della «Coamministrazione» lauretana di scorporare da Recanati la
contrada degli Scossicci, che diventerà in seguito parte integrante del
nuovo Comune di Porto Recanati. Questa memoria, che ho pubblicato per
intero, poiché era inedita1, conferma ancora una volta quanto
la storia dell’autonomia del Porto sia indivisibile dalle rivendicazioni
di Loreto e dalla decadenza di Recanati, l’antica patria comune, proprio
come aveva previsto Monaldo, il quale - piaccia o no la sua coerenza -
difese fin che poté l’unità del territorio.
Alla fine dell’intenso periodo di lavoro condotto in
quegli anni, due problemi avvelenarono i giorni di questo amministratore
avveduto, lungimirante ed equo più di quanti Recanati ne avesse mai
avuti:
La annosa causa Flaminj per l’Annona che si
trascinava dall’inizio dell’800 e che riemergeva ogni tanto.
La inimicizia del Governatore Luca Mazzanti, del
quale sono documentate agli atti le meschine e continue richieste
per la propria abitazione, perfino per le stoviglie di cucina e le
interferenze su ogni competenza.
Una nota di pugno di Monaldo, diretta al Governo
Pontificio il 24 novembre 1823 mi sembra molto eloquente. Non è certo
priva di acredine, ma ha una indiscutibile dose di verità. Eccola:
Recanati 24 Nov. 1823
Fino dallo scorso mese di Marzo il Nobil uomo Sr.
Cav. Luca Mazzanti dal Governo di Santa Vittoria venne destinato al
Governo di questa città, ma non poté recarvisi fino al mese di
Maggio perché impedito costantemente da grave e pericolosa infermità
di Artritide. Nell’epoca suddetta giunse in questa città oppresso
dallo stesso male che in seguito si aggravò non poco, e segnatamente
nei mesi di maggio e giugno obbligandolo a quasi continuo letto, ed a
rigorosa cura di frequenti salassi, bagni ed altri metodi debilitanti
necessari a comprimere l’atrocità del morbo e la febbre che li
accendeva spesso con imponenza e minacciava segnatamente la testa. Io
lo ho veduto con frequenza in questo stato compassionevole da cui non
è ancora totalmente risorto, e mi sono convinto non avrebbe potuto
applicarsi a conoscere le leggi che si emanavano dal Governo, e a
disimpegnare gli ordinarii incombenti del proprio uffizio, e di fatto
non è mai intervenuto al pubblico consiglio. Di tutto ciò per essere
la verità rilascio il presente certificato.
Monaldo Leopardi
Per parte sua il Mazzanti mise insieme 83 capi di
accusa contro Monaldo tra presunte spese arbitrarie, abusi e violazioni di
legge, che poi - ma ci vollero anni - risultarono tutte infondate. Luca
Mazzanti fu trasferito a Sassoferrato e poi a Terracina, con tutti i suoi
malanni, ma Monaldo già nel febbraio del 1826 fu sostituito dal Marchese
Girolamo Melchiorri.
Negli anni successivi, perodicamente, si chiese al
Conte di accettare nuovi incarichi di Consigliere. Le sue risposte furono
sempre negative. L’ultima che ho trovato è del 1843 e comincia così:
«Sono già 15 anni da che […] dimisi l’ufficio di consigliere e
qualunque altra ingerenza nella Amministrazione delle pubbliche cose […].».
Per la verità una brevissima eccezione la fece quando accettò nel 1831
di far parte della Giunta provvisoria dopo la rivoluzione. Ma la profonda
amarezza che dopo l’esperienza amministrativa era restata dentro l’animo
di Monaldo è espressa nel modo più chiaro nella lettera dell’8 di
aprile 1830, in risposta alla richiesta di tornare a far parte del
Consiglio Comunale.
Vorrei leggerla a conclusione, per ora senza commento,
perché è vera, quanto amara:
L’inaspettato graziosissimo ufficio con cui le
Sig.rie loro Ill.me, a nome ancora e per volontà di tutto il
Consiglio, mi invitano a rientrare nel loro corpo, è tale e tanto
larga dimostrazione di fiducia e di benevolenza che devo chiamarmene
al sommo onorato e riconoscente. A questo atto di tanta cortesia ed
amicizia non corrisponderò certamente con la rusticità di un
rifiuto, ma mi pare che io già non possa rientrare utilmente nel
corpo amministrativo di questa Città, e vorrei che le Sig.rie loro
Ill.me e tutti li signori del Consiglio ne fossero ugualmente
persuasi.
Ancorché sappia di non avere mai volontariamente
nei tempi passati operato contro il vantaggio pubblico della Patria,
overo arrecati privata offesa a miei concittadini, può essere che
dovessi soltanto alla mia imprudente e mal misurata condotta il
trovarmi per gli ufficii pubblici in gravissime angustie; ma in ogni
modo e qualunque ne fosse la causa quelle angustie mi comandarono il
ritiro da qualsivoglia pubblica cura, e chiunque dové una volta
salvarsi con la faccia non può più comparire con onore nel Campo,
né farvi ufficio di valoroso soldato. Di quelli angosciosi tempi mi
resta sempre il dubbio che potrebbero insorgere nuovamente, la paura
gravissima di trovarmi un’altra volta in consimili stretti e quindi
la risoluzione invariabile di non assumere mai più nessuna
Magistratura. Così aggiunto alla naturale insufficienza il presente
scoraggiamento, non posso oramai essere più utile cittadino di questa
Patria e tornando a sedere in Consiglio vi porterei solamente l’animo
infiacchito, la voce snervata e la fantasia preparata a qualunque
timorosa apprensione.
Per tutto questo niente altro desidero fuorché
passare il poco residuo della vita nella pace e nella dimenticanza, e
prego le S.rie loro Ill.me, e li Signori del Consiglio a volermelo
concedere benignamente. Questa grazia, che imploro con ardentissimi
voti dalla loro bontà, non eliminerà in alcun modo il pregio sommo
dell’attuale onorevolissimo invito, e dell’una e dell’altro
conserverò sempre verso le S.rie loro Ill.me, e verso il rispettato
corpo dei Consiglieri la più dovuta e sincera riconoscenza.
Con questi sentimenti passo all’onore di
protestarmi pieno di rispettosissimo ossequio
Delle SS.rie loro
Ill.me D.mo [devotissimo] Obbl.mo [obbligatissimo]
Monaldo Leopardi
Recanati 8 Aprile 1830

|
| |
|
Quel
paio di jeans di Tiberio Mitri di Carlo Trevisani
"Per l’Italia fu una favola": così
titolava La Gazzetta dello Sport del 13 febbraio tratteggiando in prima
pagina la figura di Tiberio Mitri, l’indomani della sua tragica
scomparsa.
Di una parte di quella favola Porto Recanati fu
testimone, e in qualche modo partecipe, nelle occasioni in cui il campione
triestino venne ad allenarsi nella nostra cittadina, aggregandosi alla
nazionale dilettanti della FPI, che aveva eletto il proprio quartier
generale presso la palestra Diaz, grazie alle entrature e alla
lungimiranza di autentici gentlemen dello sport locale, come Luigi Rabuini
e Reolo Rapaccini.
Accedere alla palestra Diaz, durante gli allenamenti di
Mitri e dei nazionali, era privilegio riservato a pochi spettatori, in
quanto l’indimenticabile "maestro" Egidio Mosca, e
"Peppe" il custode, facevano rigorosamente osservare le
disposizioni restrittive impartite dagli istruttori federali Steve Klaus e
Natalino Rea, che non gradivano la presenza di troppa gente, e soprattutto
di troppe ragazze, onde evitare agli atleti pericolose occasioni di
"distrazione".
Fu così che nel 1950, all’età di appena 11 anni,
contagiato dall’entusiasmo che circolava in paese, presi a frequentare
la palestra Diaz in qualità di apprendista boxeur, presentato al maestro
dal mio indimenticabile amico Fabio Ballarini, atleta naturale
eccezionalmente dotato, che allora praticava la boxe, e che mi avrebbe
successivamente coinvolto nella passione per il ciclismo, prima di
raggiungere le vette calcistiche della seria A nel ruolo di bravissimo
portiere.
La veste di neofita dell’Accademia pugilistica mi
consentiva di accedere come spettatore agli allenamenti dei professionisti
e dei dilettanti nazionali, che precedevano quelli dei pugili locali, e di
godermi lo spettacolo offerto dal fior fiore del pugilato italiano di quel
tempo. In mezzo a tanti pugili di pur elevato livello, la classe eccelsa
di Tiberio Mitri svettava in modo eclatante per la perfezione dell’impostazione
tecnica, per l’intelligenza tattica, per l’eleganza dello stile e per
la fantasia spumeggiante delle combinazioni di colpi: per quanto io possa
ricordare dei pugili di quel tempo, e di tutti quelli che sono seguiti,
solo Ray "Sugar" Robinson poté eguagliare la classe del nostro
campione, nella categoria "regina" dei pesi medi.
Si è detto e ripetuto che Mitri difettasse di potenza,
di quel colpo risolutore che contraddistingue il grande
"fighter", indispensabile al più alto livello, ma si è sempre
trattato di una diagnosi superficiale, in cui un limite caratteriale è
stato equivocato per un limite fisico: Tiberio era un buono, ed il suo
vero limite era la mancanza di cattiveria, che gli impediva di infierire
sull’avversario, così nella boxe come nella vita.
Quanto alla potenza, basti ricordare che era solito
concludere i suoi allenamenti sgonfiando la camera d’aria del "puncin
g ball" con un jab destro di eccezionale violenza, quello stesso
colpo che nel 1954 gli consentì di tornare ad essere campione d’Europa,
atterrando alla prima ripresa il detentore Randy Turpin, che si era
permesso il lusso di battere niente meno che Ray Robinson, titolo mondiale
in palio, e che si era andato a cercare la lezione, sfottendo Tiberio
nelle schermaglie polemiche della vigilia.
Al pari di altri campioni dello sport, Coppi su tutti,
Mitri si distingueva per una naturale eleganza, che si manifestava non
solo nel gesto atletico e nell’affabilità del tratto, ma anche nell’esteriorità
dell’abbigliamento, sia nella pratica sportiva che nella ordinaria
quotidianità. In allenamento era solito indossare una tenuta composta da
un pantaloncino Everlast bianco con banda nera, indossato sopra una
calzamaglia nera, e da una canottiera nera indossata sopra una T-shirt
bianca.
Per le strade di Porto Recanati lo si vedeva indossare
con disinvoltura un paio di pantaloni mai visti prima d’allora, di un
cotone color blu leggermente stinto, con impunture di filo color
"becco di papera", che segnavano i margini delle tasche e le
cuciture delle gambe, arrotolati in fondo a mo’ di terzaroli. Quei
pantaloni di nuova foggia altro non erano che il primo paio di jeans che
si fosse mai visto a Porto Recanati, che Tiberio aveva certamente
acquistato durante la trasferta in USA per l’incontro mondiale con il
"toro del Bronx" Jack La Motta.
Ai miei occhi di ragazzino esercitarono un fascino
irresistibile, evocando nella fantasia la rusticità delle tenute da cow
boy, tanto che implorai di farmene fare un paio simile: fu così che mia
madre mi fece confezionare da un’anziana pantalonaia di nome Giovanna,
che abitava sul Corso, di fronte alle scuole elementari, un paio di
pantaloni di comune tela blu, impunturati di filo bianco, che furono
probabilmente il primo simil-jeans autoctono realizzato ed indossato a
Porto Recanati, ben prima che la moda jeans si diffondesse
irrefrenabilmente per ogni dove.
L’ultima volta che vidi Tiberio Mitri fu una sera di
tanti anni fa, al vecchio Bar centrale: era reduce da una rimpatriata con
alcuni ex pesi medi, in occasione di una sua visita in zona per una
modesta attività commerciale, e si diede da fare per arginare l’arroganza
di un bullo anconetano, in cerca di improbabili rivincite postume nei
confronti del nostro Antonio Agostinacchio, da cui era stato ripetutamente
suonato in diversi confronti diretti, nonostante che la differenza d’età
giocasse a suo favore.
È scomparso così, all’alba di un giorno triste di
febbraio, investito di spalle da un treno, mentre vagava senza meta sui
binari, come nella tragica sequenza finale di uno di quei film sulla boxe,
in cui aveva recitato da comprimario.
Se c’è un paradiso per gli ex campioni della "noble
art", all’arrivo di Tiberio avranno certamente fatto una gran
festa, riservandogli un meritato posto d’onore.

|
| |
|
Ricordo di Spartè di Nevia Rombini
Espartero Rombini era personaggio più che conosciuto
nell’ambito della marineria portorecanatese. Questo ricordo che
pubblichiamo, opera della figlia Nevia, ci riporta alla tragica notte del
29 marzo 1935, quando cinque nostri pescatori persero la vita. Espartero,
Spartè per tutti, si rese protagonista di un atto di coraggio che pochi
conoscono e che, invece, merita di non essere dimenticato. Eccone il
racconto.
Il 29 marzo 1935, durante il temporale che flagellava
la nostra costa, mio padre, Rombini Espartero, i suoi fratelli Francesco e
Angelo e altri famigliari di coloro che erano usciti a pescare con la
barca a vela, correvano su e giù lungo la spiaggia cercando di portare
soccorso.
La barca di Francesco Borini era in balia delle onde.
Il figlio Fortunato, a bordo anche lui, non sapeva nuotare. Il padre era
riuscito a metterlo in salvo. Si era salvato anche un altro pescatore
della stessa barca, Giacomo Bufarini.
Francesco Borini aveva cercato di riprendere il governo
della barca, ma le onde indomabili avevano sbattuto l’imbarcazione sulle
pietre. Era in pericolo di vita.
Mio padre, con il coraggio di chi ha vent’anni, si
era legato una cima intorno alla vita, tenuta con forza dai miei zii
Francesco e Angelo. Poi si era gettato in mare ed era riuscito a portare a
terra Francesco Borini. Purtroppo era morto da pochi minuti.
Argentina Borini, figlia di Francesco, esprime stima e
affetto ancora oggi alla memoria di mio padre.
"Guardando il mare in burrasca
si può capire quanto è grande il cuore di chi
attende, prega e spera
Signore io Ti amo
Ti prego, vigila su chi ha bisogno di Te."

|
| |
|
Un Patrono, due
Comuni di Carlo Pesco
Ogni paese ha il suo patrono. Non è una frase di
effetto o una verità rivelata. E’ un dover ammettere che ciascuno di
noi è legato alle proprie tradizioni, alla propria cultura, agli usi e
costumi del proprio luogo natio o della propria dimora. E ciò è tanto
più vero soprattutto quando siamo chiamati a confrontarci con gli altri
che, magari ci infastidiscono perché esaltano talmente il proprio luogo
come se fosse il migliore, l’unico.
Succede allora che l’emulazione ci porta a gareggiare
con l’altro nelle varie bontà che abbiamo, dimenticando così che
accanto a fenomeni positivi ci sono anche delle ombre. Tutti i sindaci e i
parroci sarebbero, in questi momenti, orgogliosi di avere tali
concittadini. Finita la "gara", si ritorna alla normalità e
alla critica della propria realtà e del proprio paese.
Capita, però, che in qualche realtà non si abbia
tempo per queste "memorie" o che usi e costumi siano talmente
cambiati da disperdere un patrimonio culturale o sociale, o che non ci sia
mai stata una tradizione legata al proprio particolare Santo. E’,
inoltre, da tener presente che è invalsa da alcuni anni la
"moda" di rievocazioni più o meno storiche che hanno avuto ed
hanno il merito di aggregare le persone con conseguenti vantaggi anche
economici.
È successo vent’anni fa anche a Camerano. L’allora
parroco, l’arciprete don Gabriele Ruzziconi, nuovo del paese ma non del
servizio, volendo avere un rapporto diverso con i propri fedeli, dopo aver
osservato, per un certo periodo, che in paese c’erano sì tante
attività e tanti momenti di aggregazione, ma tutti rigorosamente
separati, pensò a un qualcosa per tutto il paese.
La sua idea non era tanto quella di far confluire in
piazza persone per ritrovarsi assieme in un momento di sana allegria: era
pur sempre un sacerdote. E come in tutti i paesi la festa del patrono
(quello di Camerano è San Giovanni Battista) si celebrava solo con la
Santa Messa e la processione: era ormai abitudine invalsa festeggiarla
così. La fede, a volte, abbisogna di imput per essere sempre viva e non
stanca.
Si confrontò con diverse persone, tra cui chi scrive,
espose la sua idea e questa divenne in breve un progetto. Ad agosto sarà
la ventunesima festa del patrono che celebreremo secondo queste ormai
consolidate modalità. Nella festa, infatti, convergono momenti diversi
(religioso, folkloristico, sociale, ludico e di appartenenza) che la
rendono accettabile e partecipata da tutte le componenti del paese.
Temporalmente dura almeno due giorni, a volte anche una settimana. Abbiamo
infatti progressivamente arricchito la festa con manifestazioni
integrative del nucleo iniziale.
Ma la festa vera e propria è composta da:
Una sfilata per le vie del paese in abiti
"storici" con tutte le varie categorie ed in particolare coi
personaggi del tempo: S.Giovanni Battista, Erode, Erodiade, i soldati
romani…. C’è stata una cura particolare nel ricercare i costumi
dell’epoca.
Una gara tra i rioni in cui è stato diviso il paese,
recuperando nel nome le località o gli aspetti più significativi. Tale
gara è divisa in due momenti. Un primo momento, nel pomeriggio e subito
dopo la sfilata, la "corsa del sacro vassoio". Squadre di
quattro persone, intercambiabili durante il percorso, devono
attraversare il paese nel più breve tempo possibile recando un vassoio
di due metri per uno, cadenzando il passo sui compagni della squadra.
Tale squadra avrà un certo punteggio secondo l’ordine di arrivo. Alla
sera, dopo cena, al campo sportivo ci sono i giochi di squadra ed, alla
fine, le premiazioni.
Un recital. E’ il momento della serena riflessione
e dello spettacolo. Il filo conduttore è sempre San Giovanni. I testi
sono tratti dal Vangelo ed adattati all’attualità.
Fanno da contorno altre manifestazioni coi giovani e
coi ragazzi come il mercatino, spettacoli musicali…La partecipazione
delle autorità a tutte le manifestazioni ed al momento liturgico per
eccellenza.
Tale festa è ormai diventata tradizione e coinvolge un
notevole numero di concittadini. Si lavora per molti mesi e con ruoli
diversi. Dopo tale impegno si è pensato di esportare la festa o tutta o
in parte nei paesi limitrofi che, magari, hanno lo stesso patrono. Sarebbe
un modo di allargare i propri orizzonti e di veder riconosciuto anche il
proprio impegno. Chissà!

|
| |
DOCUMENTO 8 - Prigionieri di guerra
È un documento toccante, composto di sei lettere di
Quinto Cavallari scritte ai famigliari; le prime tre, aprile-settembre
1917, sono del bersagliere Cavallari impegnato in zona di guerra, le
altre, ottobre ’17 – gennaio ’18, del prigioniero Cavallari, inviate
dal campo di concentramento di Milowwitz bei Lissa dove il nostro
concittadino è morto.
Sulla località di prigionia abbiamo ancora qualche
dubbio: può trattarsi dell’odierna Lysa nad Labem, pochi km a nord est
di Praga oppure dell’attuale Lezno (più probabile) sita a circa 60/70
km a nord ovest di Varsavia.
Ringraziamo la signora Jole Fabbrizzi Cavallari, che ci
ha fornito copia di questa preziosa documentazione.
La grammatica è… di guerra e i puntini appaiono
dove la calligrafia è diventata illeggibile.
Zona di guerra. 9-4-‘17.
Cari Genitori, ieri mi è giunta una del zio Pasquale
dove mi dice che rimase ferito il giorno 6 corrente. Perché mi fate privo
di tutto? Al meno se non vi sentite di darmi cattive nottizie…Sono da
dieci giorni che mi trovo in questo Reggimento che è il 21° e ancora
devo avvere un vostro scritto e…con la presente sono quatro mie che v’invio.
Fate la cortesia di darmi una pronta risposta. Saluti e baci a tutti.
Zona di guerra. 28-8- ‘17.
Caro Padre si parte per ignota destinazione atendete
più presto possibile il mio indirizzo. Saluti e baci a tutti di famiglia.
Vostro aff.mo figlio Cavallari. Fate avvisato Attilio (il
fratello) baci.
Zona di guerra. 30-9-’17.
Cari Genitori, da molto tempo che sono privo di vostre
nottizie non so come sia. Quanto prima ricevete la presente, mi date buone
nottizie. La mia salute ottimamente. Come pure spero di voi tutti in
famiglia. D’ora sono giunto al 21° Reggimento come già vi feci noto
con una mia. Saluto a voi tutti in famiglia in più tutti gli amici chi
domanda di me e un forte abbraccio e un bacio vostro aff.mo figlio
Cavallari Quinto.
22 decembre 1917.
Cari Genitori dal 20 ottobre (1917) che sono
prigioniero…..ottima come pure spero per voi. Quanto prima avrete la
presente inviarmi vaglia telegrafigo e più abbonarsi alla Croce Rossa per
il pane. Vi ripeto ancora abbonarsi alla Croce Rossa. Pane e Pane.
Inviarmi vaglia………
30 decembre 1917.
Cari Genitori colla presente vi faccio noto del mio
bene stare di salute. Come pure spero di voi tutti. In data 22/12/917
scrissi una mia cartolina raccomandandovi che quanto prima ricevete la
presente inviarmi pane, pane e pane e vaglia telegrafigo. Non mancherete
soddisfare il mio pensiero come mi avete sempre soddisfatto miei cari.
Saluti Attilio, Giuseppe, Gina e Nonno e tutti gli amici e parenti e a voi
un forte abbraccio e bacio dal vostro aff.mo figlio Cavallari Quinto.
21 gennaio 1918.
Cari Genitori colla presente vi invio il mio bene stare
di salute. Come pure spero di voi tutti, in famiglia. Quanto prima la
ricevete, mi inviate pane e bonatevi alla Croce Rossa. Sperando al più
presto possibile vostre nottizie. Saluti a tutti gli amici e compagni. E a
voi in famiglia un forte abbraccio e un bacio dal vostro aff.mo figlio
Cavallari Quinto. Darete buone notizie al mio fratello Attilio del mio
bene stare salutandolo caramente con un bacio.

|
| |
|
CRONACHE DELL’ARTE E DELLA CULTURA:
novembre-aprile 2001
di Aldo Biagetti
NOVEMBRE 2000
SABATO 4
Al Castello Svevo viene presentato il programma del
1° ANNO ACCADEMICO DELLA UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’, di recente
istituita a Porto Recanati, con il patrocinio della Civica
Amministrazione e l’apporto iniziale della Unitre di Civitanova
Marche; il Centro Studi Portorecanatesi curerà i vari corsi, il Centro
Sociale "Anni d’Argento" ogni problema burocratico ed
amministrativo. Sede delle lezioni la Scuola Elementare di Corso
Matteotti.
Sono previsti tre corsi :
Arte e Storia del Territorio, 24 lezioni, docenti:
Carotti, Palanca, Bislani e Bonifazi, con inizio lunedì 6 novembre
Inglese (1° livello) – 48 lezioni, docente
Franco Montesarchio, inizio venerdì 10 novembre
Taglio e cucito - 24 lezioni – docente sig.ra
Aliota, inizio 28 novembre
Iscritti 71
DICEMBRE 2000
VENERDI’ 15
Per l’organizzazione dell’Associazione culturale
Amadeus ha inizio, nei locali della Parrocchia di S. Giovanni Battista,
una serie di concerti di musica classica, con la partecipazione della
Scuola di Musica diretta da Ilaria Tramannoni.
DOMENICA 17
Al Castello Svevo, salone Biagio Biagetti,
presentazione del libro "Il Cantiere Navale Gardano e Giampieri –
1941/1966 – storia vera di una leggenda" di Aldo Biagetti e Lino
Palanca, a cura del Comitato ex-dipendenti del Cantiere e del Centro Studi
Portorecanatesi; relatore l’Ammiraglio Marcantonio Trevisani.
GENNAIO 2001
SABATO 20
Al Cineteatro Adriatico con il lavoro "Gli esami
non finiscono mai" di E. de Filippo ha inizio la seconda stagione
teatrale, organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dall’Associazione
Arca.
SABATO 27
Il Centro Studi Portorecanatesi, con una cerimonia nei
propri locali, consegna una targa alla esimia pittrice locale VELIA
SIMONCINI, in occasione del suo 90° compleanno. Sono presenti, oltre a
numerosi cittadini, il Sindaco di Porto Recanati ed il dr. Franco Foschi
che, a nome del Comune di Recanati, consegna alla nostra cara artista una
particolare moneta d'oro.
FEBBRAIO 2001
SABATO 10
Al Castello Svevo, per iniziativa dell’Assessorato
alla Cultura, del C.S.P. e dell’Associazione Culturale Coro a Più Voci
presentazione del romanzo storico "Il Vergaro – Storia di contadini
nella terra di Leopardi" di Renato Pigliacampo. Relazione critica
della Prof.ssa Donatella Donati.
MARZO 2001
DOMENICA 4
Giuseppe Soffiantini presenta al Castello Svevo un
volume dove narra i dolorosi giorni del suo sequestro.
DOMENICA 11
A Palazzo Volpini viene presentato il libro "Marconi
e il mare" di Filippo Pacelli (Patrocinio del Comune di Porto
Recanati, della Lega Navale e del Centro Studi Portorecanatesi).
APRILE 2001
DOMENICA 1
Nella Basilica Lauretana il Cardinale Carlo Furno
nomina Cavaliere dell’ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
Padre Bruno Silvestrini.
PADRE BRUNO SILVESTRINI nasce a Porto Recanati il 15
marzo 1954 da Guido e Laura Mandolini.
Ordinato Sacerdote presso la Parrocchia del P.mo Sangue
di Porto Recanati il 7/12/1981, segue a Roma studi di specializzazione in
Liturgia. Nominato Segretario Provinciale Piceno nel 1993, nel Capitolo
tenutosi a Cascia (17/28 giugno 2000) viene nominato Segretario Nazionale
dell’Ordine Agostiniano.
DOMENICA 22
All’Auditorium della Scuola Media, organizzato dal
Centro Studi Portorecanatesi, con il patrocinio del Centro Mondiale della
Poesia e della Cultura di Recanati e del Comune di Porto Recanati, viene
presentato "Percorsi della Memoria", un volume di Aldo Biagetti
e Lino Palanca, sul soldato portorecanatese nella seconda guerra mondiale
e nella Resistenza. Relatore l’Ammiraglio di Divisione Elio Bolongaro,
Comandante in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell’Adriatico.

|
| |
|
Cronache del 2000
(1/11/2000
– 30/4/2000)
I fatti e i giorni
In
novembre iniziano i lavori di rifacimento del lungomare.
Il 17 dello stesso mese muore in un incidente stradale,
in territorio di Castelfidardo, il giovane Luca Ascani.
In gennaio, il 18, artificieri dell’esercito fanno
brillare una bomba, residuato della seconda guerra mondiale, in un campo
di Scossicci, presso la spiaggia.
Il 4 marzo, organizzato dal Gruppo Podistico Amatori,
si svolge un apprezzato carnevale portorecanatese.
Si acuiscono, a partire dal mese di marzo, le proteste
per il supposto inquinamento nella zona di Santa Maria in Potenza.
L’Associazione Amici di Mar del Plata è fondata il
22 marzo.
Il 13 aprile, venerdì santo, si svolge, come accade
ormai da secoli, la processione della "bara de notte".
Lo
sport
In
gennaio l’Amministrazione Comunale premia con una targa atleti e
dirigenti di società sportive locali.
A metà marzo i giovanissimi fratelli Storani ottengono
grandi successi nei campionati regionali e nazionali di sci alpino.
A fine marzo l’Amministrazione Comunale annuncia che
non ci sono più ostacoli sostanziali alla realizzazione del nuovo stadio
nella periferia sud della città.
Il primo aprile si svolge a Porto Recanati la finale
del campionato d’inverno regionale cross country di mountain bike.
Ordine pubblico
Il
17 novembre, la Guardia di Finanza opera due fermi in pieno centro
cittadino procedendo poi a un arresto per reati connessi allo spaccio di
stupefacenti.
Il 3 gennaio si scopre che mancano altre tre tele dalla
Pinacoteca Moroni. Si tratta di opere di Francesco Maffei (Gesù al
tempio, XVII secolo), Dante Ricci (Mandorlo fiorito, XIX) e Celso
Baldassarri (Canale, XIX). Siamo al furto numero 8 e l’emorragia
continua.
In gennaio il Sindacato Autonomo di Polizia lancia un
allarme, l’ennesimo: a Porto Recanati si fanno pochi controlli. Poco
dopo vengono chiuse diverse case così dette a luci rosse.
Nel mese di marzo si registrano parecchi incendi dolosi
di barche e impianti balneari a Scossicci e presso il Potenza.
Il 28 marzo avviene una rapina nella filiale della
Banca delle Marche. I Carabinieri, però, subito sul posto, arrestano i
tre banditi e i loro complici, cinque persone in totale.
Il 31 marzo altro incendio doloso di un negozio di
frutta e verdura in via Cavour.
Vita sociale
Il 17 dicembre si presenta il volume sul cantiere
Gardano-Giampieri, di Lino Palanca e Aldo Biagetti, a cura del CSP. Pochi
giorni dopo, il Centro decide di creare "La Ginestra", sezione
leopardiana del CSP, che nasce dal gruppo di conversazione già attivo da
qualche mese.
Sempre in dicembre prende avvio il primo concorso di
poesia dialettale marchigiana intitolato a Emilio Gardini.
In gennaio esce il numero 4 di questa Rivista mentre
riprendono i corsi dell’Unitre, sospesi per le feste di fine anno. Il
giorno 27 viene festeggiato in sede il 90° compleanno di Velia Simoncini.
Il 4 febbraio si tiene l’assemblea dei soci, che
eleggono nel direttivo (del quale fanno parte di diritto i soci fondatori)
le seguenti persone: Maria Teresa Moscatelli, Aldo Biagetti, Alessandro
Rovazzani e Flaviano Ponziani. Nel collegio dei probiviri-revisori dei
conti sono invece eletti: Carlo Trevisani, Giovanni Rovazzani e Enzo
Valentini. Il nuovo direttivo elegge Lino Palanca presidente, Luciano
Monarca vice, M.T.Moscatelli segretaria, Giuseppe Perfetti economo. Lo
stesso coopta come soci fondatori: Nando Carotti, Luciano Monarca, Enzo
Panico e Enzo Valentini.
Il 4 e il 28 marzo vengono ricordati, rispettivamente
con un telegramma ai famigliari e fiori sulla tomba, i presidenti onorari
del CSP Giovanni Cittadini e Attilio Moroni, nel giorno anniversario della
loro morte.
Dialetto in pillole
Cénciu. Nella Vie
de Saint Alexis (1050 circa), un testo in antico francese in cui è
narrata la vicenda del patrizio romano Alessio, che abbandona affetti e
ricchezze per vivere un’esperienza religiosa in stretta povertà,
compare nella strofa XXIX il vocabolo cinces (< lat. cincius).
Siamo nel momento di grande disperazione della madre del futuro santo, che
si reca nella stanza ormai vuota del figlio e: ‘Chambre – dit ele
– ja mais n’estras parede,/ ne ja ledece n’iert en tei demenede!’/
Si l’ot destruite com s’ost l’oüst predede;/ sas i fait pendre e cinces
deramedes:/ sa grant orrour a grant duel at tornede….
(‘Camera – disse – mai più sarai addobbata,/ né
più gioia sarà tra le tue pareti."/ E poi l’ha ridotta come
saccheggiata dal nemico;/ crine vi fa appendere e miserabili stracci:/ il
grande orrore in lutto grande è volto…).
Il francese, in seguito, ha perduto il vocabolo in
favore dell’attuale chiffon, attestato già in Mathurin de
Régnier nel 1608 e proveniente dall’antico francese chipe, che
ha dato luogo a chiffe (un pezzetto, una parte tolta, stracciata
dal tutto).
L’italiano, al contrario, l’ha conservato, come il
dialetto il quale, al solito, si è mantenuto più fedele al latino
mantenendo la u finale.
Il vocabolo è usato nell’espressione cénciu el
pàggiu!, esclamazione di valore negativo, riferita a persona che non
gode della considerazione di chi parla e che significa: quel pàggiu (uomo)
di cui si parla vale quanto un cencio.
Si dice pure ‘mmullà el cénciu nel senso di
approfittare di una situazione, ma qui, per quanto ci siano alcune
ipotesi, è un po’ difficile azzardare indicazioni sull’origine del
detto.
4^ Edizione PREMIO POESIA – ESTATE 2000
1^ classificata: ANNA MARIA PELOSI di ANCONA, con la poesia "PER NOI"
Non dormire,
ascolta:
il vento,
il grande vento del cosmo,
si è impadronito ormai delle strade
e le percorre di corsa,
con la furia di un amante.
Viene da est…
E’ passato stanotte sopra il mare,
rapido
e come un insaziabile predone
ha catturato quella dolce amaritudine
che ora lo rivela.
Sì,
il suo vasto mantello
dev’essersi impigliato poco fa ai ferri del balcone
poi, forse, le fessure delle persiane chiuse
l’hanno incuriosito
e la lama sottile della sua audace giovinezza
è penetrata fin dentro le stanze…
Non dormire,
ascolta:
il vento,
il libero vento degli oceani,
è qui.
Ha scelto di confondersi col respiro segreto
della nostra casa.
Per noi.
2^ classificata: MARA GIOVINE ALBENGA, con la poesia "IO
NON HO NOME"
Io non ho nome.
Chiamami mare: danza di spuma
tra l’ànfiteatro
di sognanti stelle,
fiume di vetro
sui tappeti d’alghe
delle speranze;
labbra incollate
nella solitudine
di conchiglie chiuse,
palpito di squame
su letti di coralli.
Già ho alzato un volo
di vele bianche
che non han paura
appese agli aquiloni
dei gabbiani.
Ardono alti i fari,
non temo isole
di bagliori sublunari
nella magica tregua
degli specchi.
Poeta è squarcio su orizzonti alti.
Io non ho nome.
Chiamami cielo: ciottolo di luna
gettato dentro
il pozzo della notte,
grido sigillato
di un’antica esplosione
di comete,
angelo vagabondo
dai capelli di nuvola
e le ali di vento
sotto la trasparenza
delle stelle.
Poeta è fiume delle meraviglie
Io non ho nome.
Chiamami fuoco: incendio
di questa enorme notte
della vita,
cascata e orgia
di ubriaca luce,
ugola e grido
e crepito di fiamma.
Poeta è cero di sole incandescente
Io non ho nome.
Chiamami donna: terra sconfinata,
arata, aperta
al prodigioso coito
di sogni onnipotenti.
Poeta è fiato di universi nuovi.
Io non ho nome.
C’è mare e cielo e vento
nei miei occhi.
Troppo mare, forse,
troppo vento e cielo…
C’è fuoco, notte, figli
nel mio ventre.
Troppa notte, forse,
troppo donna e fuoco…
Ci sono cupole, archi, echi,
briciole e frantumi di poesia
dentro il cuore.
Troppa attesa di poesia, forse,
troppo dolore…
Ma creare è un sogno
che denuda gli occhi
e accende grappoli di stelle
sotto i polpastrelli delle dita.
Io non ho nome
o forse un nome solo.
Chiamami amore.
3° classificato LAMBERTO PERLINI di
JESI, con la poesia: "UN VIANDANTE IN PROVENZA"
Sei case, una locanda, febbraio soffia vento sulla
brina;
laggiù un viandante, da un campo di lavanda, pian piano
si avvicina.
Povero Cristo, quanto cammino ho fatto,
stanco, affamato, disperato, offeso.
L’ispida barba rossa: una ferita sul volto suo
disfatto.
Ha combattuto tanto, poi si è arreso.
Or della trattoria socchiude l’uscio
per chiedere qualcosa da mangiare
è rattrappito, racchiuso nel suo guscio,
prova vergogna: non ha di che pagare!
L’oste è colpito da quegli occhi spenti,
capisce il dramma suo. Lo fa pranzare.
Mentre vuota il buon vino dal bicchiere
si guarda attorno: il grigio si dissolve,
e i colori ritornano a danzare.
Vorrebbe dir qualcosa, ringraziare
gli escono due parole: "son Vincenzo…"
Prima di uscire al freddo che l’aspetta
sfila da una cartella alcuni fogli
li porge sorridendo, senza fretta.
Apre la porta e mesto si allontana
piccolo punto che va scomparendo, sulla strada montana.
Anche l’oste sorride. Gira e rigira i fogli tra le
mani,
senza capire, guarda quei segni strani.
Scuote la testa un po’ mentre li straccia, in tanti
pezzettini, almeno cento.
Aperti i vetri, li lancia al cielo e se li prende il
vento.
Ma uno ne resta. E’ lì sul davanzale, l’oste dentro
di se quasi si pente,
a stento legge un nome,
Va…Van… Van Gogh Vincènt,
ma è un nome che gli dice rien de rien

|
| |