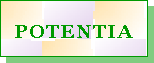
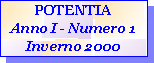
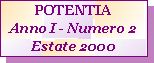
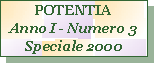
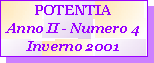
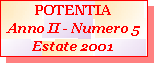
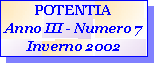
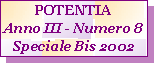
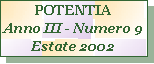
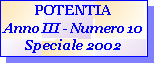
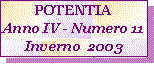
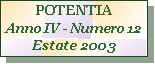
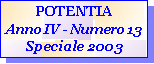
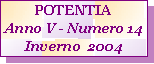
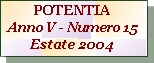
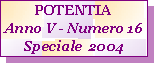
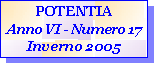
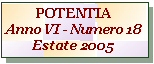
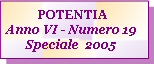
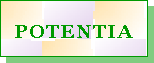 |
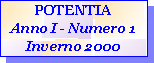 |
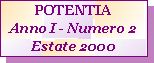 |
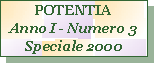 |
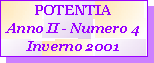 |
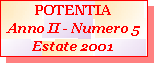 |
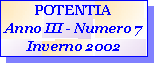 |
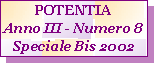 |
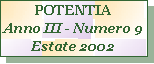 |
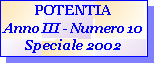 |
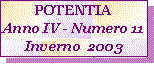 |
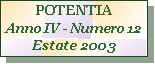 |
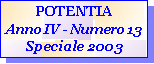 |
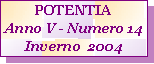 |
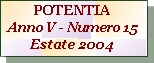 |
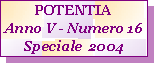 |
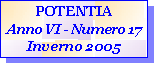 |
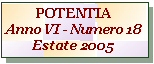 |
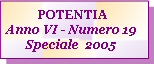 |
|
|
|
|
La
parola italiana sciabica (dialetto sciabbega, da cui
il derivato sciabbegottu per sciabicotto) ha la sua
origine nella lingua araba nella quale il termine šabaka
indica la rete a due ali con sacca centrale. Da
qui (dall’area linguistica araba in generale, in particolare
quella relativa
all’Africa Settentrionale) il vocabolo dovrebbe essere passato
prima nel siciliano per poi invadere le coste italiane e tutto il
quadrante marittimo che interessa la Penisola, visto che si tratta
di un tipo di pesca praticata ovunque nel Mediterraneo.
E
non solo nel Mediterraneo. Per
quanto riguarda l’Italia, Manlio Cortellazzo e Paolo Zolli (Dizionario
etimologico italiano, vol. 5/S-Z-, Zanichelli, Bologna 1988),
che definiscono la sciabica “rete a strascico per piccole
profondità, costituita da due ali e un sacco a maglie diverse”,
scrivono che la voce è attestata già da M. Buonarroti il giovane
nel 1619 e che, in epoca sicuramente assai anteriore essa si trova
nelle forme sciaveca e sciabica negli Statuta, privilegia et consuetudinis
civitatis Cajetae (Gaeta). Indicazioni
più ricche si trovano certo nel Grande Dizionario della Lingua
Italiana di Salvatore Battaglia ( Torino 1996,vol. XVIII,
pp.2/3) dal quale sono tratte le citazioni sotto trascritte. Sulla sciabica intesa come rete: Soderini (Avendola la natura provvista di doppia corteccia - la pianta del sughero - …si dirizza a far pianelle contro all’umido, a far girelle che tengono sospese le sciabiche et altre reti nell’acqua dirette); il sopra citato Buonarroti (Ecco reti passar, quai chiuse e quali / adattate ed acconce in braccio altrui, / come se ‘l giacchio qui trar si dovesse, / o le sciabiche tendere o le ragne); Reina (Si pigliano forse i pesci con la medesima maniera tutti? Certo che no! Si prendono con la sciapica, s’ingannano con l’esca, s’incarcerano con le nasse); Daniello Bartoli (Avendo ogni moltitudine ‘bonos et malos’, come disse Cristo dei pesci tratti con la sciapica, in cui figurò la predicazione dell’Evangelio); lo stesso (e si entra un gran tratto entro mare, e dalla barca gettando la sciabica, si pianta nell’acqua un gran ricinto di mura, e vi si fabbrica una prigione. Fondamenta sono i piombi, che radono il fondo; le cime de’ suveri, che stanno a galla, la compiono. Indi dal lito se ne tirano i capi, e si raccoglie la prigione insieme, e i prigionieri); Targioni Tozzetti (Tralla preda che fecero certi pescatori genovesi colla sciabica, osservai delle torpedini assai piccole); Bresciani (In mare gittaron sciabiche, nasse, rezze e tramagli, ma don Sebastiano non fu trovato né vivo né morto); D’Annunzio (I sugheri che pendono dalla sciabica stesa ad asciugare dopo la pesca); Moretti (Una vasta rete che, trattenuta dai pali, chiudeva uno spazio di mare, v’imprigionava il pesce, lo serrava, lo premeva man mano che uno dei pescatori di sciabica, con le gambe nude nell’acqua, stringeva le reti abbondanti). Sulla
sciabica come imbarcazione:
|
voce
la sentì anche Mingo che stava seduto dentro la sciabica in secco a
tagliare un sughero); Viani (La ciurma della sciabica non ha
limitazione di numero; quanti rematori possono entrare in una
imbarcazione sconquassata, tanti sono gli sciabicotti). Si
va dalla fine del Trecento (Guglielmotti) a noti autori del XX
secolo. Da sciabica, notiamo anche questo, sono stati tratti
i diminutivi sciabichèlla e sciabichétto nonché il verbo sciabicare;
quest’ultimo termine significa, certo, pescare con la
sciabica, ma è presente anche nel gergo della Marina Militare, come
viene qui attestato dal Comandante Nando Carotti: Il ‘gergo
marinaresco’ italiano è un misto di termini e modi di dire che
risalgono ai tempi di costituzione delle più antiche marinerie: e,
date la geografia della Penisola e le tradizioni delle popolazioni
rivierasche, non è difficile immaginare che esso risulti, allo
stato degli atti, ciò che di comune hanno avuto fin dall’inizio
della storia della navigazione soprattutto i liguri, toscani,
campani, veneti, cioè i marinai delle quattro Repubbliche Marinare,
con qualche inserimento
sardo e siciliano (Marina Sarda e Marina Borbonica). Nel caso
specifico dell’interesse che suscita nel lettore il presente
argomento, la sciabica, ecco alcuni esempi di come il termine si sia
per così dire allargato nel gergo marinaresco: un marinaio ‘in
franchigia’, cioè in libera uscita per qualche ora, può dire ai
commilitoni che va ‘a sciabicare’ e tutti capiscono che intende
percorrere su e giù le strade alla ricerca d’una ragazza; quando
comandavo una squadriglia di dragamine, ricevuto l’ordine di
operazioni, informavo il mio tenente (il secondo) che andavamo ‘a
sciabicare’ nella zona tal dei tali; quando, in tempo di guerra,
si ‘pettinava’ il mare in formazione di varie unità alla
ricerca di sommergibili nemici si sapeva bene quanto logorasse i
nervi ‘sciabicare’ anche per parecchi giorni. È corretto
avanzare l’ipotesi che il termine ‘sciabica’ sia stato
introdotto nella Marina Militare Italiana dai suoi elementi liguri,
e specificatamente genovesi, anche se tutti gli uomini di mare sono
estremamente ‘campanilisti’ e non hanno mai perduto del tutto
quella sottile rivalità sommersa che ancora oggi fa dire, ad
esempio, da un genovese, parlando di un veneto, ‘quello lì è
della Marina Veneta’. Ciò non toglie che si facciano tanto di
cappello l’un l’altro. Andiamo
all’estero. In serbo/croato, come succede per l’italiano e il
nostro dialetto, c’è un solo termine per indicare sia la rete che
la barca, vale a dire šabaka, in linea con l’arabo.
Tuttavia, qualche vocabolario da anche neka mreža potegače per
la prima e neka ribarska barka per la seconda. Doppi esiti linguistici in Francia e in Spagna. Nel Vocabolario Francese/Italiano di A.Sergent e A. Strambio (tomo secondo, p.944) si trova la voce Xabega, così spiegata: “Specie di rete composta da due ali e un sacco nel mezzo, con la quale gli spagnoli prendono le sardine”. Stessa
spiegazione, questa volta nel Nouveau Larousse Illustré (tomo
7), per Xabeba. |
Il
francese, però, utilizza anche traîne e lo spagnolo non è
da meno con traìna o traìña per la rete mentre trainera
è la barca. Fin qui, siamo nei limiti del Mare Nostrum, ed è
logico che si trovino termini, come quelli appena citati, che
provengono diritti dal latino; nel caso che ci riguarda vanno
scomodati il verbo trahere o il sostantivo trahea, da
cui anche l’italiano tratta. Tuttavia,
i temini sopra trattati per il francese e lo spagnolo servono ad
indicare, di solito, il tipo di pesca a strascico in generale, nel
quale rientra certo la pesca a sciabica, ma esistono anche vocaboli
più specifici, che sono segnalati da Mario Ferretti, curatore di un
Inventario degli attrezzi da pesca usati nelle Marinerie Italiane,
del quale non conosco l’anno di pubblicazione, edito dal Ministero
della Marina Mercantile, Direzione Generale della pesca marittima.. Ferretti
segnala senne per il francese e red de cerca
per lo spagnolo (per la rete) e, rispettivamente, senne de plage
e arte de playa per la così detta sciabica da spiaggia. Il
fenomeno si è esteso ai mari settentrionali del continente, poiché
troviamo fischtrawler in tedesco e trawl-net in
inglese, dove la radice latina si scorge con facilità. Anche qui va
osservato, come sopra, che i due vocaboli riguardano la pesca a
strascico in generale e allora, ancora una volta, ci soccorre
Ferretti, che per l’inglese ha scovato seine net (per la
rete) e beach seine per sciabica da spiaggia. La
ricerca, se continuata, darebbe certo risultati interessanti e anche
sorprendenti, ma non è esattamente ciò che mi sono proposto in
questa sede, volendo limitarmi ad accennare soltanto alla
caratteristica di universalità del tipo di pesca reso
oggetto del nostro lavoro. Perciò torno verso casa, in Adriatico, dove la sciabica era praticata con particolare intensità. Il fatto, però, non ha prodotto una consistente letteratura in proposito. Pochi e insufficienti, per quello che mi è risultato, gli studi effettuati fino ad ora, rare le presenze nella stessa poesia dialettale. A San Benedetto del Tronto, per esempio, il Circolo dei sambenedettesi ha pubblicato nel 1993 un bellissimo studio di Francesco Palestini sul dialetto della città; le numerose foto inserite nel volume sono tutte commentate con brani poetici (lancette, retare etc..) tranne quella degli sciabbecùtte, forse perché i curatori non ne hanno trovate (o non ne hanno trovate di significative). In ciò a Porto Recanati siamo stati più fortunati, come si potrà leggere nel seguito di questa pubblicazione.
|
In
ogni modo Palestini ha dedicato alla voce sciàbbeche uno dei
commenti più sostanziosi della parte del libro relativa al gergo
sambenedettese. Lo ripropongo per intero: Sciàbbeche,
sciabica: imbarcazione lunga, manovrata a remi e usata per la pesca
strettamente costiera. La sciabica lasciava a terra parte della
ciurma e s’allontanava verso il largo ‘filando’ un cavo (reste)
al quale all’occorrenza veniva aggiunto un secondo, un terzo,
ecc..; dopo l’ultimo cavo e legata ad esso, veniva calata in mare
la rete distesa a largo arco, quasi parallela alla spiaggia; poi la
barca tornava a riva ‘filando’ altrettante reste che
nell’andata. Quivi, gli sciabbecùtte a forza di braccia ed
aiutandosi con gli strùppele, tiravano i cavi a terra
parallelamente da ambo le parti, trainando la rete e restringendo
mano a mano le distanze fra le due ‘squadre’. Era difficile che
il pesce sorpreso nello specchio d’acqua potesse sfuggire: la rete
era tenuta in alto da sugheri e distesa verso il fondo da piombi (le
mazze) e terminava in un ‘sacco’ (lu sacche). Tale
pesca era particolarmente praticata nelle stagioni in cui i pesci
migrano a branchi. Il
vocabolo strùppele (da noi stròppolo) indica la
cordella terminale del collare dello sciabicotto, annodata al cavo
di traino (viene dal greco stróphos > latino stroppus,
con il significato di ‘corda’). Altri
termini dialettali rilevati nell’Inventario
di Mario Ferretti, che elenco senza un ordine preciso di
riferimento: tratta, bragagna, arte da masse, sciabaccone, sciabacca,
palandare, trattolina, sciabichello, gorro. Una ricerca sulla loro
provenienza non è materia di questo lavoro, ma cercherò di
svolgerla prima possibile. Non posso non terminare questa fin troppo rapida rassegna linguistico/filologica senza trascrivere la definizione di sciabica presente nel vocabolario dialettale purtannaru (Fattu pe’ descure – Porto Recanati 1996) redatto anche dal sottoscritto in collaborazione con Marino Scalabroni, scusandomi per l’autocitazione: Sciàbbega, sciabica: tipo di barca da pesca strettamente costiera. Di forma allungata, agile al tocco dei remi, con fondo ampio ed ampio pianale di poppa per le reti. Sulla prua aveva il tipico ornamento sacro costituito dalla croce ed i simboli della passione (eredità dei pescatori di Galilea). Era sospinta dai remi, il poppiero di destra (remu da preme) fungeva da timone. L’equipaggio era formato da 9/10 uomini, più i mozzi. Il riparto del pescato era suddiviso per un quarto al padrone della barca, mentre i restanti tre quarti all’equipaggio.
|
|
Prima di accompagnare il lettore tra storie di
sciabbegotti e nell’esame minuzioso della barca e della rete usate per
l’esercizio del loro mestiere, nonché nelle tecniche di pesca e via …sciabicando,
mi avvalgo di nuovo dell’Inventario degli attrezzi da pesca usati nelle
Marinerie Italiane perché i meno provvisti in materia abbiano almeno
qualche ragguaglio essenziale sull’argomento di cui qui si scrive.
Quanto si sta per leggere sarà oggetto di molti richiami nelle pagine che
seguono. La
sciabica è un antichissimo tipo di rete da pesca usato in passato in
tutte le marinerie. Veniva utilizzata in modo completamente manuale da un
elevato numero di persone (una dozzina). La sciabica è formata da varie
pezze di rete di forma e dimensioni di maglie diverse. Sulle braccia si
hanno maglie abbastanza grandi che diminuiscono gradatamente verso il
centro della rete. Le braccia sono molto lunghe se paragonate al corpo
della rete e al sacco. Questi ultimi anzi in alcuni casi sono così
ridotti da essere semplicemente un prolungamento delle braccia. L’apertura
verticale di bocca è assicurata dai galleggianti sulla lima da sugheri e
dai piombi sulla lima da piombi: mentre la apertura orizzontale è
ottenuta col particolare metodo di calo e di tiro. Secondo
il regolamento di esecuzione della 963 (M.M.M. 1980) la sciabica deve
avere maglie di apertura non inferiore a mm 40. Ciò perché la sciabica
è accumunata alle reti a strascico da cui comunque nettamente si
differenzia per il metodo di calo in mare e per la velocità di tiro che
è indubbiamente più bassa. La
selettività della sciabica è quindi nettamente diversa dalla selettività
della rete a strascico. A velocità bassa infatti le maglie restano più
aperte e quindi il pesce ha maggiori possibilità di fuga….
|
|
Un nome circolava da sempre nella memoria collettiva degli sciabbegotti
evocando posti lontani, esotici, ricchi di fascino e di mistero:
Lagobei. Con una sola indicazione per lo smarrito ricercatore che lo sente
pronunciare per la prima volta: a sud di Suez. Come dire, quasi
nell’universo. Si parlava di sciabbegotti andati a cercar fortuna in terre lontanissime, di viaggi
compiuti su vecchie carrette del mare, tra grandi sacrifici e pericoli, di
pesche miracolose e pure di delitti. Materia buona per una serie intera di
gialli alla Jessica Fletcher, la gentile signora in
giallo della televisione americana. Su
quel nome, a un certo punto, un dubbio: forse bei è da scrivere bay;
proviamo allora a cercare Lagobay o magari Lago Bay. E giù con il dito a
scorrere sull’atlante geografico lungo le coste africane da un oceano
all’altro. Nascita
di un sospetto, originato dalla consultazione di un atlante pubblicato
prima della indipendenza del Mozambico, scovato con tanta fortuna nella
biblioteca del Liceo Campana di Osimo: vi si legge, poco sotto Lourenço
Marques, la capitale (oggi Maputo), scritto fino fino: Baia di Delagoa.
Vuoi vedere che ci siamo? Non può essere che quel sito fosse conosciuto
come Delagoa Bay, diventato Lagobei nella pronuncia dei
nostri sciabbegotti, cui non si poteva certo rimproverare la scarsa
conoscenza dell’inglese o del portoghese? La
conferma che l’ipotesi non è per niente peregrina arriva subito da due
fonti: l’ufficio anagrafe del Comune di Porto Recanati e l’Ambasciata
della Repubblica del Mozambico in Italia. Il
primo sforna una lista di 24 persone (23 uomini, in maggioranza con la
qualifica di marinaio, e una donna) che tra il 1899 e il 1900 hanno
richiesto e ottenuto il passaporto per destinazione Delagao Bay.
Tra il novembre e il dicembre 1899 sono stati rilasciati passaporti a:
Camilletti Teodoro, Cionfrini Bartolomeo, Stefanelli Francesco, Stefanelli
Giuseppe, Stefanelli Nicola, Sorgentini Biagio fornaio, Feliciotti Renato
pescivendolo, Scalabroni Vincenzo, Consolini Luigi e Monachesi Saverio. Tra
gennaio e febbraio del 1900 ottennero invece il documento: Scalabroni
Marone (accompagnato da Scalabroni Angelo di anni 98), Giorgetti Fortunato
(accompagnato da Gaetini Andrea di anni 16), Casali Giuseppe, Pandolfi
Nicola, Giri Paolo, Michelini Toto (Antonio Giuseppe) –canepino-,
Scartozzi Luigi, Rosati Antonio, Flamini Vittorio, Stefanelli Pasquale,
Giri Filippo e Gaetini Vincenza in Moretti, massaia di anni 90. Fuori
degli addetti ai lavori (vale a dire alle operazioni di pesca vere e
proprie), è da notare la presenza di un canepino, cioè dell’artista
del cordame, elemento giudicato indispensabile per una spedizione così
complessa, di un fornaio e di un pescivendolo. Ma
ciò che stupisce sono i due vecchi, la donna novantenne e Angelo
Scalabroni, che ha quasi un secolo di vita. L’altra
informazione è giunta, come ho accennato sopra, per via diplomatica. È
l’Incaricato d’Affari che il 14 giugno ’99 mi scrive
dall’Ambasciata del Mozambico in Roma: … In riferimento alla Sua
richiesta ho il piacere di informarLa che nel secolo scorso l’attuale
Baia di Maputo si chiamava Delagao Bay ed era frequentata da marinai e
pescatori provenienti dalla varie parti del mondo. Non è quindi da
escludere la presenza italiana in un luogo di una certa importanza storica
per il commercio e lo sviluppo economico del sud del Mozambico e del
Sudafrica. La così chiamata Delagao Bay si trova nella città di Maputo,
capitale della Repubblica di Mozambico, dove esiste un archivio con
informazioni documentate sulla vita dell’attuale città di Maputo nei
secoli passati. Un
peccato non poter approfittare del suggerimento relativo all’archivio,
ma ancora oggi andare in Mozambico non è come fare una gita a Loreto. Come
che sia, i nostri andavano di sicuro a lavorare in un posto dove la loro
tecnica di pesca e la loro esperienza, coniugate con la ricchezza di pesce
dei mari tropicali, potevano consentire guadagni piuttosto lauti. In un
ambiente non ideale, anche questo va pur detto, rispetto alle abitudini
dei portorecanatesi. Si pensi che a Lourenço Marques - Maputo, 26 gradi
di latitudine, le temperature medie vanno da 18 a 25 gradi, con 779
millimetri medio annui di precipitazioni, un coefficiente annuo di umidità
di 0,66. In
compenso, non doveva esserci troppa concorrenza; nessuna, credo, dagli
indigeni, se è vero che ancora negli anni Cinquanta del XX secolo, la
pesca era praticata con mezzi rudimentali e dava assai scarsi risultati.
Così ci assicura, per esempio, Luigi Visintin, autore di un documentato Continenti
e Paesi del 1953, edito dall’Istituto Geografico De Agostini di
Novara. Di
queste avventurose spedizioni si occupò pure V., il nostro collaboratore
amante dell’anonimato (vedi Potentia n°4), desiderio che
continuiamo a rispettare. Riporto quanto egli scriveva sull’argomento,
primo tra tutti, intorno alla metà degli anni ’80: Ma ci fu un tempo
che sciabbegotti di Porto Recanati andavano a far la stagione nientemeno
che in Africa, a sud di Suez, in una località chiamata Lagobej. Un fatto
che ormai ricordano solo in pochi, i più vecchi, che accadeva intorno
alla fine del secolo scorso e al principio del nuovo: durante i lunghi
mesi invernali, quando maggiormente si fa sentire il peso della noia e il
desiderio di far qualcosa per la famiglia, un gruppo di sciabbegotti
decide di tentare l’avventura africana, recandosi nei ‘mari rosci’,
colà richiamati dai discorsi di altri portorecanatesi che hanno
attraversato il canale egiziano a bordo di velieri, descrivendolo ricco di
pesce azzurro. S’imbarcano ad Ancona e le prime volte portano con loro
soltanto la rete. Poi, un anno pensano di portarsi laggiù anche una
sciabbega: si era intorno al 1905. Sono Santì Longo (il nonno di Mario el
Cuciniero), el vecchio de Pumì (Monachesi Giuseppe), Fortunato Giri (il
padre de ‘Ntò Longo), Pacì (Bufarini Pacifico), Saeretto de Nanà (Monachesi
Saverio), Cellerì (Fortunato Stefanelli). Quella, però, fu l’ultima
campagna perché il povero Cellerì, che era il cuoco della compagnia e
s’era recato al villaggio a far la spesa, venne ucciso dai negri e il
corpo fatto sparire. Che
storia. Chiarito che Longo sta per ‘alto’ (a beneficio del
lettore non portolotto), c’è però da aggiungere che forse i morti
furono due, anche se non ho alcuna certezza che il fatto raccontato da V.
e quello che segue siano avvenuti nel corso della stessa spedizione. Dunque,
pare che un certo giorno ci sia stata una grossa discussione tra Fortunato
Giri e un altro sciabbegotto di cui scriverò solo l’iniziale del
soprannome, ‘M’. Interviene Mariano, il fratello di Santì Longo, che
si becca una coltellata mortale da M, il quale, per questo, viene
imprigionato dalle autorità portoghesi (il Mozambico era una colonia
lusitana). Qualche tempo dopo, uscito dal carcere, l’assassino vince
molti soldi a una lotteria o comunque diventa ricco (pare in America del
Sud dove si era nel frattempo trasferito) e torna a Porto Recanati. Santì
Longo non ha dimenticato. Va in un’osteria e si fa dare due bicchieri da
mezzo litro, belli grossi e pesanti. Poi si reca nell’osteria dove sa di
trovare M e lo centra con una bicchierata che gli spacca la bocca. Gli
scagnozzi di M, che poteva evidentemente permettersi delle guardie del
corpo, fanno per dare addosso a Santì; questi mostra il suo coltello e
loro, spaventati, si dileguano portandosi via M. Dopo qualche mese,
conseguenza della grave ferita infertagli, M muore. Non
è finita, perché la voce popolare riporterebbe anche la scomparsa di un
terzo sciabbegotto, probabilmente in altro tempo e circostanza rispetto
alla sfortunata ‘impresa’ del 1905, ma per quest’ultimo caso gli
elementi a disposizione, salvo l’indicazione che lo scomparso doveva
essere ‘uno della Cocchina’, sono davvero scarsi. La
sciabbega sbarcò in Argentina alla fine del XIX secolo grazie a un
portorecanatese, così almeno raccontano i vecchi e pure i nostri che
vivono laggiù, nella grande Repubblica sorella. Si
tratta di Giovanni Bronzini, emigrato intorno al 1880, che nel 1891 da
Buenos Aires si trasferì a Mar del Plata. Quando si accorse che gli
argentini praticavano la pesca usando i cavalli come forza trainante,
costruì una barca, la chiamò Marchegiana e insegnò a tutti come
impiegarla per la pesca a sciabica. Giovanni ebbe quattro figli, tra cui
Teodoro, divenuto un grande personaggio della politica argentina e a lungo
sindaco di Mar del Plata. Sarà
certo assai istruttivo poter fare, un giorno, un’analisi comparata tra
la pesca a sciabica sulla costa occidentale e su quella orientale
dell’Adriatico. E’ un compito per il quale chiamo in soccorso gli
amici della rivista sambenedettese Cimbas, egregiamente condotta da
Ugo Marinangeli e Gabriele Cavezzi. Sono certo che raccoglieranno
l’appello; per ora riporto una osservazione di Pietro Brattanich, Regio
Agente Consolare a Zara, inserita in un suo studio Sulle condizioni
della colonia italiana di Zara pubblicato nel Bollettino Consolare,
volume VII, parte II, pp. 382/391, dicembre 1871. Poche righe, che però
mi sembrano aprire a una storia che sospetto straordinaria: Ultima
finalmente, ma non di minore entità, tra le industrie esercitate qui
dagli italiani, è la pesca. Ogni anno per nove mesi scorrono sul mare che
lambe questo distretto varie barche peschereccie di Chioggia, che, col
metodo delle tratte, forniscono il pesce al mercato di Zara. Con ardui
travagli e privazioni, questi valenti marinai, il cui istinto generoso li
consiglia a volte ad atti di coraggio ammirabile, giungono a trarre dalla
loro professione guadagni, se non larghi, almeno sufficienti alla loro
sussistenza. Convennero qui nel 1870 sette compagnie, formate da 21
navigli, con 149 persone d’equipaggio. Una
ricerca di grande interesse è stata condotta per il mondo anglosassone e
persino per la Tasmania e il Giappone, da Alberto Giattini. Eccone, in una
sintesi, il risultato, con l’avvertenza che questo aspetto sarà
sviluppato nei prossimi numeri della nostra Rivista. Chi
pensava che la sciabica fosse una prerogativa della costa marchigiana
decisamente si sbagliava. Cercando nei documenti presenti su Internet (ma
non solo) pubblicati in lingua inglese, si scopre che tale tipo di pesca,
definito ‘beach seine net’ (alla lettera: rete trainata dalla
spiaggia), ha dei corrispettivi molto simili, se non identici, in varie
parti del mondo, alcune anche molto lontane da noi. Verosimilmente
l’ingegno umano, a parità di condizioni, ha determinato soluzioni tra
loro simili. Quello
che spesso rimane difficile da capire, in molti documenti in lingua
inglese, è se il tipo di rete da pesca manovrata da terra corrisponda
alla sciabica (con due cime legate ai bracci ed un
sacco, tanto per intenderci) o è costituita da una semplice rete
rettangolare, calata partendo da terra con andamento a ferro di cavallo, e
poi tirata in secca da due gruppi di pescatori (anche questo sistema,
effettuato spesso con reti da posta e soprattutto da pescatori non
professionisti viene a volte utilizzato). Pertanto, per rimanere nel
certo, possiamo elencare alcuni documenti che si riferiscono sicuramente
al tipo di pesca in questione. Rimane
difficile stabilire quando effettivamente tale tipo di pesca ha iniziato a
esistere. Quello che possiamo ipotizzare è che sia molto antico,
soprattutto per la estrema semplicità del sistema. Se si considera
inoltre che ancora oggi gli indiani della tribù dei Swinomish, presenti
nello stato di Washington (USA) e nel confinante nord-ovest del Canada,
usano questo tipo di rete e considerando con quale precisione tali
popolazioni hanno tramandato per secoli le loro tradizioni, viene da
pensare che la stiano usando veramente da molti anni. Comunque,
una prima definizione fu data da tale Thomas Pennant nel 1769, che ne
definiva le modalità per i pescatori che operavano alla foce del fiume
Towy, nel Galles del sud (Inghilterra). Purtroppo non siamo riusciti a
reperire tale documento, ma sembra che in quella zona la ‘beach seine
net’ serva tutt’ora a catturare salmoni e trote di mare e costituisca
un elemento trainante dell’economia locale. Per
tornare nel continente americano, dove notoriamente non si lascia niente
al caso, la sciabica è stata argomento di studio, commissionato in questo
caso dalla Società dei Pescatori del fiume Fraser, situato nel Labrador
(Canada). In una ricerca sui vari metodi di pesca, di cui ben sei dedicati
alla ‘beach seine net’, questa si rivela un’ottima metodica nella
cattura dei salmoni, con una quantità praticamente inesistente di
‘decessi’ (il pesce non muore nella cattura, potendosi mantenere più
a lungo), caratterizzata dalla presenza di pochi avannotti e con il pesce
scarsamente deteriorato esteticamente (aspetto importante per un pesce
prelibato). Tra gli aspetti negativi viene segnalata la difficoltà di
utilizzo derivante dalle asperità del fondo marino (la nostra ‘presura’)
e la morte rapida dopo la cattura per quella qualità di pesce, definita
da ‘stress’. Sempre
in ambito di ricerca sono state definite delle formule per calcolare
l’area delimitata dalla rete che potrebbe tornare utile, sapendo la
densità media di popolazione ittica di una data zona,
e quello che ci si può aspettare dalla calata se effettuata a
caso. Dai documenti ritrovati su Internet risulta che la
sciabica costituisce anche materia di insegnamento presso il Marine
Science Centre di Pulso, nello Stato di Washington, dove i ragazzi della
scuola superiore possono effettuare dei corsi di biologia marina; il
pescato viene rigorosamente rilasciato o mantenuto in vita e costituisce
oggetto di osservazioni per gli studenti presso il locale acquario. Relativamente
al continente australiano sono invece reperibili documenti provenienti
dalla Tasmania dove la sciabica, dotata di sacco o di una parte rigonfia,
può essere consentita purché non superi i 50 metri di lunghezza, abbia
le maglie non inferiori a 30 mm. e per essere utilizzata richiede una
particolare licenza. Sempre dietro il rilascio di licenza può essere
utilizzata anche da pescatori non professionali. Per
finire, la rete della sciabica viene prodotta, pensate un po’, persino
in Giappone dove una ditta in attività sin dal 1817, che produce reti da
pesca di qualsiasi genere e le invia in tutto il mondo, è ancora attiva
nella produzione di reti per la ‘beach seine net’. Vengono spiegati i
nodi usati, il tipo di filo e i metodi di misurazione della lunghezza e
della profondità della rete. Questo metodo viene consigliato dalla ditta
per catturare sardine, sgombri ed altre qualità di pesce atlantico. Questa
è solo una breve carrellata di curiosità reperite spulciando un po’
qua e un po’ là, non ha sicuramente la pretesa di essere una ricerca
esauriente. Può comunque costituire lo stimolo per approfondire
ulteriormente l’argomento. In
Francia, la pesca con la sciabica (senne) era parecchio praticata
nell’isola d’Oléron (costa atlantica, poco a nord del grande estuario
della Gironda). La particolarità era che qui non si usava nessuna barca.
I pescatori utilizzavano una rete con dei sugheri nella parte alta e dei
piombi in quella bassa; da ogni lato della rete erano fissati due bastoni.
Queste notizie le traggo da un lavoro pubblicato su Internet (www.cabuzel.com/oléron/phsenne.html),
e procuratomi dagli amici Franck e Nathalie Endrivet, dove si legge anche
che la lunghezza della rete dipendeva dal numero dei pescatori impegnati
nella pesca. Meglio se si era in parecchi, perché uno dei segreti di una
buona pesca stava nella velocità dell’operazione di ritiro a terra
della rete; più veloci si era meno pesce riusciva a sfuggire alla
cattura. Si
pescava spesso di notte, poiché
in quelle ore il pesce si avvicina alla costa. I pescatori collegati a uno
dei due bastoni entravano in acqua mantenendosi in posizione
perpendicolare alla riva. Gli altri li seguivano mentre i primi, giunti a
una certa distanza, compievano un movimento rotatorio per portare la rete
parallela alla riva. Fin qui si poteva procedere con relativa lentezza; il
pesce non si rendeva ancora conto del pericolo. Ma occorreva non fare
troppo rumore. Quando invece si trattava di ricondurre a riva la rete,
allora bisognava lavorare in fretta. In questa fase le due squadre si
avvicinavano, arretrando, e così si formava una sorta di tasca con la
rete. Era qui che il pesce rimaneva intrappolato. Michel
Lopez (siamo sempre in Francia, questa volta sul lago di Grand-Lieu, zona
bretone della Loira) ha scritto una storia interessante sulla disputa tra
i monaci del convento di Buzay e certi signorotti locali a proposito dei
diritti di pesca alla senne nel lago in questione. Non riproponiamo
questa storia, non disponiamo dello spazio necessario, ma è opportuno
sottolineare che la pesca alla sciabica si svolgeva anche nei laghi e
soprattutto che il privilegio di esercitarla era considerato davvero non
da poco. Conserviamo tra le nostre carte, nella sede del CSP, il lavoro
del signor Lopez, a disposizione di chi vorrà approfondire l’argomento. Un’ultima
nota sugli sciabbegotti girovaghi del Porto, che ci riporta in Mozambico. Chi
non ricorda Nemesio Castellani, più noto con il soprannome di Trentino?
Personaggio estroso, rappresentato più volte in maniera inimitabile da
Remo Scocco sul palcoscenico della rivista di carnevale, deceduto in Osimo
il 28 luglio 1971, resta nel ricordo popolare inscindibile dalla moglie
Nannina la Quadrata e dal compagno di merende in osteria Gujè Occhibelli.
Bene, Nemesio è nato a Lourenço Marques, come non mancava mai di
ricordare (“Mia madre era ballerina e io sono nato a Lourenço Marques”,
diceva, con una punta di orgoglio). |
|
Per
alcune epoche dispongo di dati certi sulla quantità di barche impiegate
nella sciabica a Porto Recanati, sugli sciabbegotti in attività,
persino sulla quantità di pesce pescato. I
primi documenti sulla sciabica sono in alcuni atti amministrativi del
Comune di Recanati dei primi decenni del XIX secolo. Purtroppo, a suo
tempo, non presi nota dell’esatto sito dei succitati atti
nell’archivio comunale recanatese, ma ricordo bene che in una relazione
firmata dal Gonfaloniere Monaldo Leopardi, si legge che da noi c’erano
una ventina di paranze e qualche sciabica. Si dovrebbe essere
intorno al 1825. Nel 1829/’30, invece, le sciabiche portorecanatesi che
risultano dal prospetto del Numero dei legni nazionali che hanno
esercitato la pesca erano otto. Di
chi fossero le paranze è noto: diverse appartenevano certo a Crispino
Valentini, ras del Porto; le altre erano degli Jorini (Francesco Antonio e
poi il figlio Primo), di Antonio Giorgetti e di pochi altri che erano
riusciti a mettere la testa fuori dai confini della generale miseria dei
marinai dell’epoca. Ma
le sciabiche? Nessun documento, almeno tra quelli conosciuti, ci attesta i
nomi dei proprietari, ma non credo sia sbagliato immaginare che i
portolotti citati sopra ne possedessero qualcuna e che, certo a prezzo di
grandi sacrifici, anche gente di nome Feliciotti, Giri, Matassini, Velluti
e via percorrendo i cognomi più frequenti nella comunità, disponessero
di un legno per rimediare il sostentamento delle rispettive famiglie. Una
cifra sicura non la leggiamo nemmeno nella relazione del segretario
comunale Luigi Petrocchi sul censimento generale della popolazione del
1901. Nel capitolo riservato alla classificazione per condizione e
professione il funzionario ha annotato la voce pescatori con
accanto il numero 375. Non ha fatto la distinzione tra i pescatori
d’altura, o della grande pesca, e quelli di costa o col piede a terra
come si definiscono sciabicotti, nassaroli e simili. E
allora ci viene in soccorso don Francesco Jorini, parroco del Porto dal
1892 al 1907, un personaggio di grande spessore, che, tra le sue molte
iniziative, faceva pure da corrispondente del mensile La pesca ,
pubblicato a San Benedetto del Tronto, organo della Federazione
Marchigiana delle Società per la Pesca, giornale di chiara impronta
cattolica: per le inserzioni occorreva rivolgersi all’amministrazione
della Libreria San Giuseppe, di S. Benedetto, e appena sotto il titolo si
leggeva , come richiamo inequivocabile all’orientamento religioso del
foglio, In verbo tuo laxabo rete. Ave Maris Stella. Nel
primo numero del giornale (1902), il corrispondente da Porto Recanati
(firma in sigla: I = Iorini) scrive: Il numero dei pescatori di Porto
Recanati è di 375 e dei pescivendoli di 114: fra i legni da pesca si
annoverano N. 10 barchetti, N. 40 lance, N. 7 sciabiche ed il pesce
sbarcato nel mese di Novembre senza tener conto delle sciabiche perché il
pesce di queste si vende a ‘occhio’, è stato dai barchetti in media
Cg. 3.550, dalla lance Cg. 32.562 e dalle paranze di S. Benedetto Cg.
4692. Dunque,
il pesce delle sciabiche si vendeva a occhio. Intanto è evidente
che anche a quei tempi molta parte del prodotto non passava per i
controlli del mercato. E poi, la vendita a occhio, era forse un
sistema per ricavare il massimo possibile dal pescato. Non indaghiamo. Il
segretario comunale Petrocchi si riscatta in occasione del censimento
successivo, il quinto, svoltosi nel 1911. Dopo aver annunciato che tra di
noi ci sono 296 tra marinai e pescatori, meno che dieci anni prima quindi,
scrive che la nostra marineria dispone di 8 sciabiche con 80 pescatori.
C’è stato un calo anche in questo settore rispetto al 1901, quando le
sciabiche erano 10 e gli sciabicotti 100 ( La precisazione viene fatta
nella relazione del 1911 e se don Francesco non si era sbagliato, nel giro
di un anno, dal 1901 al 1902, il numero delle sciabiche era dunque
diminuito di tre unità per poi recuperarne una nel 1911. Petrocchi
è certo che l’industria della pesca è cominciata al Porto tra il 1000
e il 1200, epoche in cui sembrava sorgesse presso la nostra spiaggia un
discreto numero di case e capanne, quasi tutte abitate da gente di mare e
da pochi commercianti. Da chi ha preso queste notizie, il segretario
non lo rivela, come resta nel vago la sua affermazione circa la presenza
di una struttura portuale presso la foce del Potenza (sull’argomento è
comunque tornato di recente lo storico Vincenzo Galiè e la discussione è
aperta tra gli specialisti). Quasi certamente agli inizi dovette essere
prevalente la pesca a sciabica, la più immediata, di più facile
realizzazione, ma anche la più precaria. Torniamo
a tempi più vicini. Dopo il censimento del 1911 sembra che il numero
delle sciabiche sia di nuovo salito, e non di poco. Lo deduco dal
contenuto di una delibera di giunta del 10 maggio 1917. Com’è
noto, l’Italia combatte da due anni contro gli Imperi Centrali e il
Paese vive le ristrettezze tipiche di un’economia di guerra. Quel
giorno, la giunta comunale presieduta dal sindaco Giovanni Lucangeli emana
un provvedimento di requisizione di seppie e polpi per i bisogni locali in
base al quale ogni sciabica dovrà cedere quattro chilogrammi di quel tipo
di pesce. E si legge nella circostanza che le sciabiche sono diciotto. Su
questa storia delle requisizioni per cause belliche torneremo ancora; per
ora constatiamo che la flottiglia sciabicotta è cresciuta dal 1911 di più
della metà. Nessuno
si è mai preoccupato gran che di monitorare l’andamento del settore, di
controllare quante sciabiche o quanti sciabicotti fossero in attività nel
prosieguo del tempo. Le cifre che andiamo scrivendo su questi fogli, come
si capisce subito, sono colte, a parte quelle dei censimenti del 1901 e
del 1911, qua e là in documenti di varia natura e appaiono un po’
smagliate, nel senso che l’episodicità dei documenti non permette di
avere ragguagli statistici precisi. Tuttavia,
questo è quel che abbiamo e con il quale dobbiamo arrangiarci. Per
gli anni più recenti si può far riferimento a un progetto di ricerca del
CNR di Ancona, probabilmente dell’inizio degli anni Ottanta, nel quale
si afferma che nella marineria di Portorecanati (sic!), esistono
in attività almeno 20 sciabiche, particolarmente interessate alla pesca
del Bianchetto di Acciuga, nel periodo autunnale. Stante il livello
artigianale dell’attività, è attualmente impossibile quantificarla,
anche perché gran parte del pescato sfugge a qualsiasi rilevazione
statistica (il vizio non si è perso per strada dai tempi di don
Francesco Jorini e chissà da quanto prima). Ritengo
che quando il CNR scriveva di 20 sciabiche considerasse nel numero
soprattutto le imbarcazioni di quattro/cinque metri, a motore, che ormai
già da tempo avevano preso il posto della sciabica classica, a remi,
sulla quale ci soffermeremo ampiamente più avanti. Segnalo
infine che in un documento a cura dell’Associazione Produttori, della
Cooperativa Piccola Pesca e dell’Associazione Mogli Pescatori, datato 31
ottobre 1987, le sciabiche date per esistenti e operanti sono 10. Oggi,
in pratica, non è più possibile parlare di sciabiche: la pesca con
l’omonima rete è consentita entro limiti assai ristretti e l’attività
relativa si è quasi spenta perché ovviamente gli operatori si sono dati
a tipi di pesca più remunerativi. Al momento in cui firmo questo numero
della Rivista ho notizia di una sola sciabica in attività. Riporto
con piacere una pagina inviatami da Alessandro Mordini, adesso residente
in Ancona, che mi fornisce un elenco delle sciabiche in attività al Porto
negli anni tra il 1946 e il ’48. Eccolo, procedendo da sud a
nord: -
Saè del
Cucinièru, Saverio Panetti; aveva una sciabica piccola in confronto alle
altre e lo scalo era nei pressi del Cantiere Navale; Concludiamo
questo capitolo, ripetendo qualcuno dei dati appena citati (i periodi di
riferimento non coincidono del tutto), con un altro intervento (non sarà
l’ultimo) del nostro amico V., il quale si distingue anche, anticipando
lo scrittore siciliano Camilleri, il creatore del personaggio del
commissario Montalbano, per l’altalena della sua prosa tra l’italiano
e il dialetto: Una volta ggió la marina c’era la sciabbega de ‘Incè
de ‘Ndrè de Carlo (Giri Vincenzo), la Mirabella de Magnaró (Giri
Giuseppe), quella de Gerì de Sudo (Piangerelli Geremia), le uniche a
portare sul pizzetto de prua una piccola croce in legno, alta sui quaranta
centimetri con sopra una coroncina di palme benedette, prese in chiesa la
domenica delle Palme. E poi ‘rtiravano la Bianchina de Francé de Grespì
del Moro (Giri Michele), la Vincenzina de ccì Pacchió (Scalabroni
Pasquale), de Cellerì (Stefanelli), de Pumì (Monachesi Giuseppe), tutti
sciabbegotti di antica tradizione familiare. Ai giorni nostri (metà degli anni Ottanta) lavorano un po’ saltuariamente, non solo per mancanza di braccia, sempre più difficili da reperire, ma anche per le varie leggine che ne limitano l’attività, a protezione della fauna ittica, le sciabiche de zì Gerì, del Cuciniero (Panetti Mario), de Pippetto (Valentini), de Nito de Cittadì (Annito Cittadini), de Natello de Castellà (Castellani Fortunato). Da ricordare anche le sciabiche di Giggiu Sciai, di ‘Tilio de Badiale o Zaccarani (Attilio Sabbatini), di Sciampagnó e ‘Ngiulì Bruni. |
|
Scuoti
e cala, vale a dire, fai le cose con ordine e anche con celerità perché
qui, sulla sciabica, non c’è tempo da perdere. Il
destino dello sciabicotto è racchiuso nell’amara sintesi dei due verbi:
per lui il lavoro ha poche soste, e più soste ci sono meno soldi gli
vengono in tasca. Una vita passata tra gli avvistamenti da terra, i vari
alle prime ore del giorno (meglio dire le ultime della notte), il lancio
in mare della rete e la sua lenta ‘rtirata camminando
all’indietro sotto il sole che lo cuoce. Simbolo
del suo stato, il cullaru, la tracolla di tela con due anelli di
corda (sacche) alle estremità; qui è infilata una cordicella, la risa,
che termina con un nodo detto croccu. Con questa tracolla si
riusciva a fare più forza nel momento del massimo impegno. Avviciniamoci
dunque con rispetto agli attrezzi e agli strumenti di questo mondo, tra i
quali, primo, è certo la barca. Per
farlo utilizzerò un lavoro che il CSP ha redatto nel luglio 1999,
parzialmente utilizzato da altri, e insieme farò ancora ricorso alle
ricerche dell’amico V. A
differenza di quanto accade altrove, dove in genere il termine sciabica
indica la rete, qui da noi esso indica soprattutto la barca. La
sciabica, quella classica, era un natante strutturato per la pesca
sottocosta. Agile di forma per consentire velocità e manovrabilità,
aveva la prua sottile e profilata per meglio tagliare l’onda. La barca
era sui sette metri, il fondo nero incatramato col black (pegola) e
la parte restante attorno grigia. Di
poppa la struttura era più tozza, con ampio pianale (gràttena o
gràtta) sul quale era sistemata la grande rete da pesca. Lì si
piazzava, dietro a tutti, in piedi, il paró per avvistare le rusciùre,
cioè i branchi di pesce in transito. In genere il paró era anche
il proprietario. Soltanto Vincenzo Giri (‘Incè de ‘Ndrè de Carlo,
che vuol dire Vincenzo figlio di Andrea a sua volta figlio di Carlo) si
limitava ad essere il padrone che non navigava lasciando il compito di paró
a Lisà Bufarini detto Pelài. A
prua si trovavano l’ancora e il cordame per l’ancoraggio nonché un
vano dove si collocavano cibarie e cose varie ad uso dell’equipaggio.
Sotto la gràttena c’era un altro spazio per attrezzature
secondarie. Il
natante disponeva di quattro remi ognuno dei quali aveva un nome. C’era
il remu de prua, che era il primo verso prua, meglio noto come prueru:
era un remo piccolo e si trovava alla sinistra del paró; sulla
banda opposta si trovava il remo grosso di dritta, al centro della barca,
chiamato bocca de gola; il gaezzu stava a sinistra ed era il
remo più grosso, tanto che a volte occorrevano due o tre persone per
manovrarlo, stando attenti a non farlo girare; infine, il remu da preme,
più piccolo rispetto agli altri, che fungeva da guida, alla destra del paró.
L’ultimo remo spesso era usato dal capobarca o dallo sciabicotto più
anziano perché aveva la funzione di timone. I
vogatori remavano stando seduti sui bangarelli, tavole assai
resistenti poste di traverso, con la funzione di meglio legare tra loro le
strutture laterali della barca. Per la spinta i rematori si servivano del puntapia
(puntapiedi), un asse posto in basso del bangarellu, circa mezzo
metro in avanti. Sempre
a poppa c’era la barbetta, una cima di pochi metri che serviva
per trattenere la sciabica in prossimità della costa senza ricorrere
all’ancora. A
volte ci si serviva dell’alzana, corda per il traino della
sciabica quando si tornava a casa venendo contro corrente. La
cuertina de prua era il sito che serviva per il ferricciolo e per
depositare la resta (vedi di seguito) e dove si sedevano i
bambinetti di 9/10 anni alle loro prime avventure in mare. Qualche
particolare sul remo della sciabica. La cordicella posta attorno al centro
dell’attrezzo, chiamato girò, costituiva la ‘mbarunatura,
che aveva la funzione di impedirne il lento consumo; stròppolo era
chiamata anche la cordicella che si avvolgeva attorno al remo per vogare e
che serviva a tenerlo appoggiato allo schelmo, fatto di un
cavicchio di ferro o di legno. Lo
strumento che sempre accompagnava la fatica dello sciabicotto, e che ha
finito per assumere il valore di simbolo del mestiere, era el cullaru,
una fascia a tracolla con un’appendice di 40/50 centimetri, di corda,
che si avviluppava attorno alla resta e alla rete. Su di esso si faceva
forza con tutto il peso del corpo. Lo
sciabbegottu è una figura che conserva ancora freschezza e colore
nell’immaginario popolare; basta ripercorrere i versi riportati nel
capitolo ‘letterario’ di questo lavoro per percepire l’emozione che
si prova di fronte allo spettacolo, sempre solenne, di cui sono
protagonisti l’uomo e il mare. Come
si è già scritto più volte, l’equipaggio, di solito 10/12 sciabbegotti,
era al comando di un paró. Uno sciabicotto faceva da barcaru
ed era quello che restava a bordo durante la cala; era quasi sempre il più
vecchio, addetto a raccogliere le reste tirandole da terra, a pulire la
barca, a cernire il pesce nella cuffetta (cesta piccola). C’erano
infine i murè, i più giovani, addetti ai servizi (portare la
colazione, per esempio). Allo
sciabicotto non si richiedevano doti particolari, solo buone braccia e
buone gambe per sopportare la fatica di un lavoro davvero duro. Per
tradizione le ciurme venivano formate ogni anno il 19 marzo, giorno di san
Giuseppe, e sciolte il 30 novembre in concomitanza con la festa di
Sant’Andrea (discepolo di Giovanni Battista e fratello di San Pietro,
pescatore a Cafarnao). Nella chiesetta del Suffragio c’è una pala
d’altare attribuita al Maratta e trasferitavi nel 1829 dalla chiesa
interna al castello svevo, in quell’anno demolita; rappresenta la
Madonna Addolorata confortata da San Francesco di Paola e da Sant’Andrea
che, proprio perché pescatore, tiene in mano una mugèlla (cefalo)
e per questo è stato battezzato qui da noi come Sant’Andrè de la
mugèlla. E’ lui il patrono degli sciabbegotti ed è nella
chiesetta del Suffragio che si conclude, con la messa, la stagione della
sciabica. Un
tempo alcuni sciabicotti, liberi da impegni fino al marzo successivo, si
imbarcavano per l’Argentina dove andavano a lavorare alla cossecha,
vale a dire alla raccolta del formentone; in marzo tornavano per
riprendere il cullaru. Gli Argentini li chiamavano golondrinas,
perché arrivavano e ripartivano come le rondini. Successe
pure che diversi non tornarono più stabilendosi nella Repubblica
sudamericana per sempre. Ma questa è una storia che racconteremo
un’altra volta. Negli
ultimi tempi dell’epopea della sciabica le ciurme erano composte anche
da giovani coinvolti per periodi limitati nell’attività marinara; si
trattava soprattutto di studenti che lo facevano per disporre di qualche
soldo da non domandare ai genitori. Non mancavano nemmeno operai e
artigiani, che così arrotondavano i loro guadagni. La
lunghezza della rete si aggirava in media sui 100 metri, qualcuna arrivava
anche a 120 metri, vale a dire 50/60 metri per braccio; a mano a mano che
si procedeva verso il sacco le maglie diventavano sempre più fitte.
L’imboccatura del sacco era munita superiormente di sugheri (scòrzi)
e inferiormente di piombi per far sì che la rete sul fondo del mare si
aprisse per ingoiare i pesci. Il sacco si prolungava ai lati con due
lunghissime ali che per l’azione opposta dei piombi e dei sugheri,
sistemati in opportune lime, si aprivano in verticale e bloccavano
la via d’uscita del pesce. Una
rete da sciabica si compone di molte parti, che qui si elencano in ordine
di avvicinamento al sacco: -
el gaezzu,
da non confondere con il remo, è la cimetta che si scaglia dalla barca a
chi sta a terra; era sempre attaccato alla mazza la quale era chiamata
croce quando si tirava in terra la rete e la si scuoteva. -
la resta, la cui lunghezza varia dai 30 metri in su (ma su
questa misura non c’è unanimità): a seconda della distanza da riva che
si vuol raggiungere si mettono più reste ed ecco perché gli sciabicotti
dicono ‘emu calatu a dó reste, a quattru reste…’; -
la mazza,
una robusta striscia di legno, lunga 60/70 centimetri, con le estremità a
forma di V sulla quale fanno forza le reste e le lime;
divarica la linea dei sugheri da quella dei piombi e ad essa sono
collegati il gaezzu , il tarozzu (corda di canapa di una
ventina di metri) e la resta; essa indica l’inizio vero e
proprio della rete, il braccio; le cuciture che uniscono mazze e parè
si chiamano fiezze; -
el
bracciu (parè),
ha maglie da 70 mm. e qui iniziano i galleggianti (lima da scorzu)
e i piombi (lima da piombu); -
i
spessi,
maglie da 35 mm., pezzo di rete attaccato ai bracci, pure con galleggianti
e piombi; -
ell’ala,
maglie da 10/12 mm., faceva parte degli spessi; -
bocca
de gola
(anche qui non confondere con l’omonimo remo) maglie da 8 mm.; siamo
all’entrata del sacco, detta anche carió (da scorzu e da piombu)
nella parte superiore; - la manica oppure saccu, con maglie sempre più fitte (i fitti), fino a che negli ultimi 20 cm, cioè nel fonnu, c’è la camera della morte. Una
magliaccia e un giubbetto per coprirsi dal freddo, a volte un’incerata
per riparo dalla pioggia, pantaloni mal ridotti (le salparelle) e
un paio di zoccoli: si partiva così per la sciabica, alle due o alle tre
di notte o in qualsiasi altro momento della giornata fosse necessario. Il
lavoro era legato in modo diretto alle migrazioni del pesce nei periodi più
caldi dell’anno (ma nell’immediato secondo dopoguerra si varava anche
d’inverno). In genere si pescava scalzi; solo a partire dagli anni
Trenta hanno fatto il loro ingresso gli stivali (per i più fortunati),
che sembra venissero da Zara. Quando
arrivava novembre veniva cacciata l’anguilla. Il
territorio di pesca era soprattutto costituito dai nove chilometri di
costa portorecanatese, dal Musone fino al Potenza (quest’ultimo sito di
cala era detto màsculu, con la distinzione ‘de sora’ o ‘de
sotta’ a seconda che si fosse sull’uno o l’altro lato della sbocca
del fiume). Spesso
accadeva che si restasse fuori tutta la giornata, lavorando in
continuazione e interrompendosi soltanto per mangiare el pà, la
colazione preparata dalle donne e che i più giovani (i murè)
venivano mandati a prendere in paese. I
principali tipi di voga erano tre. La ‘oga lesta serviva quando
si andava a pescare lontano e allora ci si dava il cambio a metà
percorso; per avanzare più veloci ci si alzava dal bangarèllu
puntando i piedi su una stanga situata in basso, detta ‘ppòggia pia
o puntapia (dove si appoggiano i piedi). La
‘oga longa consisteva, restando seduti, in una remata lunga e
possente per lunghe distanze; con la ‘oga battuta i rematori si
alzavano e si sedevano dai e sui bancarelli, di solito per velocizzare la
calata. Tra
gli sciabbegotti c’era una sorta di codice da rispettare, regole
a volte assai precise la più importante delle quali era che chi lanciava
per primo il capu della corda aveva diritto di precedenza nel
calare la rete. A
questo proposito va detto che la parte spettacolare era nella gara a
scegliere il posto migliore dove effettuare la cala, come nel modo
di controllarsi a vicenda spiando ognuno le mosse dell’altro. Quando
si calava la rete il paró prendeva la cima della resta,
ne raccoglieva una quindicina di metri avvolgendola in piccoli cerchi e
poi la lanciava urlando al murè di venire a prendere il capo. Il
lancio doveva essere tale da far raggiungere terra al capo e nel frattempo
il paró diceva ai rematori: ‘scìa’, comandava cioè di
tenere fermo il remo per far prendere alla barca la direzione voluta. C’era
competizione anche per toccare terra per primi: se capitava che due
imbarcazioni calassero poco distanti l’una dall’altra, da quella che
arrivava prima a toccare la spiaggia si alzavano i remi in aria in segno
di vittoria. Non
di corsa, ma a passo veloce Dopo
la cernita sulla spiaggia, il pesce veniva sistemato dentro delle còffe
o dei pagnèri (i secondi di dimensioni più piccole) fatti di
vengo e di canna; se non ce ne erano a sufficienza si chiedevano ai
contadini delle ceste di grosse dimensioni e anche i cariuletti per
portare il pesce al mercato (i rapporti con la campagna erano più stretti
di quanto si creda). Dentro i manici di questi contenitori veniva infilato
un bastone di legno che andava a poggiare sulle spalle dei due sciabbegotti
incaricati di portare il pesce in paese; non di corsa, come erroneamente
si fa credere, ma a passo svelto e stando bene attenti a non perdere nulla
per strada, anche per evitare di subire il rimprovero del paró.
Per pesi sopportabili, il lavoro poteva essere svolto da un solo
sciabicotto, che trasportava sempre due coffe. Anche
questa era un’arte; indovinare cioè la cadenza giusta per non essere
superati dalla concorrenza e, al tempo stesso,
giungere alla meta con la coffa piena come alla partenza. Arrivare
per primi significava vendere il prodotto a prezzi più convenienti. E
magari spargere tra la gente la voce che si comprasse subito il pesce già
sul posto, ché gli altri non avevano pescato nulla! A
volte si percorrevano distanze molto lunghe, soprattutto per chi doveva
farlo a piedi gravato del peso delle coffe: non era raro marciare
per diversi chilometri su strade non asfaltate né imbrecciate. Solo verso
la fine degli anni Cinquanta sono cominciati ad apparire carrozzini e
biciclette, seguiti poi dai più comodi Apetti. I
portatori delle còffe potevano viaggiare da soli o in coppia, come
rilevato poco sopra, a seconda della quantità di pesce da trasportare; di
norma erano scalzi e proteggevano la spalla dove poggiava il bastone
guarnendola con il cullàru o con la camigiòla (o camigiàcciu)
oppure con il berettu o anche, infine, con uno straccio rimediato
in qualche modo. C’era
da darsi da fare per riuscire a tornare in tempo a caricare nelle còffe
il risultato di un’altra calata. Il paró sapeva quanto era
giusto aspettare, ciò dipendeva dalla distanza da percorrere. Ma se per
caso l’incaricato del trasporto impiegava più tempo del previsto,
succedeva spesso che quando giungeva, stanco morto, a trenta/quaranta
metri di distanza venisse preso a sassate dallo stesso, impietoso paró
e dagli altri colleghi. La
divisione del guadagno veniva effettuata nel rispetto di modalità
antiche, ma assai efficaci, basate su un criterio di sostanziale equità: una
quartarola, vale a dire il 25% di una parte, andava al ragazzino di 9,
10, 11 anni; mezza parte era per i ragazzi più grandi, ammesso che
facessero bene il loro lavoro; tre quartarole sempre ai ragazzi più
grandi se erano ancora più bravi di quelli di prima; una parte
allo sciabicotto. C’erano
poi quelli che, oltre alla parte, prendevano una quartarola in più,
ed erano lo sciabicotto che sapeva calare la rete e quello che sapeva
vogare con tutti e quattro i remi. Quando
si rientrava a casa, nella mattinata, si metteva a spandere la rete sulla
spiaggia. I più giovani erano incaricati di raccoglierla, una volta
asciutta, in genere prima di mezzogiorno. Chi non era puntuale buttaa
ggió, cioè pagava una penale. Per un certo periodo, negli anni Cinquanta, gli sciabicotti avevano diritto, quando non si pescava (in inverno) a una sorta di moderna cassa integrazione consistente in poche lire. Sostiene
l’amico V., da cui pesco il piccolo glossario che segue, che i
portorecanatesi abbiano un’origine levantina e che ciò si rispecchi
inevitabilmente in un linguaggio fatto di immagini grottesche create da
una vivida fantasia. Ancor
di più queste caratteristiche sarebbero evidenti nei modi di dire degli
sciabicotti, che nel tempo hanno saputo inventare detti e combinazioni di
immagini assai saldamente agganciati a quanto si voleva rappresentare. Eccone
un campionario, senza alcuna pretesa di ritenerlo esaustivo. Fa’
la croce: raccogliere
la rete. Magnà
el cappó:
ammucchiare la rete appena tratta dall’acqua, secondo alcuni, ma per
altri sarebbe frase incitante ad essere svelti e bravi perché così ci si
potrà aspettare un buon guadagno. ‘Gnà
murì pe’ campà:
per vivere bisogna morire, detto per mettere in risalto la durezza del
lavoro. E’
bianghi cume i buffi de neve:
sono i lattarì (novellame), detti anche la magnana. Daje,
ché quessi nun è finanzieri:
si diceva quando la rete emergeva carica di lattarì, che sono
assai più buoni dei sarduncì, immagine dei finanzieri,
‘cattivi’ con gli sciabicotti a causa delle multe che essi contestano
loro abbastanza spesso. Scòte
e càla:
scuoti e cala la rete, prima che puoi; invito alla rapidità nel lavoro. Fàtte
da’ la chiae de la mazza:
è una burla per far correre un murè da un
braccio all’altro. E
tantu sai nonnu Fiore el brigante!:
non sei davvero come Fiore il brigante, che doveva essere uno sciabicotto
assai sveglio nel lavoro; la frase veniva infatti rivolta a qualcuno un
po’ ‘incantato’. Nun
tirate a scossi:
invito a tirare la rete con continuità evitando scossoni. Fate
ala:
allargate la rete dalla parte degli spessi (dopo averla scossa una
volta che è stata tirata in terra la parte contenente gli scorzi
e i piombi), il che permetteva di spujà la manica,
cioè constatare la qualità e quantità del pescato; Rete
grossa ‘mbraga maru, ‘mbraga pesciu:
bisogna fare una calata ad ampio raggio per avere maggiori possibilità di
prendere una più grande quantità di pesce. El
pesciu smaja:
quando il pesce rischia di scappare dalle maglie della rete; Dréntu
cul passu:
stringere i bracci della rete per farla venire diritta a terra.. Maneggià:
mettere da parte il cullaru e tirare con le mani. Nun
la fa’ scagarellà ‘sa croce:
non far cadere la rete quando la porti a bordo. Dàje
ch’edè la cala de la ‘endegna:
coraggio, ché questa è l’ultima cala e può darsi che sia quella
buona. Spòja
el pizzàle (spizzàla):
togliere il pesce dal pizzo, cioè dall’angolo della manica, quello in
fondo. Calàmu
a la sversa:
caliamo la rete alla rovescia rispetto alla posizione di partenza. Invece
di buttare fuori il sacco, come era normale fare, lo si buttava dentro,
cioè verso terra. Bisognava fare particolare attenzione in questa
operazione per evitare che, finita la calata, la manica (il sacco) si
aggrovigliasse. Sunà
la resta:
raccogliere le corde. Scioje
el duppì:
districare la corda sciogliendo per prima la cima doppia. Va’
‘n teretta, el pesciu è mestuuuuu:
vai verso terra ché il sacco è stato gettato in mare. Lo grida il paró
ordinando di virare gradualmente, ma con velocità verso terra per mettere
in mezzo il pesce. Raccomanda anche: Rema a bocca de gola. Altra
espressione similare: calamu a tera ‘ia (caliamo vicino terra) L’agura
fa becchettu:
quando si vede il becco, cioè il muso dell’aguglia, che è stanca
perché cacciata da pesci più grossi. Si dice anche che l’agura se
‘nciambella. E
tantu le rusciure ce ‘ffoga:
per dire che l’agora non c’è affatto. La
lattarina va a la messa:
si dice quando nella rete è finita troppa lattarina, che poi non si
riesce a vendere. Il richiamo alla messa, forse, significa che questa
volta si tornerà a mani vuote. Come quando si torna dalla messa (ma non
sono sicuro che sia così). Fàjela
sentì de dietru la rete:
mettere più forza rispetto a quello che sta davanti. Scòte,
scòte:
esclamazione degli sciabicotti quando fanno cerchio intorno al sacco per
vedere il risultato della pescata. Nun
è notte a Cinguli:
vecchio proverbio marinaro per dire che c’è tempo per fare ancora
qualche calata. Il richiamo a Cingoli è forse dovuto al fatto che dalla
nostra costa si vede assai bene il monte di Cingoli, il San Vicino. La
manica ride:
quando mancano pochi metri per tirare a riva un sacco che appare già
pieno perché il pesce guizza da tutte le parti e l’acqua sembra
bollire.
Al
contrario, se non c’era movimento di corrente: l’acqua è stanga/
mette fora/ ‘iene in tera. La
presenza della luna non era certo dimenticata, anche perché la posizione
del satellite della terra determinava il corso dell’acqua e quindi il
modo di calare la rete. Si prenda ad esempio il detto gobba a leante
luna calante, gobba a punente luna crescente. Oppure: luna colca,
marinai in pia (se il quarto di luna è disposto orizzontalmente il
marinaio deve stare all’erta); luna in pia, marinaio colco ( se
il quarto di luna è disposto in verticale, il marinaio può dormire). Anche
il sole aveva la sua parte. Si diceva ‘emu calatu ch’el sole era
altu ‘na ccànna ( o due o tre) intendendosi
il termine ‘canna’ come unità di misura rapportata alla dimensione
media di una canna.
|
|
Riproponiamo un vecchio articolo di Marino Scalabroni,
apparso nella prima pubblicazione del Centro Studi Portorecanatesi (“La
Rigòla”) risalente al giugno 1983 e centrato proprio sulla sciabica. La
recente polemica sorta tra una delle più antiche categorie di lavoratori
del mare e le autorità regionali, ci spinge a spezzare una lancia
–anche se solamente sul piano sentimentale- a favore degli sciabbegotti,
delle loro tradizioni e della loro storia. Per
questo non entriamo nel merito delle ragioni assunte dal legislatore: non
è la sede giusta e ci mancano dati seri, reali e concreti per fare
veramente collimare gli interessi di questi nobili lavoratori del mare con
quelli enunciati dagli esperti di pesca d’altura e da sensibili
sentinelle ecologiste. Ci
spinge a parlare di SCIABBEGHE e di SCIABBEGOTTI il bisogno di restituire
a questo modo di vivere la vita del mare tutto il valore che merita
dinnanzi alla storia della fatica umana e dinnanzi al valore dell’uomo
che si realizza nel suo lavoro. Affrontare l’argomento sotto l’aspetto
socio-economico, politico e tecnologico ci porterebbe lontano, ben oltre i
limiti imposti dalla natura della nostra pubblicazione, ma sostenere il
valore di questa attività, la cui origine si perde nella notte dei tempi
e che senz’altro rappresenta la forma più antica del rapporto
uomo-mare, è giusto e doveroso. E ciò anche presupponendo la supremazia
del marinaro, che affrontava il mare aperto affidando la propria vita alla
fragilità della lancetta, al capriccio degli elementi e alla sua capacità
di intuirli e di presentirli, supremazia che quasi sanzionava la
subordinazione sociale persino nelle rituali e lapidarie sentenze dei
proverbi strettamente e tipicamente purtannari: “ ‘Ete dattu la carta
de la musega ‘nte le ma’ d’un sciabbegottu” – “U’
sciabbegottu n’è bonu mancu a fa’ el testemoniu”. Il
tempo, tuttavia, con la sua inflessibile logica ha reso giustizia: parlare
dei barchetti o delle lancette ormai è rivivere momenti di vita
profondamente radicati nella nostra memoria collettiva. Oggi le moderne
tecniche meccaniche ed elettroniche, la biologia marina, la stessa
meteorologia hanno rivoluzionato i modi e i mezzi per vivere e lavorare
sul mare. La potenza dei motori, le tecniche di pesca di concezione
avanzata, la strumentazione elettronica di ricerca e di prevenzione fanno
del motopeschereccio il natante principe per lo sfruttamento del mare
aperto, relegando a mero valore di mito l’antica epopea della vela. Ma
la SCIABBEGA resiste ancora. Continua ad essere presente nell’economia e
nell’attività quotidiana. La SCIABBEGA, un natante privo di alberatura,
di agile forma e specifico per il tipo di pesca cui è usato. Nei tempi
andati tali imbarcazioni erano più numerose e gli equipaggi costituivano
un settore ben preciso nell’economia e nel costume locali. Quella degli
sciabbegotti è sempre stata una categoria particolare, spesso snobbata
dai veri uomini di mare che ne usavano l’epiteto in senso denigratorio.
Gli equipaggi si raggruppavano in clan, perché tale pesca si tramandava
di generazione nella stessa famiglia, ed erano completati con personale
anziano sbarcato dalle lancette e talvolta con sottoccupati che limitavano
il loro lavoro alle attività della ciurma di terra. L’avvento
del motore ha sollevato anche questo settore della fatica umana, senza
tuttavia aprire nuove prospettive. Infatti l’industrializzazione della
pesca ha portato una maggiore autonomia dell’uomo nei confronti della
capricciosa solidarietà della natura: oggi il pescatore chiede un mare
relativamente calmo per poter procedere nel suo lavoro. Ma questo
sussidio, d’altro canto prezioso, ha favorito la rapida riduzione della
fauna ittica ed il depauperamento dei bassi fondali sotto costa. Oggi come
ieri l’attività dello sciabbegotto resta essenzialmente stagionale,
legata al passaggio migratorio di branchi di pesci. La sciabbega tuttavia
merita un ricordo proprio perché nella vita e nel costume locali ha
rappresentato un valore culturale veramente valido. E’ giusto
ricordarla. E ricordarla come era quando riempiva di sé i pomeriggi di
pesca avanti agli occhi ammirati e curiosi di tanti turisti. Originariamente
la sciabbega era mossa a forza di remi –ognuno dei quali aveva un nome
ben preciso- ed era pilotata dal primo remo poppiero di destra, il ‘remu
da preme’ che fungeva da timone. Preliminare
alla pesca è l’avvistamento: basta che l’occhio esperto veda lo
sbalzo a fior d’acqua di un cefalo, la mugella, o il leggero incresparsi
di un’area di mare per il passaggio di un branco di pesci turchini, per
vedere scattare le sciabbeghe che prendono il largo dopo aver lasciato
alla ciurma di terra la resta per la traina. Con rapide remate, ritmate
dagli incitamenti del capopesca, l’agile scafo punta verso il largo,
mentre da poppa con sapienti e agili gesti, viene calata in mare la prima
ampia e lunghissima ala della rete, che sotto il pelo dell’acqua si
distende verticalmente e crea una vera parete capace di trattenere e
deviare la corsa del pesce. Poi la sciabbega compie una grande curva al
centro della quale si trova il punto d’immersione del sacco della rete. Il
lancio deve essere eseguito con mossa esperta onde farlo affondare in modo
da distendersi e d’aprirsi. Quindi, sempre a velocità sostenuta, si
conclude la circoscrizione di una cospicua parte di mare distendendo la
seconda ala. Quando finalmente il natante tocca terra e gli uomini
abbandonano le manovre per formare la seconda ciurma di traino, tutto il
fervore, tutti gli incitamenti svaniscono. Mentre
la sciabbega governata da un mozzo (per altri, invece, è il ‘barcaru’
a farlo, un marinaio anziano) resta sul bagnasciuga, le due ciurme, con
passi misurati, lenti, iniziano a salpare la grande e pesante rete. Sul
mare la corona di galleggiamento sembra tanto lontana e per questo più
imponente. I sugheri sembrano ancorati a un mare denso, resistente. E gli
uomini arrancando a ritroso, piegati dal ‘cullaru’, raccorciano la
distanza tra le due squadre e, progressivamente, dalla rete. Il tempo
lento, i gesti sempre uguali. Ogni uomo, l’ultimo della catena, ogni
tanto lascia la presa e si porta sulla battigia per riallacciare il suo
‘cullaru’ alla resta. E dietro qualcuno provvede a riordinare il
cordame ancora fradicio d’acqua. La
rete intanto si restringe e la sacca vorace, spalancata, nera, incomincia
a riempirsi di alghe, granchi, zanchette e, se Dio vuole, buon pesce
turchino da riempirci le ceste. Ormai gli uomini stringono tra le mani la
rete e si confondono tutti in un solo gruppo: due file strette di schiene
che tirano e altri che si inframezzano per tutte le operazioni di recupero
del sacco. Già qualche previsione si azzarda se negli ultimi metri
quadrati di mare ancora chiuso dai galleggianti ferve un brulichio o si
corrusca l’acqua. Allora la fatica non si sente più, le esclamazioni di
speranza eccitano all’ultimo sforzo, la trazione si fa più calzante
finché appare il sacco che il moto ondoso gonfia e riduce come il ventre
mostruoso di un essere abissale. Ormai
è l’ora della verità per questi uomini pazienti. Quando è andata
bene, la sacca è colma, il pesce s’ammucchia esausto tra una
fantasmagoria di squame lucenti lanciate ovunque dall’agitarsi frenetico
del pesce ancor vivo. Le ceste si riempiono nella massa ancora acquosa,
mentre mani esperte, rapidamente, cerniscono tra il pescato. Se la
giornata è buona, si riparte ancora per ritentare. Ma non è sempre così.
Talvolta il premio alla fatica è esiguo: dentro la sacca poche manciate
di frittura che non converrà nemmeno portare al mercato. Uomini
di mare anche loro con i sensi sempre tesi a percepire il tempo, a
presentire i ritmi che governano la vita che ferve negli abissi. Fermi
sulla riva, appoggiati alle agili prue falcate delle loro sciabbeghe,
questi uomini dalle decisioni rapide e dai movimenti lenti, chiamano le
ciurme addormentate leggendo l’ora dal quadrante del cielo, dai moti
delle stelle. È giusto, perciò, ricordarla alle generazioni che
ne vedono, oggi, il simulacro dissacrato dal ruggente motore. Lunga,
agile, slanciata, la sciabica (ma chi la chiama così?) costituiva un
elemento a sé stante nell’economia, nella coreografia e nella storia di
Porto Recanati. Per la particolare natura di questo genere di pesca,
caratterizzato dalla costante osservazione del mare e dalla rapidità
dell’intervento, la sciabica era costantemente armata e pronta
all’impiego. La
lunga enorme rete, opportunamente raccolta in magistrali piegature e
facilmente e rapidamente defilabile in caso di varo, troneggiava
apparentemente inerte e pesante sul pianale di poppa dal quale, una volta
in mare, il capobarca calava con movimenti calcolati e solenni.
In
effetti, anche ai tempi di Gesù la rete a strascico era tra i mezzi più
usati per la pesca. Ciò accadeva, naturalmente, pure nel mare di Galilea
dove il Messia incontra Pietro e Andrea. Qui la rete veniva trascinata tra
due barche oppure una barca restava a una certa distanza dalla riva mentre
i pescatori, sulla spiaggia, camminavano lungo la battigia. Ben poca
differenza rispetto al modo di praticare la sciabica a Porto Recanati. |
|
Adesso facciamo parlare direttamente l’amico V. senza più
limitarci ad arrangiare quanto da lui scritto ormai parecchi anni fa. Ci
piace questa prosa che non indulge a sentimentalismi e che lascia
trasparire un velo di bonaria ironia, misto a una profonda partecipazione
e a sincera simpatia per gli uomini della ‘sciabbega’. Lo
abbiamo già rilevato, ma torniamo a far notare lo stile
caratteristicamente altalenante tra lingua e dialetto. Il testo risale
alla metà degli anni Ottanta. “Ohooooo,
‘aràmo!”: era il richiamo del paró della sciabbega che alle due,
alle tre di notte correva di porta in porta a svegliare i suoi uomini. “Dàje
cùgiu, dàje, el pesciu è mésto!”, ripeteva per sollecitarli, a voce
bassa, quasi temendo che quelli di altre sciabbeghe lo sentissero. E
mentr’egli correva giù la marina a sistemare lo scalo e a ogne le
palanghe, i sciabbegotti si buttavano via dal letto, afferravano ancora
mezzo addormentati le salparelle e il collaro e, senza una goccia di latte
caldo, s’avviavano scalzi verso il mare, tra un colpo di tosse ed uno di
catarro, maledicendo in cuor loro la propria miseria. Mi
pare ancor d’udire il rumore della vecchia bicicletta de ccì Pacchió,
che veniva a chiamare vicino a casa mia el defunto Buttó, il quale,
immancabilmente, lo spediva con due tre moccoli; e quando questi si
presentava giù la sciabbega, con ritardo, i corni lu ‘ffugava. “E
tantu l’agurìa de nonnu Fiore el brigante ci hai!”, gli gridava el
Zampetto; “ ‘a là ché ‘n’antra ‘olta a te spettàmu, da culu!”,
incalzava sotto Saeretto de Nanà. Quindi
a forza di remi e con l’alzana si dirigevano verso la zona di pesca
prescelta: la ‘alla
(valle) del Potenza o del Musció, ggió da Pacchianè o su da Scainì.
El paró si metteva in piedi sulla cuertina a pùpa, per avvistare le
rosciure de pesciu; la sua vista era simile a quella di un falco. Gli
uomini sui remi stavano a bocca de gola e ‘l poro Sudo, affaticato dal
prueru che maneggiava da più d’un’ora senza respiro, mormorava tra sé
con malinconica rassegnazione: “E’ propiu ‘eru, gnà murì pe’
campà”. Intanto
lassù nel cielo e’ stelló assieme alla altre sue compagne di
solitudine si faceva sempre più pallido, mentre negli uomini cresceva
l’ansia dell’avvistamento. Finalmente il paró gridava: “O ragazzi,
mettete a prua fitta, i riffuli d’agura ce ccèga!”. In fretta
gettavano el gaezzu a terra e calavano con mosse veloci: “rete grossa
‘mbraga maru, ‘mbraga pesciu” urlava Francé de Grespì incitando i
suoi a daje sotta: “’oga cun ‘si remi ché dopu magnamu tutti el
cappó!”. A
terra gli davano dentro col passo, poggiandosi con tutto il peso sul
cullare. “O ragazzi, l’agura fa becchettu”, esclamava contento el
Cuciniero, indicando con i suoi occhi aguzzi il centro della rete che
pareva in ardore e, invitandoli a metterci la forza, gridava: “Fate ala,
nun tirate a scossi”. Così,
tra fatica e speranza si andava avanti per qualche cala, mentre el barcaru,
il più vecchio di solito, restava a bordo a sonà le reste, a pulì la
sciabbega, a capà el pesciu dalla cuffetta. Intanto,
verso le nove, si vedeva qualche ragazzino con più fagottelli in mano
correre a piedi nudi su per marina a portare la culazió al padre e ai
zisi. Gli uomini sudavano, avevano la gola arsa; il sole faceva pesare la
calura. Negli animi affiorava sempre di più la stanchezza: era ora di
tornare a casa. Ma
el paró brontolava a voce alta: “Nun è notte a Cinguli; dàje che famu
la cala de la ‘endegna”. Proprio l’ultima, chissà che non sia
quella buona. Finalmente
si prendeva la via del ritorno, ma ancora quanta fatica per il povero
sciabbegotto: fassela tutta a remi e con l’alzana dal Musció con
sciroccale era bava! A
seconda della pesca i visi erano lieti o tristi, ma c’era un anziano
sciabbegotto che, comunque fosse andata, non perdeva mai il buon umore:
era Cassino, che quando s’avvicinava alle prime case del paese
cominciava a cantare certe arie napoletane! La sua voce robusta si perdeva
lontano: “O Telèèèè, o Telèèèèè, quante notte m’aggio perse
pe’ teeeee…”, intonava ogni volta che intravedeva il povero
Telespero Pasqualini ggió per marina. Se
incontravano lungo la spiaggia qualche personaggio noto per la sua
stranezza, allora Dio te ne liberi: cominciavano a fischiare, a urlare, a
tirar fuori i fazzoletti che agitavano in aria in segno di dileggio, e giù
risate a non finire. “Agura e sgombri, agura e sgombriiiii”, gridavano
felici gli uomini dalla barca, prolungando all’infinito la “i” e
alzando le coffe colme di pesce. Tant’è
che a Porto Recanati, quando si vuol indicare il desiderio di una brigata
felice per passare qualche ora spensierata, è divenuta proverbiale
l’espressione “’Ndamu a sciabbega ché ridemu”. Una
volta allo scalo, spandevano la rete e i collari al sole; el paró faceva
le parti della rimanenza e ognuno tornava a casa sua, in mano la
sparettina de pesciu, per ritrovarsi poi tutti al pomeriggio in cantina a
fa’ ‘mbrenna. Qui, tra un quartino e l’altro passavano spensierati
la serata; il loro companatico era una chieppa o un morgano secchi, che
presi d’estate venivano messi al sole a seccare perché servissero per
l’invernata, in quei lontani anni di miseria. Oggi
come allora, se c’è una parola che offenda in maniera fastidiosa uno di
Porto Recanati è sentirsi dire “sciabbegottu”. Un tempo i
sciabbegotti costituivano l’ultima delle categorie, “boni nemmeno a
fa’ da testimoni”, tanto scarsa era la considerazione sociale nella
quale venivano tenuti! Nel
tessuto cittadino si distinguevano i commercianti, in particolare quelli
di stoffe, i telaroli, che con il loro brecche o cacciatora (carro
trainato da cavalli) si spingevano a Macerata, Ancona, San Benedetto del
Tronto… Ad
essi guardavano con invidia i pescatori, l’anima di Porto Recanati, le
cui origini storiche s’identificano con il nucleo marinaro di profughi
albanesi giunti alla metà del XV secolo; però, da quando la vela è
stata sostituita dalla meccanica, questi sono diventati, e di gran lunga,
il popolo grasso del paese. All’ultimo
posto v’era uno strato composito formato di artieri, sciabbegotti
appunto, e scalanti. Per artiero s’intendeva colui che esercitava un
mestiere in proprio: el cordaro, el canepì, el calafato, il fabbro, il
falegname, il sarto, il barbiere e qualchedun altro. I
scalanti erano per lo più vecchi marinai in pensione, e gli stessi
sciabbegotti, come Lisà de Bufarini, Peppe de Pumì, Cellerì, Jacumì de
Bruduló, Sudo. Ultimo
epigono di un mondo ormai scomparso è rimasto zi’ Neno Menelicche, il
volto di cartapecora, gli occhi dô gocce de maru, sempre ggió per marina
a spettà la cunculara. Era
loro compito quello di tenere sempre in ordine lo scalo, de ogne bè le
palanghe, de sta’ pronti a ‘ultà sull’arghenu. Ad essi spettava la muccìa, lo scarto del pescato dei barchetti; comunque, sempre bono pe’ fasse un brudettì o dô pescetti fritti! Guai se la figlia d’un marinaro avesse sposato uno sciabbegotto, oppure preteso un artiero: e per tant’è ‘ea persu l’unore lia cun tutta la generazió!!! |
|
Non poteva mancare il contributo di Alessandro Mordini, Lisà
per tutti noi, il quale scrive per diretta esperienza. La sua memoria gli
ha dettato nomi e volti ben conosciuti al Porto nonché un episodio che
rivela ampiamente la mentalità degli sciabicotti. Non
mi ricordo bene se era l’anno 1947 oppure il ’48, avevo
sedici/diciassette anni e andavo a pescare con la sciabica di Giuseppe
Giri, detto Magnaró e detto anche El Zampettu. Erano
soprannomi che venivano certamente da lontano e dei quali non conoscevo le
origini. A Porto Recanati tutte le persone anziane venivano chiamate “zi’”,
cioè zio e zia a seconda del sesso, e tutti coloro di una o più
generazioni inferiori venivano chiamati, dagli anziani, “nipote”.
Questa precisazione era doverosa. Zi’
Peppe de Magnaró aveva, credo, sei figli, di cui quattro maschi: Giggiu,
Nenu, Peppì, Pasqualì (Luigi, Nazzareno, Giuseppe, Pasquale), tutti e
quattro impegnati nella sciabica del padre. Giggiu, il più grande di età,
era il capobarca (paró). A
quell’epoca eravamo una bella ciurma. Oltre ai quattro figli di zi’
Peppe, già nominati, c’erano tre persone anziane: zi’ Incè de Nasó
(Vincenzo Gaetini), zi’ Nicò del Tentore (Nicola Mordini, mio nonno), zì
Incè de Gabetì (Vincenzo Grilli). I ragazzi della ciurma, dai
quattordici ai diciotto anni: Gaetano Ferraccioni, Pietro Cavallari (Pietru
de Ciambelló) andato poi in Argentina a raggiungere suo padre, Alessandro
Mordini (Lisà ovvero me medesimo), Luciano Grilli (Lucianu Panzetta),
Antonio Galieni (‘Ntò), Antonio Ferraccioni (‘Ntuni’), Nicola
Pandolfi (Niculì), Giri Giuseppe (Peppe Rita) che credo sia stato il più
piccolo, quattordici anni, figlio di Nenu, nipote del padrone della
sciabica.Di tanto in tanto si aggregava qualche altro, ma erano soltanto
provvisori, la vera ciurma eravamo noi. Spero
di non avere dimenticato nessuno, ma se fosse non me ne voglia. E’
passato tanto tempo. Veniamo
alla scia. A
fine settembre e soprattutto in ottobre, ci alzavamo presto, alle due di
notte eravamo già pronti per il varo della sciabica. Facevamo
la prima pescata (cala) all’altezza della pineta Volpini. Calavamo la
rete molto al largo, quattro o cinque ‘reste’, dai tre ai quattrocento
metri dalla riva e anche oltre. La
rete arrivava a terra verso l’alba, carica di ‘sciugheri, bobbe,
zanghette e baracculette’. Ma dietro la manica si formava una scia nella
quale c’erano tanti piccoli pesciolini (‘lattarì’) che uscivano
dalle maglie della rete, attirando presso di loro banchi di sgombri, ma
soprattutto di aguglie (‘àgura’). Facevamo
quella cala al largo non soltanto per il pescato della stessa, ma proprio
per calare la rete dietro la scia che sarebbe risultata la pescata più
proficua e meno faticosa, perché effettuata vicino alla riva.
Puntualmente, tutte le mattine, la cala dietro la nostra ‘scia’ ce la
fregava un’altra sciabica, che appostandosi dietro la foce del fiume
Potenza, attendeva il momento propizio per calare la rete. Noi
eravamo in piedi già dalle due di notte, questi signori freschi freschi,
da poco alzati dal letto, tutte le mattine ci facevano questo scherzetto. Quello
che loro facevano era legalmente inappuntabile, il mare era libero e tutti
potevano pescare. Non potevamo farci niente. Ma
non era del tutto corretto nel codice morale dei pescatori. Che
fare? A un certo punto ci siamo decisi. Una
mattina abbiamo fatto finta di calare la rete, invece li abbiamo aspettati
al varco. Non appena il loro capobarca ha lanciato la cima della corda a
terra (‘buttà el capu’) per poi procedere alla calata della rete,
abbiamo aggredito la metà della ciurma rimasta sulla spiaggia e a furia
di ‘scullarate’, cioè botte con le tracolle (i ‘cullàri’), li
abbiamo messi in fuga. Per quando l’altra metà della ciurma è arrivata
in loro soccorso, gli altri si erano già dileguati, e giù, botte da orbi
anche a questi. Non
ci sono state né ferite né fratture e nemmeno querele. Soltanto qualche
contusione e qualche bernoccolo (‘bòzza’), e, credo, anche tanta
paura. Soprattutto
hanno imparato la lezione: da quel giorno ogni sciabica calava la rete
soltanto dietro la propria scia. |
|
Nel
bellissimo passaggio trascritto poche pagine fa, V. fa riferimento alla
cantina, cioè all’osteria, abituale rifugio degli sciabbegotti, benché,
certo, questi non ne fossero i soli clienti. Nella
relazione di accompagno dei dati ricavati dal quinto censimento del Regno
(1911), il segretario comunale Luigi Petrocchi esprime un severo giudizio
sugli uomini portorecanatesi, …nella più gran parte marinai, i quali
fanno assegnamento sul meschino guadagno di esse (delle mogli,
pescivendole o venditrici di aranci, stoffe e altro) per poter
frequentare fino a tarda sera il caffè e l’osteria, nel lungo periodo
che stanno in terra, dal dicembre, cioè, all’aprile. Un
po’ impietosa l’analisi di Petrocchi, oserei dire ingiusta: la cantina
non era certamente il Rotary Club, ma dove altro potevano andare a passare
il loro tempo i nostri pescatori? Nei
mesi invernali, la mattina, li si poteva trovare a rammendare le reti, a
fare lavori di manutenzione degli attrezzi della professione perché
fossero pronti al momento opportuno; qualcuno si arrangiava pure a dare
una mano ai calafati. Il pomeriggio, però? Il
pomeriggio erano tante piccole processioni che prendevano la direzione di
quei ‘templi del vizio’, ogni fedele tenendo in mano un cartoccetto di
pesce essiccato o di tonno e olive, e un tozzo di pane. La
cantina era, di solito, un lungo stanzone debolmente illuminato, ai cui
lati si trovavano tavoli di 3/4 metri per un metro circa: gli avventori
sedevano su panche prive di schienale, poste ai lati. La
parete di fondo era occupata dal bancone sul quale troneggiavano le botti
del vino con i rubinetti in continua attività. Entrando
si rimaneva colpiti dal gioco di ombre cinesi proiettate sull’alto
soffitto; profili di facce spigolose, schizzi di mani e braccia alzate per
imprecare o ammonire, minacciare o descrivere: il tutto sorretto da un
mormorio sommesso interrotto, di tanto in tanto, da un richiamo festoso o
da un’invelenita bestemmia. La
buona borghesia, quella che contava e governava, frequentava il più
aristocratico caffè e guardava con poco celato disprezzo al lacero
groviglio di umanità che, pure, nella cantina si illudeva di affogare la
propria quotidiana pena di vivere. Dalle
quattro del pomeriggio alle sette, sette e mezzo di sera, i locali di
Alberto Cittadini in via della Stazione, quelli di Cavallari, del
Torcoletto in via Larga, di Giri a Castelnuovo e tutti gli altri (circa
una ventina), si riempivano di avventori davanti al naso dei quali, tra la
nebbia del fumo dei sigari, sparivano e riapparivano con sorprendente
rapidità le fogliette da un quarto, da mezzo litro o da un litro,
sempre attentamente controllate dai clienti affinché l’oste non facesse
el cullarì, vale a dire non arrivasse a versare il vino fino al
segno circolare sul collo della foglietta. Quando
l’atmosfera si era abbastanza scaldata cominciavano i cori: vecchie e
tristi storie come quella di Giulia, che il fidanzato aveva trovato morta
al suo ritorno dal servizio militare; la feroce ballata di Peppino Amato
dove si promettevano ai signori pugnali, sangue e vendetta;
stornelli del tipo Al Portu de Ricanati c’è un’usanza, le donne
maritate fa’ all’amore… Inevitabili
le canzoni del mare, mentre i più ‘raffinati’ si commuovevano (il
vino li aiutava) sulle note del Va pensiero e della Vergine
degli angeli verdiani o su quelle del Miserere che si intonava
anche per la bara de notte. Gli
argomenti preferiti nella conversazione riguardavano il lavoro, i
guadagni, i problemi con i colleghi, le piccole meschinità e i tradimenti
di ogni giorno. Molti
giocavano al sotta, nome che veniva dato a colui che comandava il
gioco: l’ignaro forestiero che si fosse trovato lì per caso avrebbe
assistito a strani rituali celebrati intorno al bicchiere colmo di vino,
dal sotta, dal paró, dal giocatore che veniva fatto olmo,
cioè lasciato all’asciutto. Nel
gioco, a volte, la tensione saliva pericolosamente: tra un 54 ell’omu
se despèra e un 55 ‘mmazza la premiera si insinuava con
facilità la contestazione seguita dall’insulto e poi dal rapido
spuntare del coltello dalla fascia che cingeva i fianchi del marinaro,
del pescatore o dell’artiere. La
cantina e le sue immediate adiacenze erano quasi un luogo deputato per le
liti; non di rado queste avevano conseguenze gravi come accadde, per
esempio, il 23 luglio 1899 davanti all’osteria Cavallari. Racconto
il fatto con le parole della sentenza emessa il 18 gennaio 1900 dalla
Corte d’Appello di Macerata, presidente il cav. Gaetano Mazzini
(Archivio di Stato di Macerata, Registro delle sentenze dell’anno 1900,
n°73): Nel giorno 23 luglio (1899), circa alle ore 14, ebbero
ad incontrarsi nella osteria Cavallari in Porto Recanati il V.A. e il F.M.
Tra di essi sorse una questione presto domata dai presenti avendo il primo
rivolto in tono ironico al F. la parola: ‘bricòcolo. Nella
sera dello stesso giorno, verso le ore 22, ebbero nuovamente ad
incontrarsi nella osteria suddetta il V. e il F. e fuori della porta della
medesima ove si ballava si riaccese la questione ed in seguito a vivace
scambio di ingiurie il V. vibrò un colpo di trincetto nel petto al F. il
quale sentendosi ferito afferrò una pietra e la scagliò contro il
feritore colpendolo alla schiena. Il
F. riportò una ferita dichiarata guarita in giorni nove ed il V. a sua
volta altra lesione guarita in giorni sette. Nonostante
che i due si fossero in seguito accordati, con la conseguente remissione
delle rispettive querele, il Tribunale condannò comunque a 28 giorni di
arresti il V. perché …è addimostrato dalle risultanze processuali
che il V. dopo essere andato freddamente ad armarsi di trincetto assalì
improvvisamente il F. il quale invece era stato dal medesimo già
precedentemente ingiuriato. I precedenti poi del V. giustificano per sé
soli la gravità della pena… Azioni
da condannare, senza dubbio; né si può dimenticare che troppi fatti
simili si verificavano nelle cantine. Tutto
ciò non può però cancellare il positivo che c’era in quella ‘istituzione’,
se non altro perché essa ha rappresentato l’unica occasione di
incontro, di svago, di scambio quasi sempre pacifico di opinioni. Anche
nella vicenda di A.V. e M.F. questo aspetto viene evidenziato: quella
sera, fuori dell’osteria Cavallari, la gente ballava come probabilmente
accadeva presso altre osterie. Poi,
alla fine, si tornava a casa, ma un po’ col vento in prua perché si
rientrava nella dimensione della vita sofferta di ogni giorno, il pensiero
di nuovo rivolto alla vasta distesa salata che Dio ci ha dato, a noi del
Porto, per eterna compagna: Pacenza
‘ita mia se pati pena; Forse
sbaglio, ma mi pare che l’ultima cantina a chiudere i battenti sia stata
quella di Primo, all’angolo tra le vie Adriatico e san Giovanni Bosco,
con ingresso da entrambe. Quella
cantina resta nella memoria di chi aveva da poco passato l’adolescenza
agli inizi degli anni Sessanta, come il locale fuori del quale Ovi e
Didó, indimenticabili personaggi e sciabbegotti, intrattennero una
vasta compagnia di giovinastri discutendo fino a mezzanotte sulla
struttura dell’atomo. Quando non ci furono più cantine, anche zi’ Nemesio
el Trentino e Gujè Occhibelli dovettero trasferire il loro
spettacolo (il secondo accompagnava all’organetto la danza del primo)
negli spiazzi all’aperto. Insomma, chiuse le porte delle osterie, finito un mondo. |
|
La
religiosità degli sciabbegotti era un misto di fede sincera e di credenze
popolari, anche di superstizioni, il che dava luogo sovente a
comportamenti piuttosto contraddittori. La
barca veniva sempre battezzata, anche quando era stata comprata di seconda
mano, e nel suo interno trovavano posto santini e immagini sacre di ogni
genere e forma. Quando
si calava per la prima volta, in qualsiasi ora della giornata, prima che
la rete toccasse l’acqua, lo sciabbegottu de pupa o il paró pronunciavano
la formula di rito, che poi era un invito: àneme sante del purgatoriu,
alla quale l’equipaggio rispondeva: per Maria Santissima. Qualcuno
toglieva il berettu, altri recitavano il padre nostro, senza
preoccuparsi, ben inteso, del fatto che poco prima avessero
abbondantemente smoccolato, magari per qualche banale motivo. Quando
all’alba spuntava il sole, l’astro veniva salutato togliendosi il berettu
e dicendo: Bungiornu santu sole. Niente di pagano
nell’espressione, almeno mi sembra, ma solo il rispetto per il più
grande fenomeno della natura creata da Dio. La ‘santità’ del sole era
per gli sciabicotti lo specchio della più grande santità dell’Ente
Supremo. È
noto che gli sciabbegotti tengono molto, da sempre, a partecipare alla bara
de notte, il catafalco dove è poggiato il simulacro del Cristo Morto,
che viene portato in processione a forza di braccia nelle vie del Porto il
venerdi santo. A
dire il vero questa devozione, da noi, è generale; è la comunità che
partecipa con uguale intensità all’evento, indipendentemente
dall’appartenenza delle persone a questa o a quella categoria sociale. Ma
sono gli uomini di mare che si sobbarcano la fatica del trasporto, con
l’aiuto di uno dei simboli del mestiere di sciabicotto, il cullaru;
e sono sempre gli uomini di mare che si mettono sacco e cappuccio per
portare sulle spalle la croce immediatamente dietro la bara (i
cangiudei). L’usanza
della processione è di certo antica assai. Quanto alla bara, occorre
stare attenti a non azzardare ipotesi senza alcun fondamento. Al momento
non si hanno certezze in rapporto al tempo del suo apparire nel panorama
dei riti religiosi locali. Per il resto, gli sciabbegotti partecipavano del modo di sentire la religiosità da parte della collettività portorecanatese. Battezzavano i propri figli, li cresimavano e li sposavano in chiesa, dove essi stessi andavano a ricevere la benedizione di Dio prima di andare ad appendere il cullare su da Marino, vale a dire al camposanto (Marino era il nome di una persona che ha fatto lungamente da custode del civico cimitero). |
|
Non
sono tra quelli che condividono in pieno l’idea della donna
portorecanatese come vero capitano della nave familiare. Mi pare che
questo sia il frutto della costruzione di una sorta di mito cresciuto fino
a vantare rango di verità storica grazie a strumenti impropri per
misurare la suddetta verità, vedi la poesia o il teatro dialettali. Ciò
non significa che alla donna debba essere riservato un posto di secondo
piano nella storia cittadina; significa solo che quello in cui è stata
collocata fino ad ora mi sembra non propriamente appartenergli davvero. Come
che sia, essa ha svolto un ruolo determinante nell’economia della
sciabbega e non di rado partecipava alla fase ultima della pesca, vale a
dire quando la rete veniva ritirata a terra, proprio come la donna di
sabbia di Grazia Deledda. Le
donne aspettavano ansiose l’arrivo dei portatori delle coffe nei
pressi del mercato ittico, con lo sguardo fisso alla strada. Una
volta avuto il pescato, assistevano alle fasi dell’astatura e della
vendita, riferendo agli uomini, in tempo reale, le notizie
sull’andamento del mercato e sulla qualità del pesce fatto giungere sul
posto dalla concorrenza. A
volte riuscivano persino a riferire dove le altre sciabiche avevano calato
la rete, così da permettere subito ai loro la scelta di un posto diverso. Una
parte del pescato veniva venduta per le vie del paese con i caratteristici
cariòli, che servivano anche per il trasporto del pesce in
campagna, al grido di pesciu, pesciuuuuu! Pesciu frescu vivu vivuuuu!
Pesciu de sciabbegaaaa! Quella
dei cariòli è stata un’epopea che merita di essere studiata a
parte; senza i dilettantismi che, anche qui, hanno fin troppo
‘guastato’ una verità storica fatta soprattutto di fatiche
inenarrabili, verità che si può ancora intuire, per esempio, dalla
lettura di alcune poesie di Emilio Gardini e percepire con chiarezza, e
con qualche brivido nella schiena, ascoltando il racconto di chi ancora è
in grado di parlare per diretta esperienza. |
|
Sugli
sciabbegotti c’è una letteratura orale sterminata. È fatta soprattutto
di aneddoti, ma non mancano racconti di situazioni e di momenti che
meritano di non essere dimenticati. Lo
scrivo a beneficio di quanti guardano con snobistica alterigia al mondo piccolo
della sciabica e credono che l’unico impegno culturale degno di essere
definito tale sia da collocare dalla linea Bergson/Heidegger in su (fatto
salvo, è ovvio, che cosa si debba davvero intendere per ‘su’). A
dire la verità, mi fanno un po’ pena perché non sanno proprio quel che
perdono. Moriranno monchi di un ‘sapere’ che li avrebbe resi capaci di
capire che cultura è pure sinonimo di umiltà. Ma
non di sciatteria, sia chiaro. Perché c’è anche da mettere in guardia
nei confronti dei non pochi ‘studiosi’ improvvisati della storia e
della tradizione locali. Questi,
infatti, sono terreni ai quali occorre avvicinarsi dopo essersi dotati
degli strumenti di conoscenza necessari, i quali non si acquisiscono per
grazia ricevuta o per eredità familiare, al modo di un mobile. Bisogna
sapere come si conduce una ricerca storica, linguistica, di folclore e di
costume. E per saperlo non c’è altra strada che lo studio, con ciò non
limitando il termine al solo riferimento scolastico. Chi
crede che trattare della sciabica, come capita in questo numero di Potentia,
o di altri argomenti che appartengono al patrimonio di civiltà della
comunità del Porto sia ‘facile’ e perciò roba per tutti,
lasciatemelo dire, è solo uno sciocco. Bene, finita la predica (me ne scuso, ma a qualcuno, forse, servirà), diamo spazio agli episodi annunciati, che sono soltanto una piccola scelta tra i tanti che sono stati riferiti. |
|
Che
motivo si ha di affermare che u’ sciabbegottu nun è bonu mancu a
fa’ da testemoniu? La spiegazione, come ebbe a dichiarare Mario
Panetti, da me intervistato per la realizzazione della
videocassetta del C.S.P. sulla sciabica, ‘è a monte’. Non
ho ben capito il senso di quel riferimento geografico, ma ricordo
perfettamente, invece, la storia che Mario raccontò per togliere valore a
un modo di dire che non può non suonare offensivo per un’intera
categoria. Eccola. Gli
Scarfiotti avevano messo su casa anche da noi costruendo una grande villa
a ridosso della spiaggia. Com’è noto, si tratta dell’attuale
albergo/ristorante Vincenzo Bianchi. Ciò accadeva, probabilmente, ai
primi del XX secolo. Già
da qualche anno l’avvocato Lodovico (primo presidente della Fiat dal
luglio 1899 al luglio 1908), veniva a passare le sue vacanze d’estate al
Porto e stava maturando l’idea di costruire qui una fabbrica di cemento,
cosa che poi fece, a vantaggio e beneficio dell’intera comunità. La
famiglia si stabiliva in villa all’inizio dell’estate e il suo arrivo,
come ho scritto nel mio Gli Scarfiotti e Porto Recanati (Porto
Recanati 1991, p.62) era un avvenimento che…. segnava l’inizio
ufficiale della stagione; nella grande casa sul lungomare pavimenti e
mobili risplendevano, la facciata era adorna di fiori e al loro arrivo i
padroni erano attesi dalla servitù che faceva ala al passaggio della
famiglia, Maman (Luigia Favale) in testa. Qualcuno ricorda che in quel
palazzo sostò anche il principe Umberto, in navigazione nell’Adriatico:
scese a terra e fu ospite degli Scarfiotti per riprendere il mare il
giorno dopo. Della
famiglia faceva parte Francesca Faà di Bruno, moglie dell’ingegner
Luigi e madre del Lodovico futuro campione automobilistico. Il cognome, Faà
di Bruno, era, ed è, altisonante. Un
giorno successe che la signora Francesca non trovò più un suo anello di
grande valore. Pensa e ripensa, giunse alla conclusione di esserselo
perduto in spiaggia, con in più il sospetto che il bagnino l’avesse
trovato e se lo fosse tenuto. La
faccenda finì davanti al pretore di Recanati, con il bagnino in veste di
primo sospetto del ‘furto’. Questi, il bagnino, che era anche sciabbegottu,
chiamò a testimoniare a suo favore un gran numero di colleghi nel
mestiere del cullaru. Alla domanda del magistrato, “Che cosa
sapete dirmi dell’anello?”, gli sciabbegotti rispondevano tutti in
maniera assai evasiva. Esempio, portato da Mario Panetti: Ah, sor
pretore, iere ‘emu calatu ‘icinu a la sbocca del Putenza e ‘emu
presu bè. Oppure, alla stessa domanda: Ah, sci; hu dittu a mi’
moje de mannamme su el pà e de mettece un po’ de furmaggiu. E
via così fino a esaurimento dei testimoni; alla fine il pretore disse che
chi aveva avuto e chi aveva dato poteva sentirsi soddisfatto e chiuse lì
il caso, con un nulla di fatto. Vecchia storia, tipo quella de La farce
de maître Pathelin, capolavoro del teatro francese del Quattrocento. Dunque,
afferma Panetti, è vero che gli sciabbegotti non hanno ‘saputo’
testimoniare, ma solo perché non hanno voluto. Loro sono stati i più
intelligenti in tutta quella faccenda. Del
resto, c’è un inoppugnabile documento che attesta, se davvero ce ne
fosse bisogno, la capacità testimoniale dei nostri artisti della
sciabica. Nella vicenda giudiziaria di Emidio Maggi, avvenuta nel 1831
(vedi il primo numero di questa Rivista), tra i testimoni a carico del
‘rivoluzionario’ figura Nicola Meschini, nato nel 1791, di professione
sciabicotto. Dunque… |
|
Il
5 novembre 1901 il sindaco Enrico Volpini fece affiggere un manifesto
tutto dedicato agli sciabbegotti. Circa
un mese prima, il 31 ottobre, il prefetto di Macerata, Borselli, gli aveva
inviato un telegramma con la richiesta di inviare soccorsi urgenti nel
territorio di Montelupone inondato a causa di piogge torrenziali e dove
diversi coloni, circondati dalle acque, aspettavano qualcuno che li
tirasse fuori da quel brutto guaio. Volpini
fece appello ai pescatori, i quali, a quanto risulta dal manifesto,
risposero pronti e volenterosi, allestendo squadre di soccorso
giunte in pochissimo tempo sul posto: lì, navigando per la campagna a
bordo delle sciabiche, i nostri si erano distinti per coraggio, salvando
molte vite e meritando il ringraziamento pubblico e ufficiale del Prefetto
Borselli. Ecco l’elenco degli eroi: Giri
Alessandro Il
manifesto, stampato nella tipografia recanatese Simboli, fu affisso per le
vie cittadine e ci pare più che giusto ricordarlo perché in
quell’episodio i nostri sciabbegotti hanno dato una grande dimostrazione
di altruismo e di capacità L’occasione
sarebbe buona di affrontare qui un argomento ancora assai poco esplorato,
quello dei rapporti tra sciabbegotti e contadini, ma ci ripromettiamo di
farlo in futuro, non disponendo ancora di notizie e documenti sufficienti
e mancandoci pure lo spazio in questo numero. Non
va dimenticato, infine, che una grossa mano fu data nell’occasione dai
nostri carrettieri; furono loro a trasportare a Montelupone, con i
cavalli, le sciabiche per il salvataggio delle persone in pericolo. Un’altra
circostanza in cui gli sciabbegotti si resero protagonisti di un atto di
valore (un’altra tra le tante, in verità), si verificò il 25 aprile
del 1926. Dal
giorno prima infuriava un grosso fortunale, che aveva anche causato la
morte di un pescatore, Attilio Antognini. Altri due, Giovanni Volpini di
51 anni e Ciriaco Pandolfi erano restati isolati su una barca ancorata a
circa quattro chilometri dalla riva. Si avvicinava la sera del 25 e la
barca, appena disancorata, non avrebbe certo retto la furia delle onde.
Pandolfi era ferito, un colpo di pennone gli aveva rotto due costole,
l’altro, Volpini, era vecchio, come si esprime il segretario
comunale, geometra Dante Santucci nel registro delle deliberazioni del
commissario Giuseppe Volpini
(21 maggio 1926). Ad
avvisare a terra che i due si trovavano in situazione molto critica era
stato il vapore Roma, che non aveva potuto soccorrere la lancia, data la
grande pericolosità della manovra di accostamento e rimorchio con
condizioni di mare così difficili. Né si era potuto convincere il
Volpini a tentare da solo di salire a bordo della nave: non aveva voluto
abbandonare il più giovane compagno ferito. Allora
otto pescatori escono in mare con una piccola barca a remi, vale a dire
una sciabica. Affrontano un non piccolo pericolo; sanno che stanno
mettendo a rischio la propria vita. Come
che sia, riescono ad accostare la barca e prendono a bordo i due. Il
ritorno si rivela più pericoloso ancora perché il natante rischia ad
ogni momento il capovolgimento, specie al momento di prendere terra. Ma
ce la fanno. Sono tutti salvi. Ecco
i nomi degli otto protagonisti, tra i quali si trova qualcuno che abbiamo
appena conosciuto: Giri
Saverio fu Giovanni, 58 anni, proprietario della sciabica Per
tutti loro la qualifica è di pescatore, mentre nell’atto si fa speciale
menzione dei primi due che furono ammirevoli e sprezzatori del pericolo. Lo stesso commissario Volpini, in compagnia del Comandante del Porto di Ancona, era stato testimone del fatto e perciò egli proponeva un’adeguata ricompensa agli otto sciabbegotti e pure a Giovanni Volpini per la sua decisione di restare accanto al compagno ferito.
|
|
L’interrogativo,
per i pescatori del Porto, per quanto antico non ha smesso di avere
validità anche al giorno d’oggi. Il problema di un posto dove
consentire l’alaggio delle piccole imbarcazioni è stato affrontato
tante volte e tanti sono stati i tentativi di trovare una soluzione
definitiva. A
parziale conforto di chi ancora si trova di fronte il problema, riportiamo
un trafiletto apparso nel quindicinale Il Martello, foglio di
opposizione all’Amministrazione Volpini/Lucangeli (sosteneva il così
detto partito Cittadini, insieme di socialisti, radicali,
repubblicani). Da
quanto si legge appare che nei primi anni del XX secolo (il trafiletto è
stato pubblicato nel numero 11 del 6 ottobre 1901) la zona di alaggio era
a lato della foce del Potenza, verso l’incasato urbano, il che significa
che chi ha pensato in tempi più recenti alla stessa soluzione, non ha poi
inventato gran che. Ecco
il testo che ci interessa: Giorni sono i lancettari, avendo il fiume
occupato la spiaggia ove eseguiscono lo scalo, furono costretti a mettere
un tanto a testa e far rimediare alla meglio. Se il fiume si è accostato
tanto al caseggiato, con un po’ di piena e mare che non riceva, non
potrebbe darsi che Porto Recanati venisse allagato? Questo prevedeva il
conte Della Torre (uno della parte di Alberto Cittadini), se non
erro, un paio d’anni fa quando c’era una questione di usurpazioni. Vi
fu un’inchiesta in proposito e fu interpellato anche il Genio Civile. Il
conte Della Torre naturalmente ebbe tutti i torti: ma il fiume,
accostandosi sempre più al caseggiato, com’egli previde, ora gli da
ragione…. Il
fiume va in piena, Amministrazione ladra! Il
problema fu ripreso in esame dall’Amministrazione comunale (commissario
prefettizio Giuseppe Volpini) alla fine del mese di maggio del 1926. Le
lamentele dei bagnini erano state probabilmente notevoli: le lancette e le
sciabiche tirate a riva in ogni sito della spiaggia di fronte all’incasato
urbano, rendevano la vita difficile a loro e ai bagnanti. Anche perché i
pescatori non si limitavano a occupare il necessario, ma spandevano
ovunque argani, palanche, travi e attrezzi vari. Durante la stagione, tra
l’altro, veniva ostacolata la regolare collocazione dei capanni.
L’inconveniente maggiore era l’alaggio delle barche quando le
condizioni del mare non consentivano la pesca. Allora,a ridosso delle
lancette e delle sciabiche …vengono lasciati escrementi e rifiuti di
ogni specie. Ben
immaginabile il conseguente e frequente esodo dei bagnanti. La Capitaneria
di Porto di Ancona, alla fine, intervenne in quell’anno 1926 ordinando
che l’alaggio delle imbarcazioni fosse possibile solo in due punti a sud
e a nord dell’incasato urbano, salvo …un’acconcia linea di tiro,
che potrà essere chiamata linea di salvataggio, nella zona centrale resa
libera per ogni fortunosa vicenda in caso di eccezionali mareggiate…. |
|
Maggio
1917: l’Italia è in guerra e anche gli sciabicotti sono chiamati a fare
il loro dovere per contribuire alla vittoria contro gli austro/germanici. Comincia
così, come si è già accennato nel capitolo Numeri, una lunga
serie di requisizioni che interessano direttamente le sciabiche. Il
10 maggio si delibera che le 18 sciabiche in attività cedano quattro
chilogrammi di pescato a testa, ogni giorno di lavoro; l’11 giugno si
cambia e adesso sarà il Comune che requisirà direttamente e
quotidianamente l’intero prodotto di due sciabiche. Ma
l’impresa non si rivela facile perché le sciabiche riescono a sottrarsi
alla requisizione, soprattutto perché il prezzo pagato dal Comune è
giudicato troppo basso. Ancora a fine luglio l’Amministrazione comunale
lamenta scarsa collaborazione da parte dei pescatori: Quasi sempre o
con un pretesto o con un altro sono sfuggite all’esatta osservanza
dell’obbligo assunto. Non
è giusto, secondo la giunta comunale, escludere dall’approvvigionamento
i forestieri; probabilmente qualcuno aveva creduto bene di pensare prima a
quelli di casa nostra e poi agli altri. Si
procede, comunque, a un nuovo sistema di requisizione, ma in nessun modo
se ne riesce a trovare uno che soddisfi gli sciabbegotti. Come
si sarebbe potuto, con la miseria dilagante di quei tempi? E
così si va avanti fino alla fine della guerra e oltre: l’ultimo
provvedimento in materia, infatti, è del dicembre 1918, quando,
finalmente, le requisizioni cominciano a riguardare anche le cinquanta
barche a vela che hanno ripreso la loro attività. Le sciabiche, essendo
tra l’altro inverno, sono lasciate in pace. |
|
Vincenzo
Scalabroni, che troviamo presente anche nell’elenco dei pescatori
accorsi a Montelupone per l’inondazione del 1901, pare fosse considerato
al suo tempo il punto di riferimento degli sciabbegotti del Porto. Lo
chiamavano, come ricordava la figlia Ida, capo barzotto, termine
che apprendo per la prima volta. Era
nato il 25 agosto 1873, da Giacomo e Vittoria Braghini. Il 9 agosto 1899
prestò soccorso al pescatore Arturo Pierantoni naufragato con la barca da
pesca I due fratelli capovoltasi nelle acque di Porto Recanati. Per
questo aveva ricevuto un attestato di benemerenza dal Ministero della
Regia Marina. Il
Capitano del Porto di Ancona, a sua volta, gli concesse un encomio per
l’azione di merito compiuta il 18 agosto 1903, quando aveva salvato
Pasquale Gaetini (di Lorenzo), che stava per annegare. E
poi c’era stato l’encomio solenne dell’Ammiraglio Comandante in Capo
del Dipartimento Militare Marittimo di Venezia …per lo slancio e
l’opera zelante spiegata in occasione della cattura della Torpediniera
Austriaca T.Bi/11, avvenuta lì 5 ottobre 1917. Così si legge nel
Foglio di Ricognizione della Marina Mercantile Italiana, documento che è
in possesso della famiglia Scalabroni. Racconta
il nipote Mauro che tra i vari lavori che Vincenzo aveva svolto, c’era
pure quello di aiutare le paranze di San Benedetto del Tronto (vedi il
capitolo Numeri) nelle operazioni di sbarco del pesce e di
rifornimento di viveri e attrezzi vari. Su
zì Saè el Cuciniero lasciamo lo spazio a V., che ne offre un vivace
ritratto: Uno dei più vecchi bagnini è stato Saverio Panetti, che
tutti han conosciuto col soprannome di Cuciniero. Gli piaceva parlare,
parlare: al bar de Storà tenea banco. E tale passione è rimasta anche al
figlio Mario, che appunto perché predica sempre lo hanno soprannominato
el pastore. Beh, quando d’estate i bagnanti domandavano al vecchio zì
Savè che tempo avrebbe fatto l’indomani, perché magari avevano in
progetto una gita in barca fino alle due sorelle (le grandi rocce
emergenti dal mare accostate al Monte Conero), questi si metteva
l’indice della mano destra in bocca, poi portandolo in alto sentenziava:
‘Dumà fa’ maestralettu, partite sciguri’. Qualche volta il giorno
dopo veniva ggió la tressa! Oppure, guardandosi attorno, con aria grave
esclamava: ‘Orizzonze de qua, orizzonze de là (da notare la ‘z’) el
tempu è nubile, minaccia di pioggere’ Ancora
un quadretto di V. Questa volta si tratta del mitico ccì Pacchió.
Va ricordato, come ci ha fatto già notare Alessandro Mordini, che al
Porto tutti gli anziani venivano chiamati zì dai più giovani,
senza che ci fosse alcun rapporto di parentela. Era un segno di rispetto
per chi aveva più esperienza di vita; questi, di rimando, si rivolgeva
all’interlocutore giovane chiamandolo nepote. Scommetto
che pochi a Porto Recanati saprebbero chi è Pasqualì Scalabroni, ma
basta dire il suo soprannome, ccì Pacchió, che ‘ncora i piri di banghi
lo conoscene! Anzi, si offende (il
verbo è al presente perché all’epoca di questo scritto, ccì Pacchió
era ancora in vita) se lo chiamate per nome, per tutti è solo ccì
Pacchió. Quando incontra qualcuno è sempre il primo
a salutare, mille mija da longo: ‘Bongionno, bongionno ccìo’.
E’ evidente che ha poco in simpatia qualche consonante, oppure sono i
denti! Ormai ha superato gli ottanta e da giovane è stato un bravo
sciabbegotto e un ottimo scalante. Quante volte el defunto babbo, zì Nannì,
zì Spartè l’hanno mandato a chiamare pe’ tené le palanghe de prua
quando araene cu’ la maretta, perché ccì Pacchió era un maestro per
capì quando riàa la valìa (ala?) bona. Perché se ‘ndài
in marina cu’ la lancetta, eri lestu dopu!
Era
anche pesce di sciabica quello sistemato sui cariòli delle
pescivendole che andavano a venderlo in paese o lo esportavano nelle
località vicine. Il 17 maggio 1901 si celebrò di fronte al regio pretore
di Recanati il processo contro …Giri Francesca fu Vincenzo di anni
37, Flamini Vincenza fu Antonio d’anni 66, Bronzini Maria-Caterina di
Nazzareno, d’anni 21, tutte pescivendole di Porto Recanati, imputate le
prime due d’ingiurie ai sensi dell’art. 395 cap. 1° C.P. per avere in
Porto Recanati il giorno 2 aprile 1901, pubblicamente ed in sua presenza
offeso la riputazione di Bronzini Caterina con le parole ‘puttana,
puzzona e simili’. La terza –a) di minaccie (sic) ai sensi
dell’art. 156 C.P. per aver minacciato Flamini Vincenza con un bastone
in mano col quale voleva percuoterla, reato commesso il giorno 2 aprile
1901 a Montefano; -b) d’ingiurie ai sensi dell’art. 395 cap. 1° C.P.
per avere ingiuriato nelle circostanze di tempo e luogo pubblicamente ed
in sua presenza offeso la riputazione di Giri Francesca con le parole di
avere fatto la spia al daziere Mattioli Pacifico di Montefano acciocché
questi avesse fatto la contravvenzione alla Bronzini Caterina perché
diceva che aveva del baccalà senza daziare. Le tre si risolsero infine a rimettere le rispettive querele, di modo che il pretore sentenziò non esserci più luogo a procedere, condannando però le donne al pagamento delle spese processuali (Il documento è tra le carte del CSP).
|
|
Consegnamo
questa ricerca ai portorecanatesi, che della sciabica hanno fatto
l’esperienza diretta o che l’hanno soltanto vista in azione o, e qui
ci riferiamo ai più giovani, ne hanno solo sentito parlare (e forse
nemmeno quello).
Lo
abbiamo già scritto in qualcuna delle pagine precedenti e qui vogliamo
ribadirlo: fuori dagli stereotipi che tanto piacciono a certi neofiti
della ricerca storica, il cui lavoro è quasi sempre fonte di confusione
perché sorretto solo da un dilettantismo ricco di presunzione, resta che
la vicenda secolare degli “sciabbegotti” è uno specchio importante
della storia della nostra comunità. È
con questa convinzione che abbiamo lavorato per fornire anche su questo
tema un punto di riferimento a chi vorrà interessarsene in futuro. |
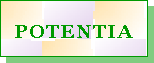 |
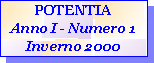 |
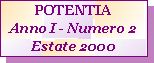 |
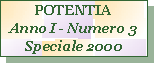 |
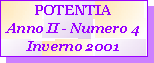 |
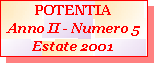 |
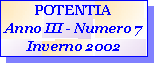 |
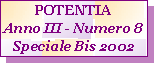 |
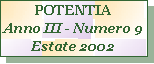 |
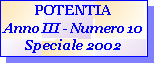 |
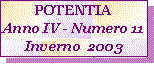 |
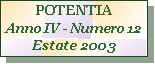 |
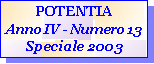 |
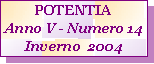 |
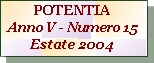 |
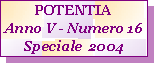 |
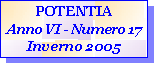 |
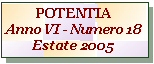 |
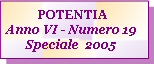 |
|